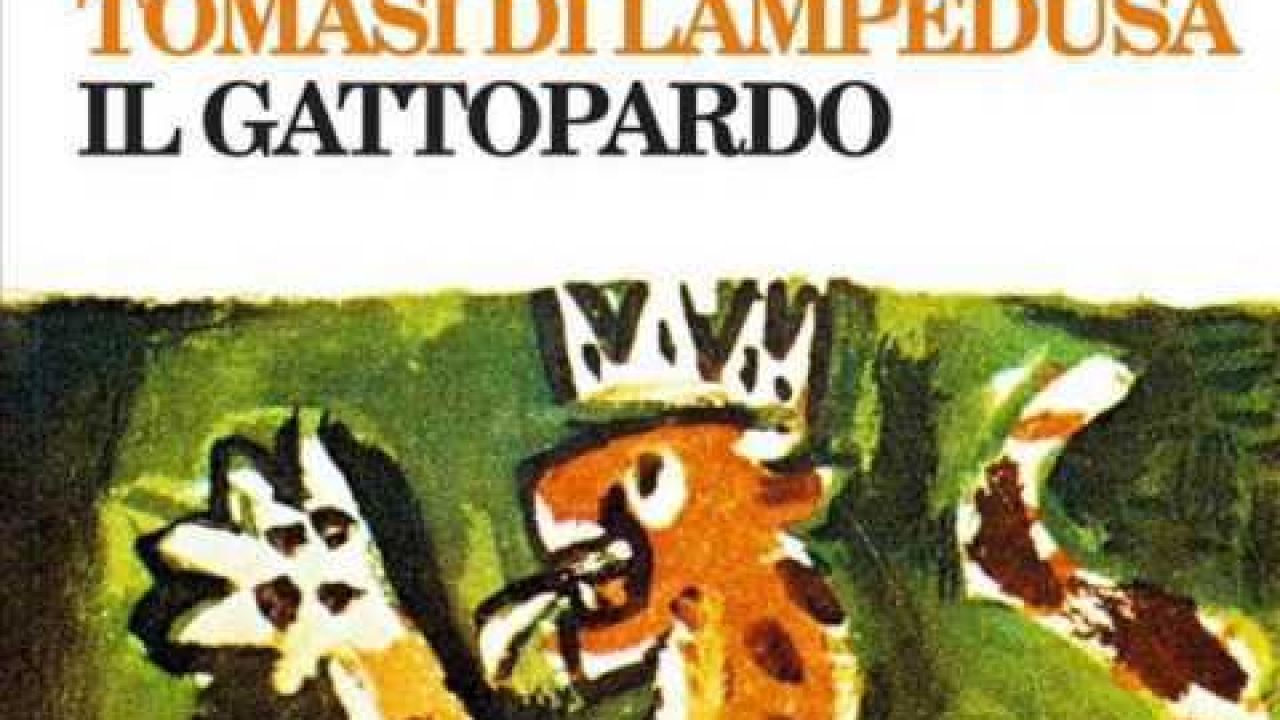
Il Racconto del potere “Il Gattopardo”
Scritto da Danilo Pette il . Pubblicato in Attualità.
Dal romanzo di Lampedusa al film di Visconti fino alla serie Netflix un viaggio tra linguaggi, epoche e della Sicilia, i personaggi e la storia d’Italia si riflettono nei cambiamenti.È un archetipo, un dispositivo narrativo attraverso cui l’Italia guarda a sé stessa ogni volta che prova a raccontare il potere, il cambiamento e la memoria. Quella è Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Pubblicato postumo nel 1958 da Feltrinelli dopo il rifiuto di Elio Vittorini, è oggi un classico indiscusso, tradotto in tutto il mondo e studiato come simbolo della transizione italiana dal potere aristocratico a quello borghese. La sua fortuna però non si limita alla pagina scritta: è diventato film nel 1963 grazie a Luchino Visconti e ora, nel 2025, si trasforma ancora una volta in serie televisiva con la produzione Netflix. Un viaggio lungo e stratificato che testimonia non solo la potenza del racconto originale, ma anche l’evoluzione delle forme espressive che lo hanno reinterpretato.
Il romanzo è un capolavoro letterario e insieme una mappa esistenziale: ha la struttura di una partitura musicale, in cui i temi principali—la morte, il potere, il tempo—si intrecciano in un crescendo malinconico che si stempera nel silenzio finale. Don Fabrizio Corbera, principe di Salina, è al centro di questo universo, figura tragica e contemplativa, consapevole che il suo mondo sta finendo. La scrittura di Lampedusa è densa, ricca di immagini sensoriali, ma anche ironica, disillusa, intrisa di una sicilianità che è visione del mondo più che colore locale. I personaggi, pur nella loro apparente immobilità, si muovono su una scacchiera esistenziale: Tancredi, l’arrivista affascinante; Angelica, la bellezza borghese che sa giocare le sue carte; Concetta, la figlia fedele ma dimenticata, silenziosa custode di un’eredità morale.
Il film di Visconti traduce questo universo in una grandiosa elegia visiva. Luchino Visconti, lui stesso aristocratico, sente profondamente il dolore del tramonto che attraversa il romanzo. Lo traduce con mezzi spettacolari: le luci naturali che scolpiscono i volti, i costumi che parlano quanto i dialoghi, le scenografie che diventano personaggi. Burt Lancaster è un Don Fabrizio più fisico, meno filosofico, ma ugualmente maestoso. Il ballo al Palazzo Gangi, lungo oltre 40 minuti, è forse la sequenza più celebre della cinematografia italiana: un’opera d’arte che vive di silenzi, passi, sguardi. Claudia Cardinale incarna Angelica come una musa sensuale e ambigua, mentre Alain Delon regala a Tancredi una leggerezza cinica che lascia il segno.
Ma Visconti fa anche delle scelte drastiche. Taglia l’ultima parte del romanzo, quella ambientata nel 1910, dove Concetta ormai anziana riflette sul passato e sulla morte. Il film finisce con la dissolvenza del ballo e con l’incedere solenne di Don Fabrizio verso l’inevitabile. È una scelta simbolica: non interessa più il futuro, ma la bellezza della fine. La musica, composta da Nino Rota e Piero Piccioni, è parte integrante della narrazione, tessendo un velo sonoro fatto di nostalgia, eleganza e tragedia. Visconti costruisce un mausoleo della memoria, una pellicola che celebra la morte con l’estetica del sublime.
La serie Netflix del 2025 sceglie invece una via molto diversa. Si inserisce nel solco della serialità contemporanea, ma cerca di non cadere nella trappola del mero intrattenimento. Sei episodi, ognuno con un focus tematico preciso, raccontano la storia da più punti di vista. Il personaggio di Concetta emerge prepotentemente, assumendo un ruolo centrale. Interpretata da Benedetta Porcaroli, non è più solo la figlia silenziosa e rassegnata, ma una figura viva, in conflitto, che cerca una propria voce in un mondo che la ignora. Il suo rapporto con il padre, con Angelica, con Tancredi è finalmente esplorato nella sua complessità.
Anche Angelica, impersonata da Deva Cassel, abbandona il ruolo passivo per diventare un’agente del cambiamento: investe, trama, seduce con consapevolezza. È l’incarnazione di una nuova femminilità, non più oggetto ma soggetto del desiderio e del potere. Don Fabrizio, con Kim Rossi Stuart, viene umanizzato: non è più solo il monumento al passato, ma un uomo ferito, attraversato dal dubbio. Le sue notti di solitudine, le sue riflessioni interiori, i momenti di tenerezza con Concetta lo rendono più vicino allo spettatore contemporaneo.
La musica, firmata da Paolo Buonvino, non cerca di imitare Rota, ma propone un’alternanza tra elementi classici e contemporanei: archi e pianoforte si mescolano con sonorità elettroniche leggere, costruendo una colonna sonora che accompagna senza sopraffare. La regia, divisa tra Tom Shankland, Laura Luchetti e Giuseppe Capotondi, sfrutta droni, piani sequenza, primi piani strettissimi per entrare nell’intimità dei personaggi. Le inquadrature di Palermo, dei campi bruciati dal sole, delle ville in rovina diventano paesaggio mentale, riflesso dello smarrimento dei protagonisti.
Un elemento interessante della serie è il colore: se nel romanzo Angelica indossava rosa e nel film di Visconti dominava il bianco, qui il rosso diventa simbolo. Rosso come passione, potere, sangue. Il ballo, ancora una volta snodo centrale, è reinterpretato con nuovi codici visivi: meno lungo, più dinamico, scandito da contrasti e tensioni. Anche la figura di Tancredi, interpretato da Saul Nanni, acquista nuove sfumature: non è più solo il bell’affascinante, ma un giovane cinico, che sa cosa sacrificare per ottenere un posto nel nuovo mondo.
La struttura della serie permette anche l’emersione di personaggi secondari, come le sorelle di Don Fabrizio, il parroco, i servitori, che diventano voci di un coro sociale più ampio. Il tempo è dilatato, ma non per rallentare: serve a scavare. Ogni episodio ha un titolo simbolico, una parola chiave – “Decadenza”, “Desiderio”, “Memoria” – che orienta lo sguardo. La serialità contemporanea permette questo: non solo raccontare, ma creare ambienti, sfumature, livelli.
Ma non tutto è apprezzato. Le critiche non mancano: alcuni lamentano una certa patinatura delle immagini, un’estetica troppo pubblicitaria; altri notano forzature linguistiche, dialetti approssimativi, casting non sempre coerente con l’ambientazione siciliana. C’è chi parla di “Gattopardo soap”, chi ne critica il ritmo lento, chi accusa la serie di opportunismo culturale. Ma d’altra parte, anche il romanzo fu rifiutato in prima istanza, e il film fu accusato di essere reazionario.
Ogni adattaménto dell’opera “Il Gattopardo” risponde al proprio tempo. Lampedusa scriveva in un’Italia post-bellica, ancora traumatizzata dal fascismo, dove il senso del passato era urgente. Visconti girava in un’epoca in cui il cinema italiano cercava una propria identità internazionale, tra neorealismo e grande affresco storico. Netflix produce in un’epoca di frammentazione, di ricerca di nuove narrazioni, di attenzione ai personaggi femminili, alla diversità dei punti di vista, alla possibilità di costruire un universo narrativo che dialoghi con generazioni diverse.
Il confronto tra le tre versioni può anche essere quantificato. Il romanzo ha circa 150 pagine, scritte con densità stilistica; il film dura quasi tre ore, con un montaggio rigoroso; la serie si estende per sei ore, con spazio per linee narrative multiple. Tematicamente, il romanzo indaga il tempo, la morte, il potere; il film sublima la bellezza della fine; la serie enfatizza l’identità, il genere, la trasformazione sociale. Dal punto di vista visivo, passiamo dalla parola immaginativa del romanzo alla coreografia visiva del film, fino all’estetica mobile, quasi liquida, della serie.
Anche la musica cambia: nel libro è evocata, nei silenzi dei salotti, nei suoni delle cicale; nel film è sinfonica, barocca, orchestrale; nella serie è più ibrida, contemporanea, più psicologica. Le case, i corpi, i vestiti parlano in modo diverso. I costumi raccontano l’evoluzione del ruolo delle donne: da angeliche presenze a protagoniste, da cornici a voci. E anche la fotografia evolve: dall’immaginazione letteraria, al rigore pittorico di Visconti, alla tavolozza digitale e saturata della serie.
Il successo di ogni versione dipende anche dal suo pubblico. Il romanzo è per chi ama la lettura lenta, la riflessione storica, la finezza dello stile. Il film è per chi cerca la bellezza formale, la monumentalità, la regia d’autore. La serie è per chi desidera empatia, protagonismo femminile, serialità narrativa. Nessuna versione è definitiva: tutte sono varianti di uno stesso mito.
Oggi, nel 2025, parlare ancora de Il Gattopardo non è un gesto nostalgico, ma politico. In un’Italia in cui il potere cambia nome ma non volto, in cui i riti si ripetono con nuovi abiti, il messaggio di Tancredi resta attuale: tutto deve cambiare perché tutto resti com’è. Ma forse, come suggerisce la serie, c’è anche un’altra via: quella di chi rifiuta il silenzio, come Concetta. Di chi non accetta di essere spettatore della storia, ma cerca di riscriverla.
Il Gattopardo oggi è un prisma. Ogni angolazione rivela qualcosa: il lusso e la rovina, la tenerezza e il calcolo, la Sicilia e l’Italia, il passato e il presente. È un organismo narrativo che non smette di generare domande: su chi racconta, su chi ascolta, su cosa significa davvero cambiare. La serie Netflix, nel suo tentativo coraggioso, non offre risposte definitive. Ma rilancia il romanzo nella contemporaneità, chiede di rileggerlo con altri occhi. E in questo gesto, c’è forse il senso più autentico della letteratura, del cinema, della serialità: non dire tutto, ma far nascere il desiderio di capire di più.
©Danilo Pette


















