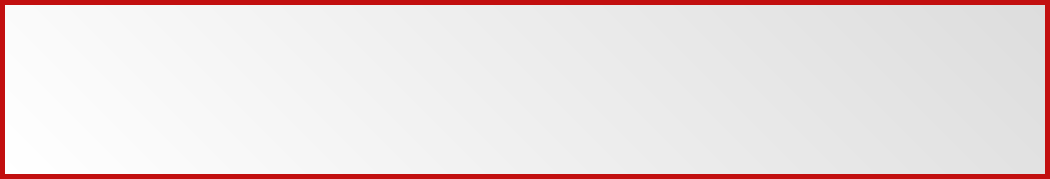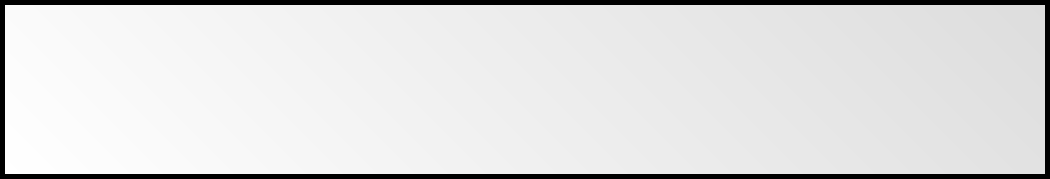La Memoria che Ruggisce The Who al Firenze Rocks 2023
Scritto da Davide Mengarelli il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro, Attualità.
a cura Davide Mengarelli
Sessant’anni di storia del rock scorrono in una notte magica alla Visarno Arena, tra rivoluzione sinfonica, poesia elettrica e coscienza civile
Il rituale collettivo della resistenza sonora
Sabato 17 giugno 2023. L’aria fiorentina è appesantita dal caldo estivo, ma la tensione nell’atmosfera testimonia che la Visarno Arena si trasforma in un altare laico: quello della memoria rock. Le casse già rimbombano, eppure è avvertibile un altro ritmo, quello dei cuori che battono all’unisono. Il pubblico arriva senza fretta, come chi si appresta a ritrovare una parte di sé smarrita—muschio e pelle vissuta invecchiata insieme ai volti segnati dal tempo; tre generazioni diverse si agitano nello stesso spazio, collegate da un unico battito silenzioso. Ci sono rughe e smartphone, pacchetti di sigarette consumati e tatuaggi che raccontano identità, mentre i trentenni spiegano ai figli l’importanza di respirare questa storia dal vivo.
Quattro anni dopo l’ultima apparizione, The Who sale sul palco in un momento che va oltre la musica: un testamento etico, politico e artistico. Sullo sfondo, un’altra presenza imponente – l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Keith Levenson – con novanta musicisti pronti a ribaltare la percezione del rock. È questo il rischio: eppure, già nei minuti precedenti l’ingresso della band, la domanda s’insinua: “il rock può ancora smuovere, scuotere le coscienze, in un’epoca annichilita dal rumore e dal flusso continuo dell’intrattenimento?”
Tom Morello e l’urlo della coscienza
Prima del rito, l’officiante. Tom Morello – ex chitarra elettrica dei Rage Against the Machine – apre la serata con l’intento di scardinare la normalità. Indossa la sua chitarra con la scritta “Arm the homeless”: manifesto politico che non si nasconde in slogan, ma si fa battito e promessa. Il palco, già saturo di aspettative, viene scosso dal suo first strike: il riff tagliente di “Voodoo Child”, omaggio al maestro Hendrix, penetra come una scarica elettrica nello stomaco del pubblico. Neanche il tempo di assimilare, ed eccolo lacerare l’atmosfera con uno sguardo ironico: “Gossip”, cornice inattesa sul repertorio dei Måneskin, tutela un aggiornamento generazionale. Suona come un inno alla giovinezza, a una protesta non codificata ma pulsante.
Ma è con “Killing in the Name” (Rage Again the Machine, 1992) che la risposta esplode: urla collettive Fuck you, I won’t do what you tell me diventano una preghiera ribelle sotto le stelle. L’eco arriva lontano, mentre Morello non si limita a suonare: incide, graffia, smussa. Come un chirurgo della tensione pubblica, preme ogni corda, affondando in una carne viva che pulsa su un presente sordo e indifferente. È un’azione antica e bruciante: il rock come resistenza è tornato, nonostante tutto, qui e adesso.
Una platea senza età
Alle 21:30, le luci si abbassano: scatta l’ora della sacralità laica. Nessuna divisione generazionale, nessuna barriera tra passato e presente: anziani con le magliette consumate della prima ora, giovani che non hanno conosciuto Keith Moon ma lo sentono ancora battere nella cassa. Amalgama che travalica il tempo, perché qui – come in altre grandi occasioni della musica – si fa comunità.
La presenza fisica di Pete Townshend, che mulina ancora il braccio come cinquant’anni fa, e di Roger Daltrey, vorticosamente fisico nel movimento del microfono, crea una presenza ipnotica. Ma è solo quando parte l’Overture di Tommy che la Visarno si trasforma in teatro. Il suono orchestrale incide fronti inattese: archi che respirano, ottoni che spingono, fiati che dipingono geometrie sonore. Non è retorica, non è ombra: è un patto. Tra la band e se stessa, tra l’oggi e il passato.
Tommy l’epopea della rinascita
Il primo atto è dedicato all’opera rock che ridefinì il genere: Tommy (1969). Ma qui, al Firenze Rocks, non si assiste solo a un’esecuzione: si assiste a una trasfigurazione. Il bambino cieco, sordo e muto diventa simbolo universale: di chi sopravvive, di chi, nonostante il silenzio, cerca luce. Ogni nota di “Pinball Wizard” diventa una lama lucente: chitarra, orchestra, voce di Daltrey dialogano senza mediazioni. E poi “See Me, Feel Me, Touch Me, Heal Me” risuona con sembianze di preghiera laica – una liturgia che unisce tutti, senza credi, solo intenzione e suono.
Keith Levenson dirige con rigore chirurgico: le sezioni orchestrali sono collocate con precisione in uno schema narrativo raffinato. Non c’è nostalgia: c’è consapevolezza e cura. La sua bacchetta, con movimenti minuscoli, plasma l’energia di Townshend e Daltrey, fondendola con le masse sonore. Ne esce un’opera sinfonica, contemporanea e immortale: Tommy ricostruito, senza veli, nella sua dimensione più universale.
Rock allo stato puro
Dopo l’estasi orchestrale, si torna allo stato puro: The Who come li abbiamo conosciuti, aggrediti dalla voglia di suonare. Il palco si restringe ma non perde potenza. “I Can See for Miles” è un boomerang psichedelico: anni Sessanta condensati in un’esplosione che ancora ha il potere di inquietare e stordire. “Behind Blue Eyes”, eseguita con delicatezza, diventa intima: violini, violoncelli, voce ferita eppure ferma. Su tutto, lo stomaco di chi ascolta si contrae, e il tempo si arresta.
Il cuore prende quando arriva “Won’t Get Fooled Again”. Quell’incipit ritmico sintetizzato è tensione compressa. Poi la batteria irrompe potente, la chitarra spara fiamme, e Daltrey intona: “I’ll tip my hat to the new constitution”. È grido che ancora risuona oggi: sdogana, sconvolge, riaccende. L’arena vibra, l’aria frizzante si innalza. E Firenze urla, partecipando, come se si trattasse di una terapia collettiva.
Una band ancora in marcia
Il dramma della band viene da lontano: scomparsi Keith Moon (1978) e John Entwistle (2002), i cuori pulsanti originali. Eppure, stasera non c’è nostalgia vuota: al loro posto Simon Townshend (chitarra), Jon Button (basso) e Loren Gold (tastiere). E soprattutto Zak Starkey alla batteria: figlio di Ringo Starr, ma figlio spirituale di Moon. Urla, scava, respira con fede nei geni musicali del gruppo. Lo si percepisce ad ogni colpo: lo fa in ricordo, ma senza copiare.
La sezione è compatta, orchestrale, tesa al’identità viva del gruppo. Nessuna recriminazione, nessun museo. Gli Who avanzano con piglio deciso: suonano come se fosse la prima volta e come se il mondo avesse ancora bisogno del loro urlare.
Quadrophenia l’oceano interiore
Il terzo atto è riservato a Quadrophenia (1973): non un sequel, ma un altro mondo. Qui, la rabbia e la fragilità conversano in uno spazio creativo che rispecchia l’adolescenza fragile e confusa. Le immagini sullo schermo – mare agitato, strade londinesi, volti smarriti – danno profondità a note che nascono da un vissuto generazionale.
Quando arriva “Love, Reign o’er Me”, tutto esplode come un’epifania spirituale. La voce di Daltrey, tesa verso l’alto, smuove l’aria. L’orchestra accompagna in un respiro che va oltre la definizione: è ombra e luce, sacro profano, distorsione e preghiera. Snapchat, distrazioni, smartphone – tutto è bandito per un momento. Solo un letto di suono che ti avvolge e ti libera.
Il rock è (ancora) politica
Ma la serata non è solo musica: è dichiarazione. Una sequenza di immagini poderosa scorre su videowall: guerra in Vietnam, proteste civili, scene dall’Ucraina, corpi attraversati da migrazioni, volti che scrutano l’orizzonte. Non sono fotografie decorative: sono moniti. Contrappunti visivi alla musica, per ribadire che The Who non rappresentano intrattenimento fine a se stesso. Hanno suonato Tommy e Quadrophenia per responsabilità civica: suonano per ricordare che ogni rivoluzione, ogni rinascita, nasce da corpi e coscienze allertati.
In un’epoca di distrazioni, i due ultrasettantenni sul palco ribadiscono che il rock è linguaggio di critica e consapevolezza. Non c’è fuga: c’è presenza, urgenza, etica. E la sinfonia delle idee, mescolata al suono potente, suona come una corsa fino al limite dell’attenzione.
L’addio che resta
La conclusione si fa preziosa: “Baba O’Riley”. Battito sintetico iniziale, come un cuore che batte sotto pelle. Poi, l’orchestra accende un fuoco fatuo di archi e fiati. Il vibrato finale, affidato al violino solista Katie Jacoby – prima parte dell’Orchestra –, si avverte come un duello tra due anime musicali. Non è rock orchestrale: è un matrimonio emozionale, una scintilla. Il pubblico non canta soltanto: accompagna la partitura di un rito laico, un abbraccio che sa di promesse.
Non ci sono bis. Non servono. Quello che conta è già stato strappato dalla notte. Daltrey si commuove, Townshend sorride quasi incredulo. Si staglia una silenziosa riflessione tra il cordone umano: non serve applaudire. Il suono ha già detto la sua. E la notte può scendere su Firenze.
Il tempo non esiste
The Who, nel 2023, non sono reliquie. Non sono un monumento. Sono una voce vibrante, scolpita dalla saggezza e dalla resistenza. Hanno scelto di restare vivi, di non ricadere nello stereotipo del rocker nostalgico. Tommy e Quadrophenia sono monoliti contemporanei: portano la storia in direzioni ignote, senza imitare né ripetere. Il segreto è nella scelta: suonare con coraggio, nonostante gli anni.
Chi era alla Visarno Arena lo ha visto: due uomini ultrasettantenni che si muovono con la stessa energia cercata nei loro vent’anni. Sopra di loro, novanta orchestrali hanno donato ossa sonore, carezze, spigoli. Hanno acceso lampeggiamenti sonori mai visti prima. Hanno consegnato [alle] loro storie un nuovo alveare di sensi. E chi c’era – ascoltatori, spettatori, semplici abitanti della sala all’aperto – ha capito che la memoria non è peso, ma potenza. Non è catena, ma canto. Un canto necessario.