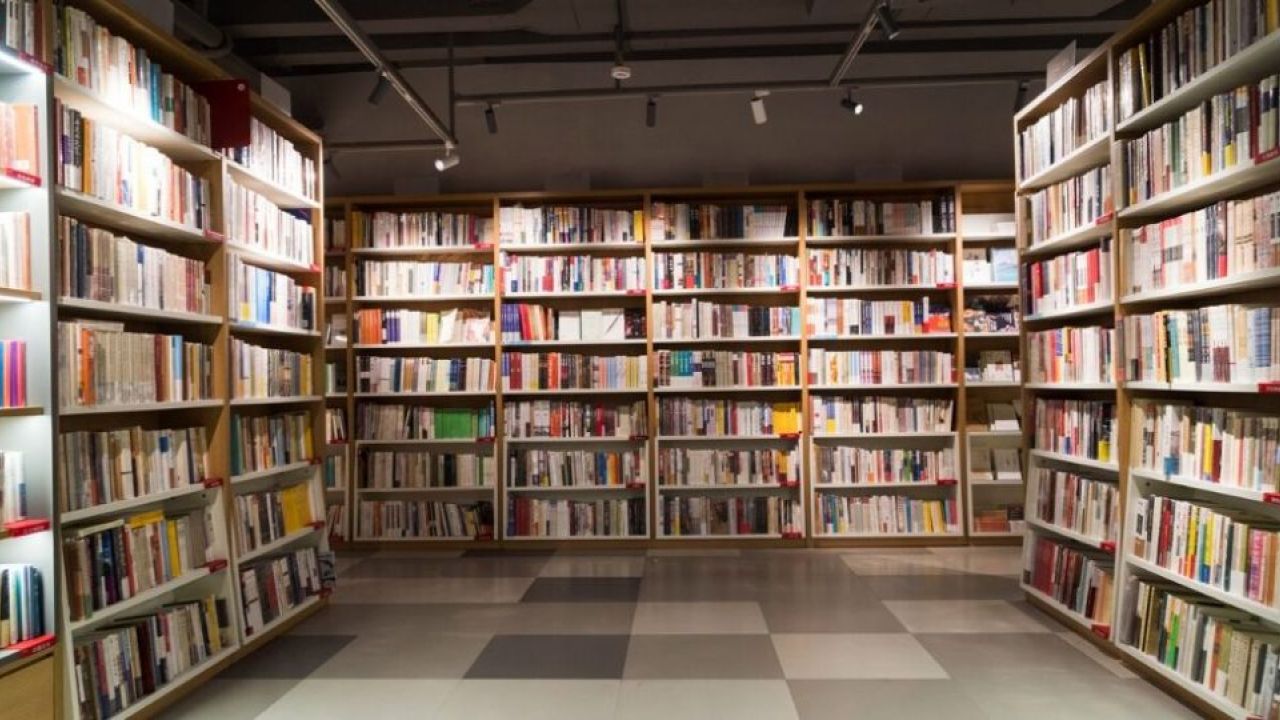
Il Prezzo dell’Oblio
Scritto da Ottavia Scorpati il . Pubblicato in Attualità.
Nel vortice delle leggi di bilancio, tra cifre, percentuali e rinvii, si nasconde un dramma che non si legge sulle prime pagine dei giornali, non fa clamore nei talk show, eppure è una ferita aperta, profonda e destinata a sanguinare nel tempo: il taglio alle risorse destinate alla cultura. Più precisamente, quel taglio che colpisce i beni librari, gli archivi e le biblioteche, pilastri fragili ma imprescindibili di una società che vuole davvero chiamarsi civile.Nel 2025, la legge di bilancio ha sancito una drastica riduzione di fondi: meno dieci milioni di euro per la Fondazione del Libro, quasi dieci milioni in meno per gli archivi, centinaia di milioni tolti alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico. Cifre che da sole potrebbero sembrare numeri da bilancio pubblico, semplici annotazioni su fogli contabili. Ma dietro quei numeri si nasconde molto di più. C’è un prezzo che non si calcola in euro, ma nel disfacimento di un tessuto culturale, nella perdita di un’identità collettiva e nel depauperamento di una coscienza critica che rischia di smarrirsi definitivamente.
Chi, nei palazzi del potere, decide di sottrarre risorse alla cultura per destinarle ad armamenti, sussidi elettorali o riforme discutibili, sembra aver smarrito il senso più profondo di cosa significhi investire in un Paese. Perché tagliare i fondi significa non solo chiudere biblioteche o limitare l’accesso ai libri, ma significa soprattutto amputare la memoria collettiva di una nazione, significa soffocare la possibilità di pensiero critico, di immaginazione e di confronto con la propria storia. È una scelta politica che ha conseguenze sociali e morali devastanti.
Dietro quei numeri, infatti, ci sono bibliotecari e archivisti che provano a mantenere aperti spazi con scaffali impolverati, cataloghi non aggiornati, edifici spesso fatiscenti. Ci sono restauratori che lottano contro il degrado inesorabile di affreschi, monumenti e opere d’arte, ma che non possono farlo per mancanza di fondi. Ci sono operatori culturali che ogni giorno cercano di tenere accesa la fiamma della conoscenza, di offrire alle comunità un luogo di incontro e di crescita, e che si trovano di fronte a una burocrazia che non crede più nella cultura come leva di sviluppo.
Tagliare i fondi significa condannare tutto questo all’abbandono, significa lasciare alla polvere e all’oblio ciò che rappresenta la nostra storia, la nostra identità. Significa privare intere generazioni della possibilità di incontrare la cultura in modo libero e democratico, di formare cittadini consapevoli e dotati di spirito critico. E tutto questo accade non per mancanza di risorse, ma per scelte di priorità distorte, per miopia culturale e per una visione miope che vede nella cultura solo un costo e non un investimento.
Questa crisi non è soltanto economica o gestionale. È soprattutto culturale e morale. Perché un Paese che decide di amputarsi la memoria, che rinuncia a investire nella cultura, sceglie di vivere nell’effimero, nell’immediato, nel rumore di notizie che durano il tempo di un click e si perdono nel flusso incessante delle distrazioni digitali. È un Paese che rifiuta la propria storia, che abdica al proprio futuro, che perde la propria dignità.
Eppure, questo stesso Paese ha in dote il più grande patrimonio culturale del mondo. Un’eredità inestimabile che dovrebbe essere motivo di orgoglio, custodia e cura, non un peso da tagliare. Antonio Gramsci scriveva dal carcere che “istruire è difficile, ma governare un popolo ignorante è più facile.” Parole che dovrebbero echeggiare forti nei corridoi di chi prende decisioni cruciali, perché dietro ogni taglio alla cultura c’è la volontà – forse inconsapevole – di rendere più facile il governo attraverso un popolo meno informato, meno critico, più manovrabile.
Pasolini, con la sua sensibilità acuta, aveva già colto il pericolo di una società che perde la memoria, incapace di parlare con le proprie radici e con la propria storia. Non si tratta di un lusso riservato a pochi eletti, ma di un diritto fondamentale, di un patrimonio collettivo che plasma il presente e costruisce il futuro.
Oggi, la riduzione dei fondi significa lasciare indietro chi lavora ogni giorno in biblioteche, archivi e musei. Significa abbandonare un settore già fragile, messo a dura prova da decenni di tagli progressivi e scelte sbagliate. Non è una questione di scarsità di risorse, ma di scarsa volontà politica, di una miopia culturale che rischia di avere conseguenze irreparabili.
Mentre i governi non esitano a investire miliardi in spese militari, in riforme spesso inefficaci o in incentivi di breve respiro, è paradossale e inquietante vedere come la cultura – quell’elemento che forma cittadini consapevoli, capaci di critica e partecipazione – venga trattata come un costo da ridurre. Non è una questione economica, ma di priorità: si sceglie di rinunciare a ciò che fa di una società una comunità viva e proiettata nel futuro, per inseguire un presente privo di prospettive.
L’erosione delle risorse destinate a biblioteche, archivi e tutela del patrimonio è una ferita che si allarga, una frattura che rischia di spezzare definitivamente il legame tra passato e futuro. Ogni libro non acquistato, ogni archivio chiuso, ogni restauro rimandato è un pezzo di memoria che si perde, un tassello di identità che si sgretola. E quando la memoria si perde, si perde anche la capacità di costruire una società più giusta, più consapevole, più libera.
Il vero prezzo che paghiamo, dunque, non è solo l’abbandono materiale di luoghi e beni culturali, ma la rinuncia a coltivare una coscienza critica, a formare cittadini in grado di leggere e interpretare il mondo, a costruire un futuro che non sia solo un presente perpetuo e disorientato. È una sconfitta morale prima ancora che economica, una resa davanti alla sfida della complessità, della conoscenza e della responsabilità.
Il Paese che taglia i libri è un Paese che si priva della propria anima. Rinuncia a sognare, a interrogarsi, a crescere. Preferisce l’oscurità del silenzio alla luce della riflessione. E in quel silenzio, in quelle biblioteche vuote, in quegli archivi chiusi, si consuma un lento e inesorabile disastro: la dissoluzione di ciò che eravamo, la perdita di ciò che potremmo diventare.
Il futuro non si costruisce con slogan o inaugurazioni di facciata, ma con scelte concrete, coraggiose e coerenti. Con investimenti veri nella formazione, nella ricerca, nella conservazione del patrimonio culturale. Con una politica che metta al centro la cultura non come costo, ma come investimento, fondamento di uno sviluppo autentico e duraturo.
È ora di riconoscere che la cultura è infrastruttura civile. Custodire la memoria è il primo passo per costruire una società più giusta, più libera. È ora di smettere di tagliare e iniziare a investire davvero in quel patrimonio immenso che abbiamo, per non condannarci a un presente senza radici né futuro. Perché ogni libro perso, ogni archivio abbandonato, è una ferita che colpisce tutti noi. E la memoria, quella vera, è la sola ricchezza che nessuno potrà mai portarci via.
Un Paese che taglia i libri non è un Paese povero, ma un Paese che si rifiuta di vedere. La legge di bilancio 2025 è una fotografia impietosa, letta dalla newsletter Pubblico della Fondazione Feltrinelli, che ha analizzato numeri e voci di spesa con rigore. Meno 10 milioni di euro per beni librari e la Fondazione del Libro, meno 9,4 milioni per i beni archivistici, meno 424,9 milioni per il patrimonio culturale, meno 485,8 milioni per la tutela dei beni e delle attività culturali e paesaggistiche. Tradotto in termini concreti: meno biblioteche, meno archivi, meno restauri, meno cultura per tutti.
Vergogna. Non esiste altra parola. Perché un Paese che taglia sulla cultura non è un Paese povero di risorse, ma un Paese povero di ambizione, di visione, di rispetto per sé stesso. È un Paese che ha deciso di amputarsi la memoria per vivere nell’eterno presente, dove ogni notizia dura ventiquattro ore e ogni indignazione evapora al tramonto, dove la riflessione è stata sostituita dall’immediatezza e dall’indifferenza.
Chi ritiene che si tratti di “spese superflue” dovrebbe provare, almeno una volta, a guardare negli occhi un bibliotecario di provincia che cerca di tenere aperta una sala lettura con scaffali fermi agli anni ’90. Dovrebbe ascoltare il racconto di un restauratore che combatte contro l’umidità che lentamente consuma un affresco del Quattrocento. Dovrebbe visitare un archivio dove un climatizzatore rotto permette la formazione di muffe che minacciano documenti unici, preziosi e irrinunciabili.
La cultura è molto di più di libri e monumenti. È case editrici indipendenti che pubblicano autori esordienti. È festival che portano scrittori nei piccoli centri. È bambini che toccano per la prima volta un libro, ragazzi che in una biblioteca comunale scoprono un romanzo che cambierà la loro vita. È memoria viva, passaggio di sapere, confronto e crescita. Tagliare qui non è un’operazione contabile: è una dichiarazione politica, è dire nero su bianco che la conoscenza non è prioritaria.
Ogni dittatura, ogni forma di potere autoritario, inizia bruciando o censurando libri. Ogni società in declino smette di trasmettere ai giovani ciò che ha imparato, preferendo il rumore alla riflessione. Antonio Gramsci, dal carcere, aveva colto questo pericolo e lo aveva indicato con chiarezza: “istruire è difficile, ma governare un popolo ignorante è più facile.”
Pasolini, dall’altra parte, osservava nelle nuove periferie e nei nuovi palazzi una perdita di senso, una rottura con la storia e con le radici. E il paradosso più inquietante è che questo accade in un Paese che detiene il più grande patrimonio artistico e culturale del mondo, con città che sono musei a cielo aperto, biblioteche custodi di incunaboli unici, archivi che raccontano mille anni di storia.
Eppure, invece di custodirli e valorizzarli, li lasciamo cadere a pezzi.
Non è miseria economica, è miseria morale. La tragedia è che i governi che tagliano i fondi alla cultura non esitano a spendere miliardi per armamenti, riforme inefficaci o mance elettorali. Questa contraddizione è sconcertante, indicativa di una miseria morale che si fa politica economica.
Mi chiedo – e chiedo a chi ci governa – se abbiano mai provato la sensazione di aprire un libro raro, di sentire l’odore della carta che ha attraversato i secoli. Se abbiano mai provato il silenzio vibrante di un archivio storico. Se abbiano mai capito che un affresco restaurato non è solo pittura, ma un pezzo di identità collettiva.
La cultura non è un lusso da salotto. È infrastruttura civile. È ciò che impedisce a una comunità di diventare massa informe, è ciò che dà senso al concetto stesso di Paese. Senza cultura, siamo solo un mercato di consumatori, pronti a essere intrattenuti ma incapaci di essere cittadini.
Oggi si tolgono dieci milioni alle biblioteche. Domani potremmo non accorgerci che ci hanno tolto le parole per raccontare chi siamo stati.
E allora resteremo qui, in piazze silenziose, sotto statue che guardano lontano ma che nessuno sa più nominare. Le librerie chiuse avranno vetrine impolverate come occhi spenti; gli archivi saranno stanze vuote dove l’eco dei passi suonerà più forte delle storie perdute. E in quel silenzio, scopriremo che a mancare non saranno solo i libri, ma noi stessi.
La cultura non è un “extra” da tagliare nei momenti di crisi. È la linfa vitale di una democrazia, il terreno fertile su cui crescono le idee, la partecipazione e la giustizia sociale. Quando si decide di sottrarre risorse a biblioteche, archivi, musei, non si tratta solo di ridurre spese, ma di mettere in discussione la capacità stessa di un Paese di essere libero e consapevole.
Ogni libro acquistato, ogni archivio mantenuto, ogni restauro realizzato è un investimento non solo nella memoria, ma nel futuro. È la certezza che il domani sarà costruito su fondamenta solide, su una coscienza critica e una conoscenza condivisa.
Per questo, occorre un cambio di paradigma che metta al centro la cultura come priorità strategica. Non più una spesa da comprimere, ma una risorsa da valorizzare e proteggere. Non più un peso, ma un investimento su cui costruire la società del futuro.
È necessario rivedere le politiche di bilancio, ascoltare chi quotidianamente lavora nei luoghi della cultura, coinvolgere le comunità, sostenere l’editoria indipendente, promuovere la formazione e la ricerca. Solo così si potrà davvero invertire la rotta di un Paese che oggi sembra correre verso il baratro dell’oblio.
La cultura non è solo un bene da conservare, ma un volano di sviluppo economico, sociale e ambientale. Le città d’arte, i musei, le biblioteche attraggono turisti, generano lavoro, alimentano un indotto importante. Ma tutto questo richiede cura, manutenzione, investimenti continui.
Tagliare fondi alla tutela del patrimonio significa mettere a rischio questo motore economico, compromettendo non solo l’identità culturale ma anche la capacità di creare ricchezza e occupazione. È una scelta miope che si ritorce contro il Paese stesso.
La cultura non può essere lasciata solo nelle mani dello Stato. Serve un impegno collettivo, una presa di coscienza diffusa che riconosca il valore di ciò che si rischia di perdere. Sono necessari cittadini informati e attivi, capaci di chiedere e rivendicare la tutela del patrimonio culturale come diritto fondamentale.
Le associazioni, le fondazioni, i comitati civici, le scuole e le università hanno un ruolo cruciale nel promuovere la conoscenza e la difesa della cultura. Solo un’azione corale potrà invertire la tendenza e restituire dignità e valore a un settore oggi troppo spesso trascurato.
Il lento sgretolamento della memoria collettiva, causato da tagli sistematici e scelte politiche sbagliate, rappresenta una crisi che va ben oltre l’economia. È una crisi di identità, di valori, di speranza. E come tutte le crisi più profonde, chiede di essere affrontata con coraggio, consapevolezza e intelligenza.
Questo non è solo un appello ai governanti, ma a ogni cittadino che vuole un futuro degno di essere vissuto, che desidera una società capace di guardare al domani con radici ben salde nel passato. Perché senza memoria non c’è futuro, senza cultura non c’è civiltà, senza libri non c’è libertà.


















