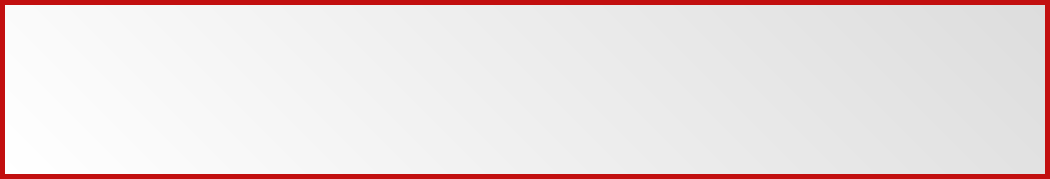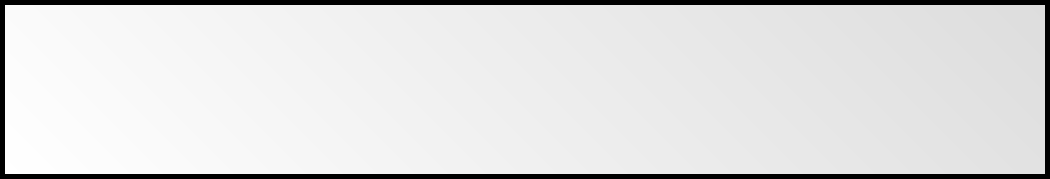Il battito silenzioso di una volpe
Scritto da Danilo Pette il . Pubblicato in Attualità.
Quando la città dorme, basta una piccola vita a risvegliare chi sceglie di fermarsi.
Domenica 8 settembre 2025. Via Ardeatina. Ore 22:35. Una notte che ha già perso memoria del giorno, che mastica le sue ultime luci tra denti d’asfalto e respiri a intermittenza. L’aria è ferma, piena, gonfia come un polmone che non sa se deve inspirare o cedere. E poi — un suono. Né forte né urlato. Un tonfo secco, spoglio. Come una frase senza verbo. Come se qualcosa si fosse staccato dal mondo e fosse caduto nel mezzo, tra la corsia e l’ombra.
Non un’esplosione. Non un urlo. Più simile a uno schiocco di legno bagnato che si spezza. Ma è sufficiente. Per chi lo sente, è sufficiente.
Il rumore rimbalza tra i palazzi senza finestre, si appoggia sul parabrezza di un’auto in corsa. La macchina non si ferma. Rallenta. Una frazione. Poi riprende. Viene inghiottita dal ventre della città, dove nessuno si volta davvero. Dove tutto passa, tutto scorre, tutto si dimentica in tempo utile per il prossimo semaforo.
Resta solo il vuoto, e nel vuoto — qualcosa. Un corpo. Minuscolo. Ancora caldo. Incastrato tra la linea bianca e il bordo del marciapiede. Non grida. Non si agita. Ma respira. Tremolante, sottile, come il battito d’ali di un insetto sotto vetro. È una volpe. Una volpe. Qui. Sull’Ardeatina. Di notte. Fuori luogo. Fuori tempo. Un errore di sintassi nella frase notturna della città. Un dettaglio fuori posto. Eppure reale.
Le luci dei lampioni fanno fatica a starle addosso. La sagoma sfuma ai bordi. È polvere e pelo, è sangue che si dilata piano sotto la pancia. L’asfalto tiene memoria del calore. La città no.
Due fari in lontananza. Un’auto. Piccola. Dentro, due ragazze. Una guida, l’altra guarda il telefono. Le dita che scorrono come se cercassero niente, ma lo cercassero comunque. Addosso ancora l’odore di fritto, di chiuso, di ore passate in piedi dietro a un banco. Camicie stanche, pelle lucida, occhi vuoti. Una notte come tutte, identica alla precedente, forse identica alla successiva. Ma non identica a questa.
Perché una delle due, la passeggera, alza lo sguardo. Un istante. Una frazione di grado nella traiettoria. Basta. La sagoma. Un animale. Forse. Non dicono nulla. Si guardano. Poi la frenata. Secca, istintiva. Il flash delle quattro frecce. La macchina ferma nel mezzo della corsia. Non c’è nessun suono. Nessuna parola. Solo lo sguardo fisso sul corpo in mezzo alla strada. È troppo piccolo per essere un cane. Troppo delicato per essere un gatto. Troppo vero per essere un dubbio.
“È una volpe?” Una voce, quasi un sussurro. L’altra annuisce, appena. Non serve altro.
Il telefono. Di nuovo. Ma ora non scorre per noia. Ora cerca. “Clinica veterinaria aperta ora?” “Roma sud emergenza animali?” “Fauna selvatica soccorso?” Le dita digitano, ma le risposte non arrivano. Caselle vocali. Silenzi. Una voce automatica: “Restare in linea.” Ma nessuno arriva.
Il tempo si fa viscoso. La macchina resta lì, ferma. Il motore ancora acceso, come un cuore che rifiuta di spegnersi. Intorno, le luci delle altre auto che si avvicinano. Rallentano. Alcune passano. Nessuno si ferma. Poi una macchina frena. Una seconda. Una terza. Una coppia scende. Lei ha i capelli raccolti. Occhi nudi. Lui non dice molto. Si avvicina. Si inginocchia. Due dita. Un tocco leggero, come si fa con i neonati o con i feriti. “Respira ancora. Ma è debole.”
Chiede alle ragazze. “Avete chiamato?” Loro annuiscono, frustrate. “Nessuno risponde.” Lui annuisce. Non dice altro. “Chiama il 112,” dice. Non come un ordine, ma come l’unica cosa che resta da fare.
Dalla tasca esce un cellulare diverso. Sporco. Usato. Lo mette all’orecchio. La voce dall’altra parte è calma, impersonale. “Non muovetela. Se potete, mettetela in una scatola. Qualcuno passerà. Forse.” Quelle ultime due parole restano sospese. Forse. Come a dire: fate voi.
Ma non si muovono. Nessuno si muove. Restano tutti lì, intorno al corpo della volpe. L’aria ha smesso di cambiare. È densa. Non c’è più la strada, c’è solo quel cerchio. Quel piccolo spazio dove la realtà ha rallentato.
Una delle ragazze apre Instagram. Istinto. Niente di ragionato. Una storia: il musetto impolverato, gli occhi chiusi. La scritta: Volpe investita. Via Ardeatina. Clinica aperta? Roma sud. Non è un grido. Non è una preghiera. È solo una richiesta nuda. Ma è abbastanza.
Quaranta secondi. Un messaggio. Poi un altro. Una clinica, zona Nomentana. Accettano fauna selvatica. “È lontano.” “Ma ci arriviamo.” “Forse.”
“Come la portiamo?” Nessuno ha scatole. Nessuno ha guanti. Le mani nude. I dubbi anche. Poi una macchina si ferma. Due ragazzi. Occhi larghi. Lei parla. Lui ascolta. “A casa abbiamo una scatola. Torniamo subito.” Numero scambiato. Ripartono.
La città continua. Le auto passano. Alcune osservano. Altre fanno i fari. Nessuno scende. Nessuno domanda. Come se quella scena fosse un cortometraggio che non riguarda. Un animale per terra. Quattro persone ferme. Non è abbastanza. Non è mai abbastanza, in questa città.
Una volante. Due agenti. Rallentano. Osservano. Non scendono. La macchina riparte. Una decisione che dura meno di un secondo. Il dolore non era evidente abbastanza. Il problema non era chiaro. O forse sì, ma troppo scomodo. Nessuno commenta. Ma il silenzio, da quel momento, pesa di più.
Poi una seconda volante. Più piccola. Non lampeggia. Si ferma. Dentro, due agenti giovani. Uno scende. Si avvicina. “Che succede?” Gli spiegano. “Una volpe. Ferita. Aspettiamo una scatola. Poi la portiamo.” L’agente osserva. Il corpo. Le mani. I volti. Annuendo. Resta. Anche l’altro scende. Nessuna divisa. Solo giacche leggere, scarpe consunte. “Abbiamo finito il turno. Stavamo tornando in caserma.”
La coppia della scatola torna. Il ragazzo ha i guanti da giardino. La scatola è una da pacchi. Marrone. Le mani tremano appena. Si inginocchia. Tocca il corpo. “È ancora calda.” La solleva. La depone nella scatola con lentezza chirurgica. Nessuno fiata. La strada sembra trattenere il respiro. La volpe respira ancora. Lentamente. Ma lo fa.
La scatola entra nell’auto. Il ragazzo chiude piano il portellone. Non c’è fretta, ma c’è urgenza. Un paradosso che si muove tra le mani. Nessuna parola. L’aria dentro la macchina è densa, umida, come se anche i sedili respirassero. Le portiere si chiudono. Un clic. Poi il motore.
Partono.
La strada si apre come una ferita. Le altre auto, per una volta, cedono il passo. Nessuno suona. Nessuno lampeggia. È come se qualcosa, invisibile, si fosse dichiarato sacro. E Roma, la città della distrazione, per un istante lo avesse capito. Nessun clacson. Nessuna accelerata rabbiosa. Solo la direzione. Solo la scelta.
L’interno dell’auto è silenzioso. Non c’è musica. Solo il ronzio basso del motore e il respiro irregolare della volpe nella scatola, coperta con un vecchio asciugamano da palestra. La ragazza guida con le mani strette sul volante. Il ragazzo tiene una mano sul bordo della scatola, senza toccare, solo a pochi millimetri. Come per sentire se c’è ancora vita. C’è.
Dietro di loro, la strada si richiude. L’Ardeatina torna a essere traffico e fumo. Le quattro persone rimaste si sciolgono piano, come una nebbia. Le ragazze tornano nella loro auto, ma non ripartono subito. Una apre il telefono. Rivede la storia. I messaggi. Le risposte. Non è un gesto di autocompiacimento. È conferma. È reale. È successo. L’altra le poggia una mano sulla spalla. “Ci stanno scrivendo,” dice. E non serve altro.
La coppia che aveva chiamato per prima resta per un altro po’. Guardano dove la volpe giaceva, dove ora resta solo un alone scuro sull’asfalto. Il vuoto del corpo è una forma precisa. Il uomo mette le mani in tasca. Lei si stringe nella giacca. “Era viva. Ancora viva.” Nessuno aggiunge nulla.
Nel frattempo, l’auto avanza. I cartelli cambiano. Eur. Piramide. Termini. Porta Pia. Poi, Nomentana. Il GPS indica una clinica aperta h24. Si chiama Oasi, ma non c’è niente di poetico nell’insegna. È solo luce fredda, tubo al neon, una porta automatica che si apre a scatti. Parcheggiano male, ma nessuno dice niente. È tardi. È sempre tardi, in questi casi.
La ragazza prende la scatola tra le braccia. Il ragazzo le apre la porta. Dentro, l’odore è disinfettante e tensione. Al bancone, una donna in camice. Li guarda. Guarda la scatola. Capisce.
“Fauna selvatica?” chiede. Non per burocrazia. Per sapere dove portarla.
“Sì,” rispondono. E gliela porgono come fosse una cosa fragile. Lo è. Lei la prende. Guarda dentro. Non sorride. Non fa commenti. “Venite.”
Spariscono oltre una porta grigia. Un secondo. Poi la porta si richiude. Il suono è netto. Come una linea. Come un punto.
La sala d’attesa è vuota. Due sedie. Una pianta finta. Una macchina del caffè spenta. Il ragazzo si siede per primo. Appoggia i gomiti sulle ginocchia. Guarda in basso. Lei resta in piedi per un po’. Poi si siede. Incrocia le braccia. Lo guarda.
“Nessuno ci crederà,” dice. Ma non sorride. Non cerca leggerezza. È solo la constatazione di un mondo che non sa tenere conto di queste cose.
“Non importa,” risponde lui.
Il telefono vibra. La ragazza apre Instagram. Decine di messaggi. Cuori. Domande. “Come sta?” “L’avete salvata?” “Posso donare qualcosa?” Lei non risponde subito. Legge. Scorre. Poi scrive: È in clinica. Non è in shock. Frattura a una zampa. Forse anche al bacino. La tengono in osservazione. Posta. Chiude.
La porta si riapre. La donna in camice li guarda. Nessun sorriso. Ma gli occhi sono morbidi. “Non è in pericolo immediato. È grave, ma stabile. Ha dolore, ma risponde. Serve un po’ di tempo.” Si ferma. Li guarda entrambi. “Chi firma?” “Chi paga?”
Silenzio.
“Per il ricovero. Per la responsabilità legale. Serve un nome.”
I due si guardano. Una pausa. Lui alza le spalle. Lei si alza. “Firmo io.” Prende la penna. Scrive nome e cognome. Data. Firma. Nessun gesto eclatante. Solo inchiostro su carta. Ma basta.
“Grazie,” dice la donna. Lo dice piano. Come se non volesse spezzare nulla.
Poi sparisce di nuovo.
Il ragazzo resta seduto. Guarda la mano di lei. Il tratto della firma. Poi guarda fuori. Una strada qualunque. La notte continua. I motorini, i fari, le auto che passano. Nessuno sa cosa è successo. Nessuno lo saprà. Ma non è questo il punto.
La ragazza prende fiato. Si piega in avanti. Appoggia il viso sulle mani. “Mi tremano ancora.” Lui la guarda. “È normale.” Poi si alza. Le si siede accanto. Niente abbracci. Solo presenza.
Fuori, Roma torna a essere rumore. I semafori riprendono il loro comando. I clacson risuonano più forte. L’aria è di nuovo pesante, piena di smog e luce artificiale. Ma dentro la clinica, il silenzio è diverso. Non è vuoto. È denso. C’è dentro tutto. L’attesa, la paura, la possibilità.
La scatola è rimasta lì, in una stanza dietro. Vuota adesso. O forse piena di qualcosa che ancora non ha nome. Un gesto. Una scelta. Una linea che si è tracciata in mezzo alla notte. Nessuna delle persone coinvolte tornerà a casa con un premio, un articolo, un applauso. Ma qualcosa è stato spostato. Leggermente. Come una traiettoria deviante. Come un graffio sulla superficie dell’indifferenza.
Otto persone. Otto storie che si sono incrociate nel tempo sbagliato, nel posto sbagliato, per fare la cosa giusta. O forse solo per provarci. Senza garanzie. Senza sapere.
di Danilo Pette