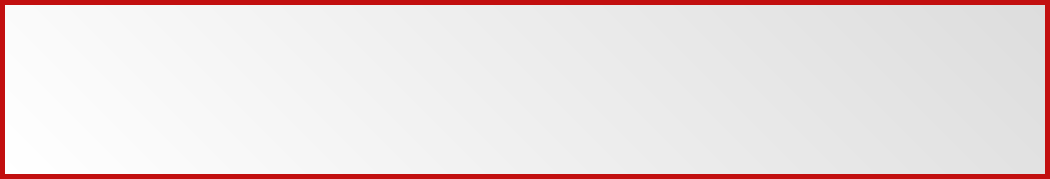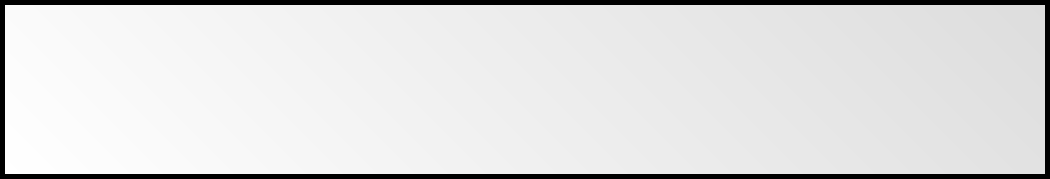Nobiltà, Notai e Narcisismo? La sentenza che ha messo fine al titolo “fai-da-te”
Scritto da Alessio Tommasi Baldi il . Pubblicato in Araldica, Cavalieri, Nobili e Templari.
Non sono un giurista, e non pretendo di esserlo. Ma quando la Cassazione si mette a parlare di nobiltà, titoli e atti notarili, qualcosa dentro di me si accende. Non per nostalgia monarchica, ma per quella curiosità un po’ viscerale che mi spinge a cercare di capire perché, in Italia che non riconosce titoli nobiliari, questa materia continui ad essere così “di moda”.
Il fascino eterno della nobiltà
 Fin da bambini siamo cresciuti tra principi, dame e cavalieri. Non è solo folklore: è imprinting culturale. La nobiltà, anche se giuridicamente morta, continua a vivere nei sogni, nei racconti e — diciamolo — nelle vanità. È il simbolo di un’identità forte, riconoscibile, tramandata. E in un mondo che ci vuole tutti uguali, l’identità è forse l’ultimo lusso… o forse un salvagente.
Fin da bambini siamo cresciuti tra principi, dame e cavalieri. Non è solo folklore: è imprinting culturale. La nobiltà, anche se giuridicamente morta, continua a vivere nei sogni, nei racconti e — diciamolo — nelle vanità. È il simbolo di un’identità forte, riconoscibile, tramandata. E in un mondo che ci vuole tutti uguali, l’identità è forse l’ultimo lusso… o forse un salvagente.
La storia dell’umanità è attraversata da dinastie, imperi, intrighi di palazzo e guerre per il trono. E anche se oggi viviamo in repubbliche costituzionali, il fascino del sangue blu non è mai svanito. Anzi, più la società si omologa, più il desiderio di distinguersi si fa pressante. Ecco perché, anche nel 2025, qualcuno ha pensato di “certificare” la propria nobiltà con un atto notarile.
La sentenza che ha fatto tremare i mantelli
La Cassazione, con la sentenza n. 18740 del 9 luglio 2025, ha messo fine a un tentativo tanto creativo quanto illusorio: un notaio aveva formalizzato un atto che attestava lo status nobiliare di un privato. La Corte non solo ha invalidato l’atto, ma ha sanzionato il notaio. Un gesto forte, che ha fatto rumore. Ma che, a ben vedere, non dice nulla di nuovo.
La nobiltà, in Italia, non ha valore giuridico. Lo dice il Titolo XIV della Costituzione, lo ribadiscono decenni di giurisprudenza. L’unico frammento che sopravvive è il predicato territoriale nel cognome, se storicamente riconosciuto. Il resto? Roba da salotto.
Nobiltà privata, non pubblica
Attenzione però, la repubblica non ha abolito la nobiltà: l’ha privatizzata. Non dà privilegi, non apre porte, ma può essere difesa come segno identitario. È passata dal diritto pubblico al diritto privato, e oggi vive nel nome, nella memoria, nella storia familiare. Non nei registri, non nei timbri notarili.
La sentenza della Corte Costituzionale n. 101/1967 è il pilastro di questa architettura: stabilisce che, dopo il 1948, ogni tutela passa attraverso il diritto privato. Se un predicato è stato integrato nel cognome sotto la monarchia, può essere difeso come parte del nome, ma non come status. E se non è storicamente consolidato, non si inventa. Non basta un atto, non basta un uso sociale. Serve radice storica, documentazione, coerenza.
L’ordinanza n. 8955/2024 ha ribadito che i tribunali devono fare riferimento ai registri storici e alla formula costituzionale transitoria. Nessun predicato può essere “creato” oggi. La tutela del nome non equivale a riconoscimento del rango, ma alla protezione dell’identità.
Il bisogno di essere “qualcuno”
 Ma allora, perché tutto questo clamore? Perché viviamo in una società liquida, dove tutto si mescola e si perde. E quando non sappiamo più chi siamo, cerchiamo disperatamente un’etichetta, un riconoscimento, un “di Vattelappesca” da appiccicarci addosso. Non per vantarcene — o forse sì, qualche volta — ma per non sparire nel mucchio.
Ma allora, perché tutto questo clamore? Perché viviamo in una società liquida, dove tutto si mescola e si perde. E quando non sappiamo più chi siamo, cerchiamo disperatamente un’etichetta, un riconoscimento, un “di Vattelappesca” da appiccicarci addosso. Non per vantarcene — o forse sì, qualche volta — ma per non sparire nel mucchio.
La psicologia ci insegna che l’identità non è solo ciò che pensiamo di essere, ma anche ciò che gli altri vedono in noi. E quando il riconoscimento sociale non basta, cerchiamo quello pubblico. Vogliamo che lo Stato, il notaio, il giudice ci dicano: “Tu sei”.
Troppo facile, a mio avviso, derubricare il tutto a vanagloria. C’è il desiderio di essere riconosciuti, certificati, distinti. Non basta che un amico ci chiami per nome. Vogliamo che lo faccia lo Stato, il notaio, il giudice. Vogliamo che qualcuno ci dica: “Tu sei”. E quando questo non accade, c’è chi lucra su questo istinto naturale e si inventa titoli, diplomi, mantelli. E c’è chi ci casca.
In un’epoca in cui l’identità è merce rara, la nobiltà diventa un rifugio. Ma anche un terreno minato. Perché dove c’è un bisogno, c’è chi specula. Ecco perché la Corte fa bene a ribadire, a sanzionare, a mettere paletti. Non per punire i sogni, ma per proteggere la verità.

Il mercato dell’identità
Il fenomeno dei titoli nobiliari “fai-da-te” non è solo una curiosità folkloristica. È il sintomo di una crisi più profonda: la crisi dell’identità personale. In un mondo che ci vuole intercambiabili, replicabili, fluidi, il bisogno di essere “unici” a volte diventa ossessivo. E su questa ossessione si sviluppa il mercato dei profittatori.
Oggi proliferano enti, associazioni e individui che vendono titoli, diplomi, onorificenze. Spesso con nomi altisonanti, stemmi araldici e cerimonie in costume. Un tempo sarebbe stato considerato ridicolo. Oggi, è business. E questo dovrebbe far riflettere chi insiste a voler “fluidificare” tutto.
La nobiltà come identità, non come privilegio
La nobiltà non è morta. È viva, ma solo se ha radici. Non si compra, non si certifica, non si improvvisa. È un pezzo di storia personale, non un lasciapassare sociale. E se qualcuno cerca di farla rivivere col timbro del notaio… la Cassazione lo rimette al suo posto.

In fondo, come diceva Pirandello, “uno, nessuno e centomila” non è solo un titolo letterario. È la condizione dell’uomo moderno. E se un cognome antico ci aiuta a essere “uno”, ben venga. Ma che sia vero, documentato, e non notarizzato a comando.
La vera nobiltà, tuttavia, non solo non è morta, ma è invece viva ed è auspicabile che sia diffusa.
Essa non significa essere riconosciuti da un notaio o dallo Stato, ma perché siamo eccellenza. Un’eccellenza derivante dalle origini e dalla tradizione, ma anche e soprattutto dalla propria stessa natura. Significa elevatezza spirituale, perfezione morale e intellettuale, è nobiltà d’animo, d’ingegno, d’indole, di pensiero e di comportamento ed è suggellata non da un bollo notarile, ma da una vita in costante azione coerente con tutto quanto sopra anche, anzi soprattutto, quando quella coerenza va a danno di chi la esercita. E’ giustizia nella verità, è coraggio nell’azione, è ingegno nella prova, è aiuto nel bisogno, è conforto nell’indifferenza, è rispetto ed è dovere. Essa è sempre ben riconoscibile e, oggi più che in passato, per chi la incontra è spesso scandalo, è inciampo, è domanda, è luce.
Se poi un predicato storico fa parte della propria identità, è giusto difenderlo. Non per vantarsi, ma per non perdersi… nomen omen.