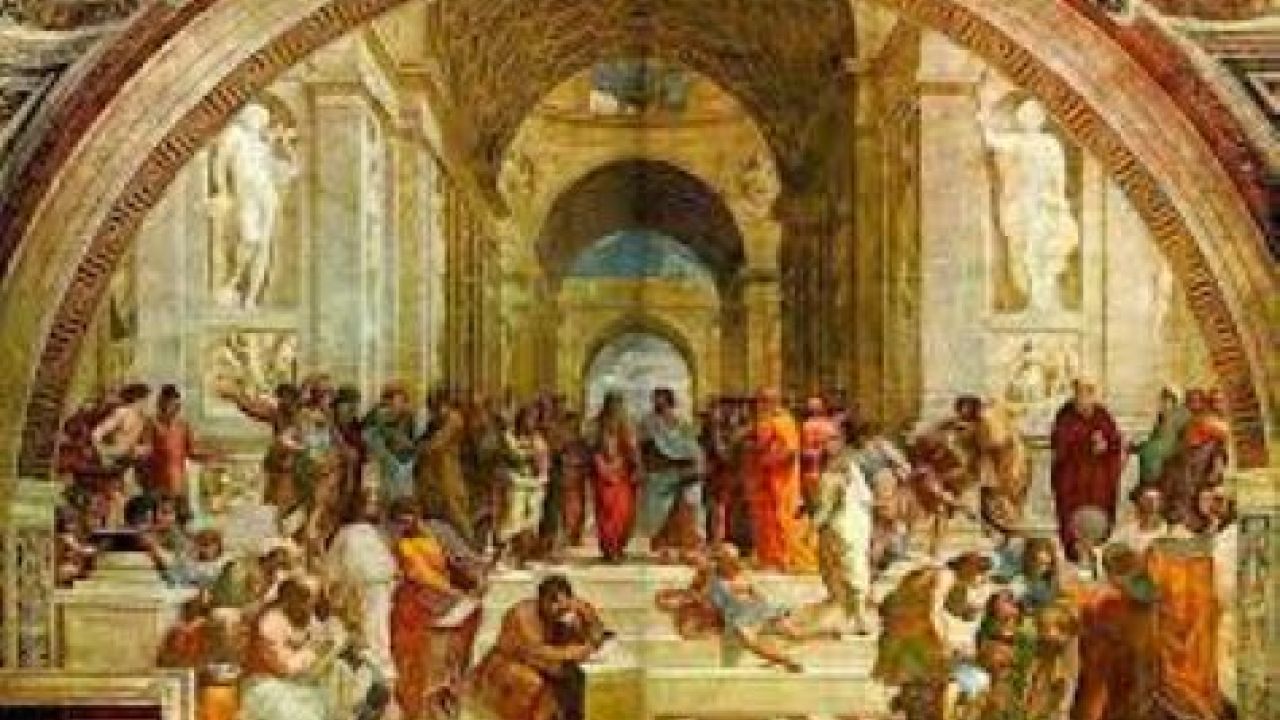
Atene e potere in un Paese ritrovato
Scritto da Fulvio Muliere il . Pubblicato in Attualità.
a cura di Fulvio Muliere
Dopo un decennio segnato da crisi, austerità e incertezza politica, la Grecia torna protagonista nello scenario europeo grazie alla leadership di Kyriakos Mitsotakis. Un’analisi del suo progetto di governo tra riforme strutturali, nuova centralità nel Mediterraneo e sfide ancora aperte.
La Grecia è tornata. Non quella delle cartoline turistiche o delle rovine classiche, ma quella moderna, resiliente, capace di risalire la china dopo essere stata il simbolo delle fragilità dell’eurozona. Le recenti elezioni politiche del 21 maggio hanno confermato il largo consenso nei confronti del premier uscente Kyriakos Mitsotakis, leader di Nuova Democrazia, il quale ha ottenuto un risultato elettorale nettamente superiore rispetto al principale avversario, Alexis Tsipras. Ma dietro i numeri delle urne si cela una trasformazione più profonda, che riguarda l’intero sistema-Paese: dalla crescita del PIL sopra la media europea al ritorno della fiducia dei mercati, dalla posizione strategica nel nuovo scacchiere energetico alla complessa gestione delle migrazioni. In un’Europa che fatica a ritrovare coesione e visione, la parabola greca assume oggi un valore paradigmatico. Questo articolo propone un viaggio analitico e critico nel nuovo corso ellenico, per comprendere come Atene stia provando – tra luci e ombre – a trasformarsi da anello debole dell’Unione a modello mediterraneo di ripresa.
Il panorama politico greco, segnato da una lunga e travagliata transizione post-crisi, ha visto un nuovo consolidamento con la schiacciante affermazione di Kyriakos Mitsotakis e del suo partito, Nuova Democrazia, nelle elezioni del 21 maggio. Con un consenso popolare vicino al 41%, più del doppio rispetto a quello ottenuto dal principale avversario, Alexis Tsipras, leader di Syriza ed ex primo ministro, il centrodestra greco ha dimostrato di rappresentare per una parte consistente dell’elettorato una garanzia di stabilità, crescita e governance. Tuttavia, nonostante l’ampio margine, la legge elettorale proporzionale allora in vigore ha impedito a Mitsotakis di ottenere la maggioranza assoluta dei seggi in Parlamento, rendendo necessaria una seconda tornata elettorale, fissata per il 25 giugno. Questa tornata elettorale sarà determinante: con il ritorno del premio di maggioranza per il primo partito, Nuova Democrazia potrebbe garantirsi un governo autonomo, libero dai vincoli delle coalizioni, e quindi più stabile e capace di portare avanti le riforme già iniziate.
La rilevanza di questa vittoria non è solamente politica. Si innesta, piuttosto, in una più ampia traiettoria di riscatto nazionale. Dopo un decennio di crisi economica profonda, cominciata già nel 2001 con l’ingresso nell’euro, la Grecia sembrava destinata a un declino inarrestabile. L’adozione della moneta unica, pur avvenuta con il placet delle istituzioni europee, non era sostenuta da fondamenta economiche solide: il deficit era ben oltre i limiti imposti dai parametri di Maastricht. Tuttavia, per ragioni politiche e strategiche, Bruxelles chiuse un occhio. Nei primi anni l’ingresso nell’euro sembrò premiare la Grecia: tassi d’interesse bassi, afflusso di capitali, aumento della spesa pubblica, ma dietro l’apparente prosperità si nascondeva una fragilità strutturale, aggravata dalla mancanza di trasparenza fiscale e da un debito pubblico crescente. A partire dal 2009 la situazione degenerò: Atene fu costretta a chiedere aiuti internazionali e ad accettare una sequela di misure di austerità imposte dalla Troika – Commissione Europea, Banca Centrale Europea e Fondo Monetario Internazionale – in cambio di tre piani di salvataggio per un ammontare complessivo superiore ai 260 miliardi di euro.
Il periodo successivo fu segnato da instabilità politica, proteste sociali, disoccupazione altissima, tagli draconiani e una perdita di fiducia generalizzata nelle istituzioni. La Grecia diventò l’epicentro della crisi del debito sovrano europeo, e l’eventualità di una Grexit, ossia l’uscita del Paese dall’eurozona, fu per anni uno scenario temuto e dibattuto. La classe politica sembrava impotente o complice. Né i governi di centrosinistra né quelli di centrodestra riuscivano a produrre una risposta sistemica. In questo contesto, l’ascesa di Syriza nel 2015 rappresentò un tentativo, velleitario e populista, di ribaltare il paradigma imposto dalle istituzioni europee, ma che si concluse con un fallimento politico clamoroso, culminato con la capitolazione di Tsipras e l’accettazione di un nuovo memorandum.
Quando Kyriakos Mitsotakis prese le redini del Paese nel 2019, la Grecia era ancora convalescente, con un’economia fragile, una società stremata e una reputazione internazionale compromessa. Tuttavia, il governo di Nuova Democrazia si pose fin da subito come interprete di una nuova stagione, improntata a pragmatismo, riformismo e credibilità. L’approccio fu tecnocratico, ma non distante: un bilanciamento tra rigore e realismo, tra attrazione degli investimenti e recupero della fiducia sociale. Il primo effetto tangibile fu la ripresa del PIL. Dopo la flessione pandemica del 2020, il 2021 vide un rimbalzo dell’8,4%, seguito da un ulteriore +5,9% nel 2022. Per il 2023 e il le previsioni della Commissione Europea indicano un +2,4% e +1,9% rispettivamente, mentre la Banca Centrale greca stima una crescita del 2,2% per l’anno in corso, al di sopra della media dell’eurozona. Un dato che non solo testimonia la solidità della ripresa, ma anche la sua sostenibilità.
A trainare questa crescita sono stati diversi fattori. Il turismo, storicamente uno dei pilastri dell’economia ellenica, è tornato ai livelli pre-pandemici, con numeri record per le stagioni 2022 e 2023. I fondi europei del PNRR sono stati utilizzati con efficienza per modernizzare infrastrutture e servizi pubblici, mentre il clima di fiducia ha favorito un ritorno degli investimenti esteri. Il porto del Pireo, già al centro di ingenti investimenti cinesi, è diventato uno snodo logistico cruciale nel Mediterraneo, mentre il rilancio della Grecia come hub energetico ha aperto nuovi scenari geopolitici. In particolare, la collaborazione con Israele, Cipro ed Egitto per l’interconnessione energetica, insieme alla ristrutturazione delle reti elettriche e gasiere europee a seguito della guerra in Ucraina, ha trasformato la Grecia in un partner strategico per Bruxelles. In questo contesto, la stabilità politica non è un valore astratto, ma una condizione essenziale per la continuità delle politiche di integrazione energetica e infrastrutturale.
Non è un caso che il rating del debito greco stia tornando ai livelli pre-crisi. Le principali agenzie internazionali – Fitch, Moody’s e Standard & Poor’s – hanno già segnalato un outlook positivo. L’ottenimento dell’investment grade è considerato imminente, e potrebbe concretizzarsi entro la fine del 2023. Questo rappresenterebbe una svolta storica: significherebbe che la Grecia è tornata a essere affidabile per gli investitori globali, con la possibilità di ottenere finanziamenti a costi significativamente inferiori, liberando risorse per la spesa pubblica e gli investimenti produttivi. Anche sul fronte occupazionale i segnali sono positivi: la disoccupazione è in calo costante, specialmente tra i giovani, anche se persistono disparità territoriali e settoriali.
La gestione Mitsotakis non si è limitata all’economia. Sul piano della politica estera, la Grecia ha rafforzato le sue alleanze strategiche, in particolare con gli Stati Uniti. Nuovi accordi militari hanno portato a un rafforzamento delle basi NATO presenti sul territorio, mentre il governo ha mantenuto una postura ferma ma misurata nei confronti della Turchia, evitando escalation ma difendendo con decisione gli interessi nazionali nel Mar Egeo. In Europa, Mitsotakis ha incarnato una visione europeista ma critica: favorevole all’integrazione, ma attento agli interessi dei Paesi mediterranei, in particolare sul fronte dei vincoli fiscali e delle politiche agricole.
Tuttavia, non mancano le criticità. La questione demografica rimane una sfida epocale. L’invecchiamento della popolazione e l’emigrazione giovanile, pur in rallentamento, continuano a ridurre il potenziale produttivo del Paese. Le aree rurali e insulari soffrono per la mancanza di servizi essenziali, in particolare sanità e istruzione. Il fenomeno dell’overtourism, con la concentrazione eccessiva dei flussi in poche località, sta mettendo sotto pressione infrastrutture e ambiente, rendendo urgente una politica di redistribuzione turistica più equilibrata e sostenibile.
Anche la gestione migratoria resta un punto sensibile. La Grecia è uno dei principali punti di accesso per i migranti provenienti da Asia e Africa attraverso la rotta orientale del Mediterraneo. Il governo ha adottato politiche restrittive, rafforzando i controlli e attuando respingimenti che hanno suscitato dure critiche da parte delle ONG e delle organizzazioni internazionali. Tuttavia, l’opinione pubblica greca sembra approvare la linea dura, considerandola necessaria per garantire sicurezza e coesione sociale.
Durante la campagna elettorale, le opposizioni – Syriza e Pasok – hanno cercato di colpire Mitsotakis sul fronte della gestione amministrativa. L’episodio più eclatante è stato l’attacco informatico al sistema scolastico nazionale, verificatosi durante
le prove d’esame Panelleniche. La vulnerabilità del sistema ha sollevato dubbi sull’efficacia delle politiche digitali del governo, ma l’incidente non ha scalfito il consenso popolare, anche grazie alla rapida reazione delle autorità e alla trasparenza nella comunicazione dell’accaduto.
La vittoria di Mitsotakis, pur espressione di una classe dirigente borghese e tecnocratica, si è fondata su un’ampia trasversalità sociale. Non solo l’elettorato tradizionale di centrodestra, ma anche fasce popolari e giovani imprenditori hanno votato Nuova Democrazia, attratti dalla promessa di stabilità e modernizzazione. L’identità greca, segnata da una profonda coscienza storica e un forte orgoglio nazionale, sembra aver trovato in Mitsotakis un punto di equilibrio tra appartenenza europea e sovranità nazionale, tra innovazione e tradizione.
Grecia del 2023 si presenta come un laboratorio politico ed economico di grande interesse per l’Europa. Lungi dall’essere un caso isolato o un’anomalia mediterranea, la sua traiettoria rappresenta un esempio di come, anche dopo una crisi devastante, sia possibile ricostruire un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo, a patto di mantenere un saldo ancoraggio alle istituzioni democratiche, alla trasparenza e alla responsabilità politica. La seconda tornata elettorale del 25 giugno non sarà solo un passaggio formale, ma il sigillo su una fase storica di rilancio nazionale. Se confermata, la leadership di Mitsotakis potrà contare su un mandato pieno, per completare un percorso iniziato tra mille difficoltà e oggi carico di aspettative.


















