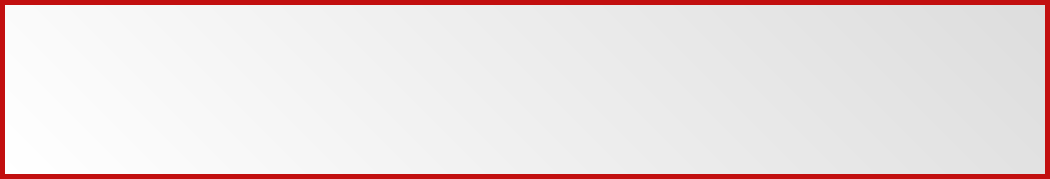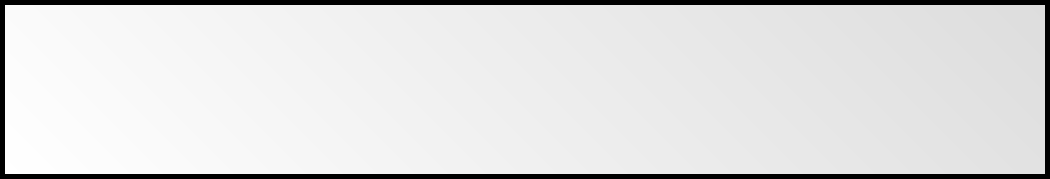Centesimi al Sole
Scritto da Danilo Pette il . Pubblicato in Attualità.
“Quando il valore del lavoro si misura in centesimi sotto il sole rovente, tra sudore, fatica e un algoritmo che decide chi può resistere e chi sparire, la dignità umana viene ridotta a una notifica digitale: questo è il racconto di chi, invisibile e sfruttato, consegna non solo cibo ma anche il prezzo di un sistema che preferisce il profitto alla vita.”
Centesimi. Meno di un caffè. Una mancia sudata, raccolta da chi ha il fiatone, il casco che brucia, la pelle che cuoce. Un premio, dicono. Un bonus. Un incentivo per resistere. Per consegnare anche quando l’asfalto frigge e i semafori si sciolgono. Un’elemosina digitale che arriva in forma di notifica, come se bastasse un messaggio colorato per trasformare la disumanità in opportunità. Come se bastasse un’emoji per cancellare la vergogna.
Il termometro segna 42 gradi. Il rider accende l’app. Una corsa. Poi un’altra. Poi ancora. Nessuna pausa, nessuna ombra. Solo una promessa: “Qualche centesimo in più per ogni consegna sotto il sole”. Ma chi stabilisce il prezzo del sudore? Chi ha deciso che la fatica valga meno di un euro, anche quando il corpo grida, anche quando le ginocchia tremano?
I bonus li chiamano così. Ma sono messaggi freddi come l’acciaio. Pochi caratteri per dire: arrangiati. Stringi i denti. Ce la puoi fare. Come se il problema fosse la motivazione, non la sopravvivenza. Come se bastasse un incentivo per rendere accettabile l’inaccettabile.
Ogni consegna diventa un atto di resistenza. Ogni chilometro un test. Resistere al sole, all’afa, al peso. Resistere alla stanchezza, alle vesciche, alla fame. Ogni rider è un sopravvissuto, eppure nessuno li chiama così. Nessuno li celebra. Nessuno li ascolta.
Sono ovunque, ma non esistono. Sono parte dello sfondo. Li si vede solo di riflesso, nello specchietto retrovisore, o attraverso lo spioncino, quando bussano per consegnare una cena calda a chi, magari, non ha alzato nemmeno un dito per cucinarla. Sono i servi gentili della città, i nuovi facchini della logistica algoritmica. Invisibili. Ma fondamentali.
Eppure la loro esistenza è computata in spiccioli. Un centesimo per ogni goccia di sudore. Una monetina per ogni rischio. Un riconoscimento finto, che puzza di presa in giro, che sa di violenza sottile, quella che si esercita col sorriso, con la promessa di un’opportunità.
È il mercato, ci dicono. È la flessibilità. La libertà di scegliere quando lavorare. Ma la verità è che non c’è nessuna scelta. Non c’è libertà. C’è solo una necessità che diventa vincolo. L’app non perdona. Ti valuta. Ti misura. Ti confronta. Ti penalizza. E se dici no, sei fuori.
Fuori dal sistema. Fuori dal flusso. Fuori dal gioco.
E chi ha il coraggio di rifiutare una corsa, magari perché ha la pressione bassa, perché ha già percorso 50 chilometri sotto il sole, perché sente le gambe cedere, riceve il silenzio. Nessuna nuova corsa. Nessun aggiornamento. Solo una pausa. Che pausa non è: è una punizione. È l’algoritmo che ti dimentica. È il sistema che ti silenzia.
La monetizzazione del rischio è diventata prassi. L’eccezione è diventata regola. Ogni estate, ogni ondata di calore, porta con sé lo stesso copione: temperature record, allerte della protezione civile, raccomandazioni di restare a casa, bere molto, evitare sforzi. E intanto i rider sono in strada. Non per eroismo. Ma perché non possono permettersi il lusso di non esserci.
Il lusso del riposo. Il privilegio della sicurezza.
Le aziende inviano comunicati. Parlano di attenzione. Parlano di premi. Parlano di “supporto”. Ma il supporto ha la forma di una notifica con scritto “+0,20 € per ogni corsa effettuata oltre i 40 gradi”. C’è quasi da ridere. Se non ci fosse da piangere. Se non ci fosse da vergognarsi.
Quanti di noi, seduti al fresco, con una bibita ghiacciata tra le mani, leggono quel messaggio e provano qualcosa? Non pietà, non carità. Ma consapevolezza. Indignazione. Disgusto. Quanti pensano che quel rider potrebbe essere nostro fratello, nostra sorella, nostro figlio?
Ma è più comodo non pensarci. È più semplice separare. Creare una distanza. Noi e loro. Chi ordina e chi consegna. Chi clicca e chi suda. Chi è cliente e chi è funzione.
Una funzione. È così che li vede il sistema. Un avatar su uno schermo. Un numeretto in movimento sulla mappa. Un indicatore di performance. Nessuno si chiede chi ci sia dietro quella mappa. Nessuno si chiede che storia abbia, quella persona che ci sta portando la cena. Se dorme bene. Se è in regola. Se ha mangiato. Se ha figli. Se è felice. Se ha paura.
Non ci interessa. Perché l’umanità, in questo gioco, è stata espulsa.
Il linguaggio stesso lo rivela. “Partner”, “collaboratore”, “indipendente”. Parole studiate. Parole pulite. Parole che annullano il conflitto. Che nascondono la gerarchia. Che cancellano il potere. Perché se sono partner, allora siamo alla pari. Ma non siamo alla pari. Uno guadagna milioni. L’altro raccoglie centesimi sotto il sole.
Uno lavora da casa. L’altro si consuma in strada.
Eppure abbiamo accettato tutto questo. Come se fosse normale. Come se fosse inevitabile. Come se fosse giusto. Ci hanno addestrati alla rassegnazione. Ci hanno insegnato che questo è il mondo. Che bisogna solo adattarsi. Che chi si lamenta è debole. Che chi protesta è ingrato.
Così, ogni estate, si ripete lo stesso schema. Il calore uccide, ma non il profitto. Il corpo cede, ma l’algoritmo no. La logica resta la stessa: avanti, avanti, avanti. Sempre di più. Sempre più veloce. Sempre più economico. Il costo? La salute. La dignità. La vita.
Non è retorica. È cronaca. Ogni tanto, quando un rider sviene in strada, quando viene trovato riverso sul marciapiede, quando muore, la notizia rimbalza sui giornali. Per qualche ora. Poi scompare. Come lui. Come tutti gli altri.
“Un altro malore”. “Un’altra tragica fatalità”. Così scrivono. Ma non è fatalità. È sistema. È calcolo. È politica dell’abbandono.
Perché sì, la politica c’è. Ma non dove serve. È lì quando c’è da fare passerelle. Quando c’è da tagliare nastri. Quando c’è da applaudire l’innovazione. Ma quando si tratta di mettere mano alle tutele, di riscrivere i contratti, di obbligare le piattaforme a riconoscere i diritti, allora scompare.
Fanno finta che non sia un problema. Fanno finta che siano eccezioni. Che si tratti di casi limite. Ma non sono limiti: sono la regola. Sono la normalità.
E questa normalità è malata. È tossica. È violenta.
Perché in nessuna società sana è accettabile che qualcuno venga pagato centesimi per rischiare la vita. In nessuna economia giusta è legittimo che il guadagno di pochi si fondi sull’umiliazione quotidiana di molti. Eppure accade. Ogni giorno. Sotto il sole. Nell’indifferenza.
L’aspetto più crudele è l’ipocrisia del sistema. La retorica che accompagna tutto questo. Le parole scelte con cura. Il marketing della compassione. L’idea che basti “valorizzare” il lavoro con piccoli bonus per lavarsi la coscienza. Come se si potesse davvero misurare la dignità al centesimo. Come se si potesse comprare la resistenza di un corpo con una notifica gentile.
“Ti diamo qualcosa in più”. Sì. Ma in cambio di cosa?
Di una corsa sotto il sole, senza pausa, senza acqua, senza sicurezza.
Di un chilometro in più, mentre il cuore pompa al massimo e la vista si annebbia.
Di una salita con lo zaino in spalla, mentre l’aria brucia i polmoni.
Il rider non può fermarsi. Non deve. Perché ogni minuto conta. Ogni secondo pesa. Ogni pausa è penalità. Ogni rifiuto è di restare indietro. Ogni “no” pesa come un mattone nell’algoritmo che decide chi vale e chi no. È il segnale silenzioso della scomparsa. La cancellazione senza colpa, senza becchino, soltanto uno “stato inattivo”. E mentre diventi invisibile al sistema, resti visibile solo alla fatica che ti divora.
Allora continui. Anche se il sudore ti brucia la nuca. Anche se hai le mani insensibili dal freddo quando la notte scende. Anche se la pioggia ti lava via la voce. Anche se quel bonus non basta a comprare un tram. Anche se quell’incentivo è meno di una sigaretta. Perché anche meno.
Il sistema, ipocrita, si pulisce le mani così: ti regala qualche centesimo, come a dire “ci siamo preoccupati per te”. Come se bastasse un gesto minimo, simbolico, per lavarsi la coscienza. Come se si potesse comprare la nostra coscienza per per pochi centesimi. Un buffetto sulla guancia di chi cade.
E noi? Non possiamo più dire di non sapere. Ogni volta che ordiniamo, partecipiamo. Ogni volta che accendiamo l’app, siamo complici. Ogni volta che ignoriamo quello zaino che avanza accaldato, siamo corresponsabili.
Chi ha inventato la parola “bonus” in questo contesto è un artista del paradosso: un sofisma che trasforma l’offesa in opportunità. Il coraggio in scelta. La violenza in concessione.
L’opportunità di essere sfruttati.
Poi arriva il silenzio. Silenzio è la strada arroventata quando il rider svanisce dalla mappa. Silenzio è la nostra indifferenza dietro lo schermo. O è la città, imbambolata nel suo clima condizionato, che non vede più niente che non sia comodo o cool. Il corpo che fatica è fuori tema. È fuori frame.
Eppure la domanda resta, ancora: quei centesimi, sono un premio? O sono una condanna? Un segnale che indicizza la dignità al ribasso. Una sentenza: dignità = pochi centesimi. E va bene così.
Non è generosità. È arroganza. Non è pensiero. È a pensiero.
E allora serve qualcosa di più di un post indignato. Serve un gesto concreto: riconoscere diritti. Leggi serie. Contratti veri. Peso politico. Rappresentanza. Calore umano. Servono voci che non si spengano in strada o dentro l’app.
Un bonus non basta. Non basta un hashtag, non basta un’impaginazione gentile, non basta un commento indignato mentre torniamo al fresco.
Serve che il lavoro abbia valore, sempre. Che la vita non si misuri in spiccioli. Che la fatica non sia neutralizzata da un algoritmo.
E se non abbiamo il coraggio di fermarci, almeno lasciamo che sia la coscienza a farsi caldo.
a cura Danilo Pette