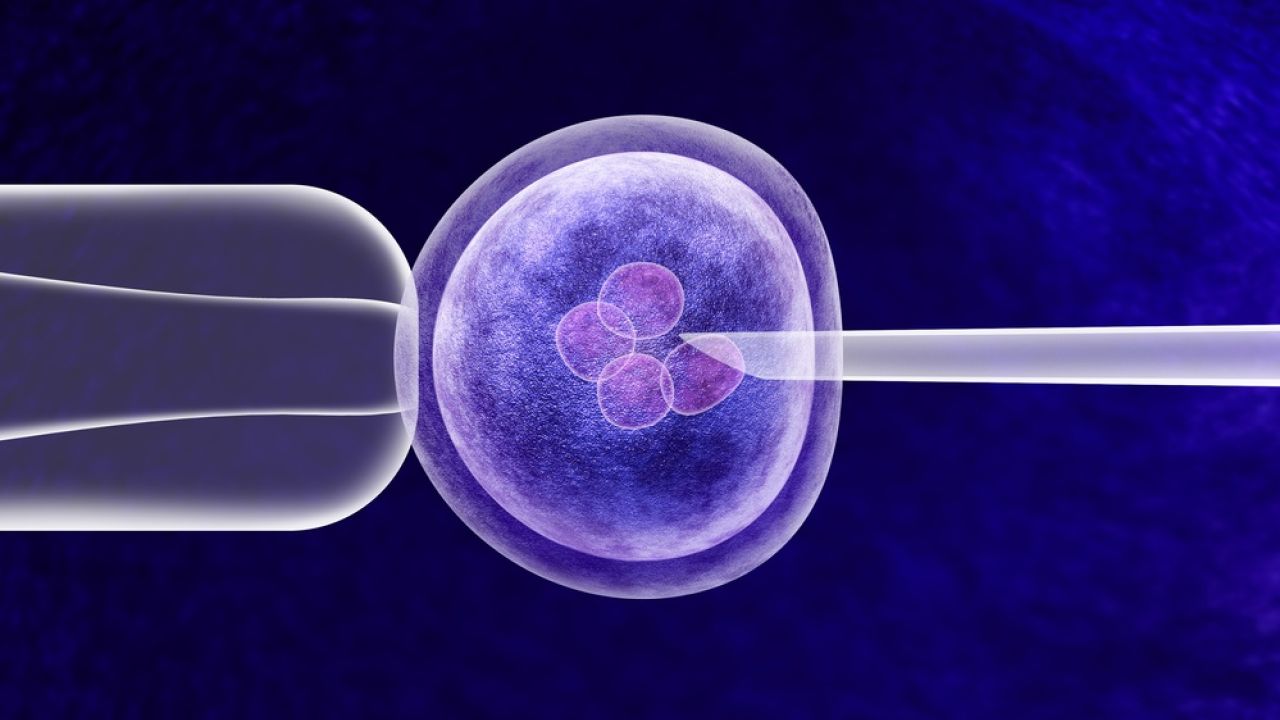
Codice Salute e la Nuova Geografia del Potere nella Medicina
Scritto da Ottavia Scorpati il . Pubblicato in Attualità, Salute e Sanità.
A cura di Ottavia Scorpati
Dall’intelligenza artificiale ai gemelli digitali, dai big data alle piattaforme globali: la trasformazione della sanità ridefinisce non solo la cura, ma anche i rapporti tra Stati, cittadini e poteri economici. Un’indagine critica sull’ascesa della medicina algoritmica come strumento geopolitico, economico e culturale.
La salute non è più soltanto una disciplina scientifica, un settore medico o una voce nei bilanci pubblici. È divenuta uno dei terreni più strategici della contesa globale, una nuova infrastruttura del potere contemporaneo. Non si tratta semplicemente di progresso tecnologico o di innovazione clinica: ciò che si sta ridisegnando sotto i nostri occhi è una nuova architettura del mondo, in cui dati biologici, algoritmi predittivi e piattaforme digitali sostituiscono farmaci e bisturi, e in cui l’accesso alla cura è modellato dalla logica del codice e non più soltanto dalla diagnosi.
Nel corso del XX secolo, la medicina ha seguito il cammino della chimica di sintesi e della biologia molecolare: dalla scoperta della penicillina alla doppia elica del DNA, la cura era soprattutto una questione di laboratorio. Oggi, invece, il codice informatico è diventato il nuovo principio attivo, l’intelligenza artificiale il nuovo strumento diagnostico, l’algoritmo la nuova forma di autorità clinica. I trattamenti si digitalizzano, i pazienti diventano “profili sanitari dinamici”, i gemelli digitali permettono di simulare l’efficacia di una terapia prima che venga applicata. Ogni cellula del nostro corpo può essere tradotta in dati, e ogni dato diventa materia prima per l’industria della salute. Ma in questo passaggio epocale, chi governa il processo? E per conto di chi?
Gli Stati Uniti continuano a guidare la trasformazione, grazie alla storica alleanza tra FDA, Big Tech e capitale di rischio. L’innovazione non nasce più nei laboratori pubblici, ma negli incubatori privati, nei server delle multinazionali digitali, nelle strategie delle piattaforme globali. Il software sanitario diventa prodotto brevettabile, scalabile, capitalizzabile. Israele, da parte sua, ha costruito un ecosistema altamente avanzato, in cui la raccolta centralizzata dei dati sanitari viene integrata con intelligenze artificiali per sviluppare soluzioni terapeutiche in tempo reale. La Cina, invece, fonde la medicina digitale con la propria visione strategica di potenza globale: ospedali digitali, app di telemedicina, piattaforme per la diagnostica a distanza vengono installati in Paesi dell’Africa, dell’Asia centrale e dell’America Latina. Ma dietro la cooperazione sanitaria, si cela una sofisticata architettura di controllo: ogni sistema di assistenza è anche un sistema di sorveglianza; ogni tecnologia “donata” garantisce accesso privilegiato a dati sensibili, territori, risorse.
Nel vuoto lasciato da istituzioni fragili, economie in crisi e governi delegittimati, queste infrastrutture tecnologico-sanitarie diventano nuovi strumenti di influenza politica. Stati collassati, società disgregate, territori segnati da promesse disattese di sviluppo e diritti diventano laboratori del nuovo colonialismo digitale. Promuovere la salute, in questi contesti, non significa solo curare, ma occupare uno spazio geopolitico, entrare nei meccanismi vitali delle società, accedere alle informazioni genetiche della popolazione. L’algoritmo non è più un semplice calcolo: è una nuova forma di governo.
Nel frattempo, la medicina digitale genera un’economia parallela. Le Digital Therapeutics – terapie digitali clinicamente validate – stanno già trasformando la pratica medica in molti Paesi. Applicazioni che trattano l’insonnia, la depressione, il diabete o le dipendenze vengono prescritte come farmaci. Si passa da cure materiali a servizi software; dai medicinali a licenza alle piattaforme in abbonamento. Si afferma un modello in cui la salute è on demand, personalizzata, automatizzata – ma anche vincolata alla connessione, all’interoperabilità, alla logica del mercato. Le assicurazioni iniziano a selezionare i clienti in base al rischio genetico predittivo; i datori di lavoro esplorano la possibilità di integrare dati sanitari nei processi di assunzione; i governi autoritari profilano i cittadini per fascia di rischio sociale, sanitario, politico.
I big data sanitari, che rappresentano una risorsa strategica di valore inestimabile, diventano l’oggetto di una nuova corsa globale all’egemonia. Non c’è settore industriale che prometta, nei prossimi anni, tassi di crescita simili a quelli della salute digitale. Le stime parlano di mercati miliardari, ma dietro i numeri c’è una trasformazione ancora più profonda: quella del rapporto tra cittadino e Stato, tra individuo e potere, tra diritto alla salute e controllo digitale. Chi possiede l’algoritmo, possiede il futuro della medicina. Chi stabilisce gli standard di funzionamento, determina chi avrà accesso alla cura e in quali condizioni.
L’Europa, in questo scenario, appare in affanno. Pur disponendo di centri di eccellenza scientifica, università di prestigio e una lunga tradizione di welfare sanitario, il continente resta spesso spettatore delle dinamiche globali. Iniziative come EU4Health o lo European Health Data Space tentano di costruire un’infrastruttura comune, ma senza una visione politica unitaria, il rischio è quello di restare consumatori passivi di tecnologie sviluppate altrove. L’Italia, con i fondi straordinari del PNRR, ha oggi una possibilità concreta di colmare il divario. Ma la digitalizzazione sanitaria non può ridursi a una modernizzazione amministrativa: deve essere accompagnata da una strategia nazionale fondata su formazione, ricerca pubblica, capacità produttiva autonoma. Senza un’infrastruttura cognitiva e industriale, il nostro Paese sarà semplicemente un mercato, non un attore.
Nel cuore di questa trasformazione, si apre anche una battaglia culturale. Serve un nuovo lessico della cura, una nuova alfabetizzazione scientifica, un’educazione digitale che renda ogni cittadino consapevole del proprio ruolo nel nuovo ecosistema terapeutico. Iniziative come Reshape, promosse dall’Osservatorio Terapie Avanzate con l’Osservatorio Malattie Rare, mostrano che è possibile raccontare l’innovazione in modo accessibile e rigoroso: narrazioni, podcast, illustrazioni, linguaggi trasparenti per costruire fiducia nella scienza e contrastare la disinformazione.
Ma questi sforzi, per quanto lodevoli, non bastano. L’intero sistema deve riconoscere che la medicina digitale è anche – e soprattutto – una questione politica. L’algoritmo non è neutro. La selezione dei dati, la progettazione dei modelli predittivi, la distribuzione delle tecnologie non sono mai prive di interessi, valori, ideologie. Ogni linea di codice porta con sé una visione implicita di mondo: su chi merita di essere curato, su cosa significhi “normalità”, su quali corpi abbiano diritto alla tecnologia e quali no.
Le disuguaglianze digitali rischiano di sovrapporsi e amplificare le disuguaglianze sociali. Senza un sistema di regole globali, trasparenti e condivise, la medicina del futuro potrebbe diventare uno strumento di esclusione. La prevenzione personalizzata può degenerare in selezione genetica. La profilazione del rischio può trasformarsi in discriminazione predittiva. E l’accesso alla cura può essere definito non dalla necessità, ma dalla capacità di pagare, di connettersi, di essere “leggibili” dagli algoritmi.
In questa nuova geografia della salute, le democrazie si giocano una parte fondamentale del loro futuro. La medicina digitale sarà uno degli strumenti con cui si misurerà la qualità della vita, ma anche la qualità della democrazia. Se prevarrà la logica dell’oligopolio, della sorveglianza, dell’estrattivismo tecnologico, allora la salute diventerà un altro fronte della disuguaglianza. Se invece si riuscirà a costruire un modello partecipativo, etico, inclusivo, allora potrà essere il punto di partenza per una nuova stagione di giustizia sociale.
In un’epoca segnata da crisi economiche, repressioni dei diritti, crisi ambientali e collasso istituzionale, la medicina digitale diventa la nuova arena in cui si ridefiniscono i rapporti di forza. Non possiamo permetterci l’inerzia. Governare l’algoritmo, costruire una sanità digitale equa, difendere la privacy come bene comune, finanziare la ricerca pubblica, proteggere i dati sensibili e promuovere la solidarietà sanitaria sono azioni urgenti, non più rinviabili. La salute non è più un tema tecnico. È il nuovo terreno della politica globale.



















