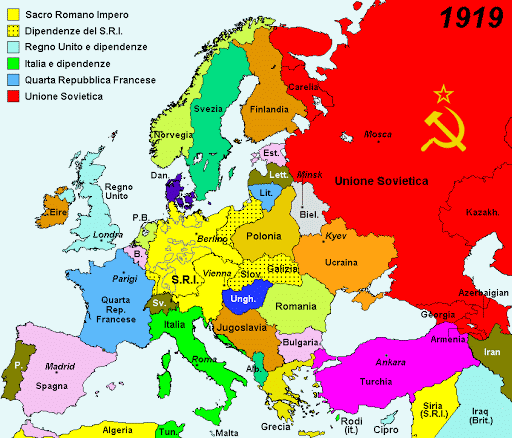
Europa muta
Scritto da Agostino Agamben il . Pubblicato in Attualità.
a cura Agostino Agamben
Sotto l’ombra apparente della normalità quotidiana si consuma una crisi silenziosa che riguarda la postura geopolitica dell’Italia e dell’Europa intera: tra l’indifferenza verso il conflitto ucraino, la marginalizzazione diplomatica, il ricatto energetico e il vuoto di decisione politica, si delinea la necessità di riscoprire una voce comune, un’etica della presenza e un pensiero capace di andare oltre la logica dell’attesa e del compromesso.
Non c’è alcuna frontiera fra l’ombrellone e la politica estera; o forse l’ombra stessa è la frontiera che disegna e disperde insieme, smarginando le pretese di una distanza netta, relegata, fra il privato e il politico. Sotto il tessuto steso per ripararsi dal sole non si cela soltanto la solitudine balneare, ma tutto un ordine mondiale inarrestabile, un orizzonte che non si lascia mai delimitare da mutuazioni consolatorie.
Il discorso si muove — quasi impercettibilmente — su due livelli che congregano il visibile e l’invisibile: sul piano dei missili, dei carri armati, dei ricatti economici, e sul piano delle conversazioni quotidiane, dell’ombrellone, del colore, del rumore, della lingua. Perché l’ombrellone non è soltanto un riparo; è un segno, un dispositivo attraverso cui si manifesta ciò che chiamiamo politica estera: cioè la costituzione di uno spazio in cui si sperimenta ciò che siamo, ciò che possiamo essere, ciò che diventiamo quando il mondo ci interroga, o quando noi interroghiamo il mondo.
Sotto l’ombrellone il mare riflette la luce che acceca, e le onde che tornano a riva cancellano ogni confine tracciato sulla sabbia. Il mare è, per natura, estremo confinamento e al contempo spazio sovrano. Se pensiamo all’Ucraina, se pensiamo a Mosca, se pensiamo all’Europa che balbetta, si potrebbe dire che quei paesi sono come spiagge su cui si infrangono gli inevitabili ritorni del passato, i tentativi di riscrivere storie, tracciare linee, erigere ombrelli contro il rischio di essere investiti dal diluvio.
Il fatto che la crisi con la Russia non sia nuova non significa che non sia fatale; il tempo non cancella, semmai sedimenta. L’esperienza dell’Unione Sovietica è oggi un fantasma che ritorna, una sostanza tenace che reclama spazio, memoria, presenza. Putin non è soltanto un leader; è l’ombra, allungata, di un ordine che si credeva superato, ma che ogni tanto torna sotto forma di scalpore, di confine riaperto, di guerra latente che si fa visibile. E l’Europa trema, nella misura in cui ha dimenticato cosa significa avere una voce, cosa significa che la voce sia ascoltata, che non sia sommessa dal fragore delle partenze, delle migrazioni, delle bollette energetiche.
Ecco che, allora, l’agnello sacrificale non è necessariamente Kiev; è qualcosa dentro Kiev e fuori Kiev; è la speranza che l’Occidente ha coltivato di preservare se stesso con la distanza, con la neutralità, con la promessa di un ordine basato sul diritto, su alleanze e su promesse che spesso si rivelano fragili. Ricordiamo Praga, ricordiamo Monaco; ricordiamo quando ci illudevamo che bastasse un trattato, una firma, un gesto pubblico per garantirci la pace, la stabilità, la corretta collocazione storica. E invece ogni volta succede — come la sabbia che si sposta — che il trattato sia ignorato, la voce calpestata, l’aggressione contenuta solo nella misura in cui il potere lo consente.
Ma non siamo alla terza guerra mondiale, e tuttavia le premesse ci sono: non perché esista una catastrofe inevitabile, ma perché non ci siamo preparati, perché preferiamo parlare del green pass e degli ombrelloni — temi immediati, condivisibili, capaci di coinvolgere il corpo — piuttosto che confrontarci con ciò che ci espone, ciò che ci chiede una decisione nel tempo lungo. Parlare di ombrelloni è parlare dell’ombra che ripara — o che tradisce — la nostra incapacità di fare politica estera, politica comune, politica che tagli la distanza fra provincia e centro, fra periferia sentita come estraneo e dove si decide ciò che diventa normale.
Kiev ha già perso la Crimea; il Donbass è un’ombra che si estende fra guerra civile e occupazione, fra esercito regolare e milizie, fra identità che aspirano ad appartenere e identità che reclamano separazione. Cercare la salvezza in Europa, entrare nella NATO, dichiararsi filo‑occidentale significa volere un ordine che garantisca stabilità, protezione, riconoscimento. Ma quell’ordine non è mai neutro; è un ordine che provoca resistenze, che contiene ferite che crediamo rimarginabili, ma spesso non lo sono.
Se la crisi si risolvesse con la vittoria di Putin — con la vittoria cioè di quella forma oscura del potere che re‑verbalizza il “grande spazio”, la sfera d’influenza fatta presenza — allora l’Europa orientale diventerebbe il laboratorio in cui si sperimenta la dissoluzione di ciò che pensavamo irreversibile. L’Europa stessa, con le sue istituzioni, con i suoi trattati, con le sue parlamentazioni, entrerebbe in un crepuscolo di significato: basta la faccia feroce, il gesto puntuto, la minaccia, che l’Europa abbassa la testa, che la NATO tace, che l’America, lontana, guarda altrove.
Questo non è complottismo, non è metodo paranoico: è la storia che ritorna nella forma del possibile — non in quella della necessità. La storia non è un destino, ma è un campo aperto in cui le nostre scelte configurano orizzonti, dischiudono possibilità, rinviano altre. Così, se invece la crisi si concludesse con un compromesso diplomatico, sarebbe pur sempre una vittoria di Putin, benché temperata; eppure il rilievo non è tanto nella vittoria quanto nella capacità occidentale di mostrare qualcosa, un segnale, una soglia che si rifiuta, un limite che si difende.
Perché la politica estera — quando è tale — non consiste nel reagire, ma nel definire, nel dichiarare che non tutto è negoziabile, che non tutto è transitorio; che esiste un confine etico, un confine ontologico, oltre il quale non accada che l’esitazione sia già resa colpa, che la neutralità sia già resa connivenza, che il silenzio sia già resa assenza. È in questo confine che si gioca l’Europa: non nella sommatoria delle sue missioni estere, nelle sue dichiarazioni ministeriali che si fanno vani se non vengono incarnate, se non producono comunità, memoria, responsabilità.
L’Europa dovrebbe parlare con voce sola non come luogo del consenso tiepido, non come curatela del presente bensì come custode del possibile, come custode delle soglie. Quando accade che tutti i ministri degli esteri viaggino itineranti, con un occhio rivolto all’America, un altro all’energia, come accade troppo spesso, non è diplomazia: è prassi del camuffamento, è partecipazione all’ordine esistente con la speranza che non chieda troppo, che non costi troppo, che non esponga troppo. È l’arte del compromesso anticipato, della capitolazione preventiva.
Perché il ricatto energetico diventa limone spremuto se non si ha la forza di dire “no”. E dire no non è rifiuto della realtà; è rivendicazione dell’umanità, dell’autonomia minima che distingue fra chi accetta di essere subordinato e chi pretende di restare almeno interlocutore. Se il consumatore, la comunità, la collettività, dicessero “non consumo a prezzi stellari”, se il popolo europeo riprendesse a pensare che il benessere non è cifra del consumo ma termine di giustizia, allora l’ombrellone non sarebbe più metafora disimpegnata ma punto da cui partire, scena d’istanza, spazio in cui la persona, l’umanità, l’onore, il diritto reclamano significato.
L’America di Biden non è tanto diversa da quella di Trump, perché l’atto della potenza non può cambiare totalmente, può solo riformulare le priorità — la Cina, il Pacifico, le rotte commerciali, il riconoscimento internazionale — mentre l’Europa resta su un orizzonte periferico, una pedina, marginale, importante solo nella misura in cui si allinea, non in quella in cui decide. E qui, nella marginalità della decisione propria, sta la vera crisi: non nel fatto che altri giocano, ma che noi ci siamo ridotti a spettatori, non partecipi, a volte complici del governo del mondo che altri conducono.
In Italia, questa estraneità non è nuova. Il dialogo internazionale che proclamiamo è spesso rituale, simulacro; attento a non disturbare nessuno: non gli Stati Uniti, non l’Unione Europea, non la Russia, nemmeno la Turchia o la Libia. È una politica estera che si conviene, che si misura, che si pesa, ma che raramente pesa, che raramente incide, che raramente esige. Abbiamo cercato il sollievo, la stabilità formale, la figura rassicurante, più che la forma che desta, che interpella, che scuote. Pensiamo che basti essere benaccetti, che basti non offenderei, che basti non disturbare, per essere presenti. Ma essere presenti è esigere, pretendere, manifestare limiti, dire che non tutto può essere contenuto sotto l’ombrellone della diplomazia da salotto.
Il fatto che il governo adotti provvedimenti all’unanimità, per poi riservarsene la correzione in Parlamento, suggerisce qualcosa: che molte decisioni non sono realmente decisioni ma atti di gestione dello status quo, che l’unanimità è più spesso mimetica che sostanziale, che la voce comune è spesso solo la somma di voci che non osano dissentire. Se non erano d’accordo, perché li hanno approvati? E se lo erano, perché modificare? È questo balbettio, questo andare per iterazioni, per indecisioni, per aggiustamenti continui, che produce l’immagine di un paese che non si muove, che resta sotto l’ombrellone, aspettando che passi il temporale, che cambi il vento, che si riduca la marea.
Si ama Draghi non per le sue parole altisonanti, cioè anche per quelle, ma per la promessa implicita che esista un movimento, che esista una direzione, che esista un orizzonte che non sia solo ciò che si sopporta o si teme. Però se quel movimento si riduce all’allineamento, all’adesione formale, alla declamazione del principio senza l’atto che lo sorregge, allora Draghi, noi, l’Italia, restiamo sotto l’ombrellone del possibile, osservando il mondo che cambia altrove, mentre qui ci si interroga, ci si sposta, ci si difende, ma non si decide.
E la politica estera non è un lusso; non è questione per élite, non è oggetto da manuale diplomatico: è ciò che determina se l’ombra protegge o nasconde ciò che non vogliamo vedere. È ciò che decide se l’ombrellone sia un segno di identità, un segno di esistenza, un segno di responsabilità, o se sia la maschera dietro cui ci rifugiamo per non guardare, per non sentire, per non scegliere.
L’ombra, l’ombrellone, il confine sono insieme: ciò che ombreggia e ciò che divide, ciò che nasconde e ciò che rivela. E sotto quell’ombra, se siamo disposti, si può intravedere, non la chiarezza piena, ma quel lume minimo che serve: per scegliere, per dire no, per pretendere che l’Europa abbia non soltanto interesse ma dignità, non soltanto tutela ma autorità, che l’Italia non sia mero osservatore, ma parte che assume responsabilità, che parla, che decide.
Parlare con voce sola non significa gridare più forte, ma sentire che la parola, una volta detta, reclama essere coerente, che la politica estera sia pratica dell’assunzione, non della rinuncia, della soglia non della resa, che l’ombrellone sotto cui stiamo non sia solo ombra, ma segno che vogliamo di più: protezione che conserva libertà, comunità che non segue indifferentemente la corrente, identità che non si vergogna di essere parte del possibile.



















