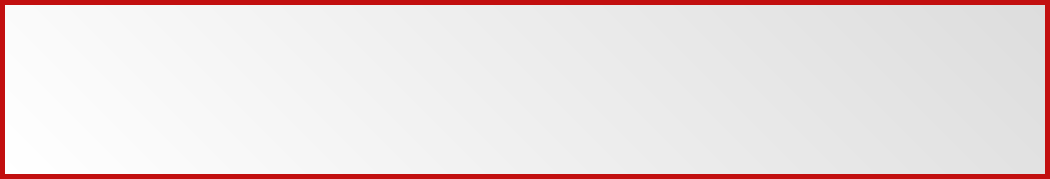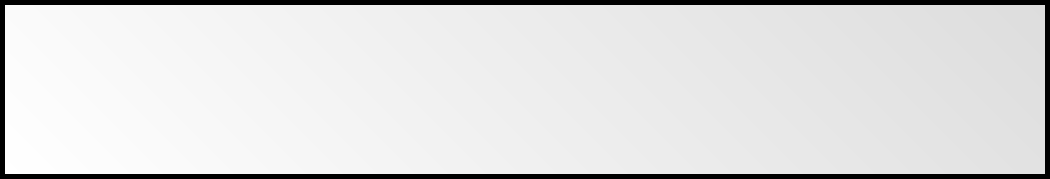Il mercato delle armi tra profitti e dinamiche di potere finanziario
Scritto da Agostino Agamben il . Pubblicato in Economia e Politica.
a cura di Agostino Agamben
Dalla crescita record delle esportazioni italiane al dominio consolidato degli Stati Uniti, passando per il crollo russo e le strategie di investimento nell’industria della difesa, un’analisi approfondita del sistema finanziario mondiale che si intreccia con il complesso mercato degli armamenti, tra rischi regolatori, innovazioni tecnologiche e l’irresistibile attrattiva dei profitti in tempi di conflitto e instabilità politica.
In un mondo dove il confine tra sovranità e violenza si dissolve in un perpetuo stato di eccezione, le esportazioni di armi delineano una mappa non solo geopolitica ma ontologica. Il recente rapporto del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) non registra soltanto numeri, ma la tessitura di un ordito invisibile che lega Stati Uniti, Francia, Russia, Italia, e tutti gli attori internazionali in un complesso meccanismo di potere e dipendenza. Se il dato numerico esprime la crescita del 21% delle esportazioni statunitensi, mentre quelle russe crollano del 64%, esso trascende la mera economia per rivelare un corpo politico globale che si ridisegna attraverso il mercato delle armi come dispositivo politico.
L’Italia, protagonista silenziosa ma imponente, si colloca ora tra i primi dieci esportatori mondiali, con una crescita vertiginosa del 138% nel quinquennio 2020-2024 rispetto al precedente. Questo balzo in avanti non è solo un risultato economico, ma una configurazione simbolica della sua nuova soggettività internazionale, che pur sacrificato nei giochi della guerra altrui, diviene tuttavia produttore e distributore di strumenti di morte. La sua quota del 4,8% nell’export globale si concentra nelle regioni in cui la conflittualità è più intensa e le tensioni più alte, il Medio Oriente in primis. Qatar, Egitto, Kuwait non sono solo destinatari ma nodi di un sistema che alimenta la continuità del conflitto e della dipendenza.
Nel mentre, gli Stati Uniti consolidano il loro primato con una quota del 43% sull’export mondiale, mostrando come l’“impero” non si limiti più a esercitare il controllo diretto sul territorio, ma si radichi nel dispositivo della produzione e della vendita di armamenti. L’arma qui non è mero strumento di guerra ma vettore di dominio, una forma di potere che determina chi vive e chi muore, chi può resistere e chi invece è lasciato nell’indistinto campo del sacrificio. È la definizione stessa di una “guerra infinita”, che si alimenta della continua produzione e distribuzione di strumenti di morte, in cui il mercato globale diviene teatro e motore insieme di conflitti che si intersecano e si sovrappongono.
Il ruolo dell’Europa appare segnato da una duplice ambivalenza: se da un lato si assiste a un aumento senza precedenti delle importazioni di armamenti, raddoppiate (+105%) nella Nato europea, dall’altro si palesa una dipendenza strutturale dagli Stati Uniti, che coprono il 64% di queste importazioni. È una relazione che racconta di una perdita di autonomia strategica e di un vincolo di alleanza che si manifesta nel continuo acquisto di caccia e sistemi avanzati, ma che non può non essere letto come l’espressione di un “potere sovrano” che si esprime più nella subordinazione che nell’autodeterminazione. Il soggetto europeo appare così non come protagonista, ma come dispositivo periferico di un sistema centrato altrove.
Il Medio Oriente, crocevia di tensioni globali, si conferma mercato privilegiato per l’esportazione italiana e statunitense. Nonostante una lieve diminuzione delle importazioni nella regione (-20%), quattro paesi restano tra i primi dieci importatori mondiali. Qui il dispositivo bellico diventa una sorta di “contratto sociale negativo”, dove la sovranità statale si regge sulla capacità di detenere il monopolio della violenza legittima, ma allo stesso tempo si manifesta come un equilibrio fragile, instabile e permeabile. L’industria italiana di armamenti, con i suoi sistemi missilistici, aerei da combattimento e navi, non è solo un attore economico, ma un soggetto politico che contribuisce a plasmare la geografia della guerra e della pace.
La Cina, emblema di un modello di sviluppo interno e autosufficiente, riduce drasticamente le importazioni (-64%), puntando sulla produzione nazionale. Il Giappone e il Pakistan, invece, intensificano gli acquisti, segnalando un riarmo senza precedenti. L’Asia e Oceania emergono così come la più grande area importatrice di armi, confermando come il riarmo globale non conosca pause né confini, ma sia piuttosto un processo continuo di ristrutturazione e ridefinizione degli equilibri di potere.
L’industria bellica si presenta come un sistema nervoso pulsante, un intreccio di capitali, tecnologie e strategie che risponde a una domanda crescente e mutevole. I ricavi delle prime cento aziende produttrici di armi hanno raggiunto nel 2023 i 632 miliardi di dollari, con incrementi significativi anche in Russia e Medio Oriente. Le grandi aziende statunitensi dominano la scena, mentre in Europa si osserva una crescita più contenuta, ma non per questo meno significativa, soprattutto in Germania, Svezia, Ucraina, Polonia e Repubblica Ceca, dove la domanda di munizioni e sistemi di difesa cresce in parallelo con le tensioni geopolitiche.
Il caso della tedesca Rheinmetall è paradigmatico: ampliando la produzione di munizioni e carri armati Leopard, essa incarna la trasformazione dell’industria bellica in una macchina di guerra economica e politica, capace di rispondere rapidamente ai mutamenti del campo di battaglia. La strategia degli “scambi di armi” tra paesi, che forniscono materiali militari a Ucraina e ricevono ricambi dagli alleati, rivela un sistema di interdipendenza e mutualismo nel segno della guerra.
Nel Medio Oriente, le aziende israeliane e turche mostrano una crescita vertiginosa, alimentata dai conflitti in Gaza e Ucraina. Il capitale bellico si trasforma così in una leva di potere regionale, una risorsa strategica da accumulare e impiegare in un contesto in cui la sicurezza diventa sinonimo di armamento e controllo.
La Corea del Sud e il Giappone sono protagonisti di un’accelerazione senza precedenti, con incrementi del fatturato del 39% e del 35% rispettivamente. La politica giapponese di rafforzamento militare dagli anni 2020 segna un cambio di paradigma che rompe con la tradizione post-bellica e si inserisce in un contesto di crescenti tensioni regionali.
Il mercato dell’industria bellica si configura come un investimento “sicuro” ma paradossale, in quanto fondato sulla produzione di strumenti di distruzione e morte. Le tensioni geopolitiche, le regolamentazioni e le controversie sono i confini di un campo di gioco in cui il capitale si muove incessantemente, creando una rete globale di relazioni complesse e ambivalenti.
Le azioni delle aziende di difesa sono sensibili ai contratti governativi e all’innovazione tecnologica, come l’introduzione di droni avanzati o sistemi missilistici. Ma queste dinamiche non sono solo economiche: esse raccontano di una mutazione del concetto stesso di guerra, da conflitto circoscritto a condizione permanente dell’umano contemporaneo.
La guerra diventa così una forma di “potere”, dove il potere si esercita non solo attraverso la violenza ma mediante la produzione, la distribuzione e il controllo delle armi. Questo “potere sovrano” globale si esprime attraverso la catena produttiva e commerciale delle armi, che a sua volta modella le relazioni internazionali, le alleanze, i conflitti.
Il concetto di sovranità si frantuma: non più il controllo esclusivo sul territorio o sul popolo, ma una soggettività dispersa e moltiplicata, fatta di dispositivi produttivi, scambi, interessi economici e politici. L’Italia, gli Stati Uniti, la Francia, la Russia, il Medio Oriente, l’Asia, non sono più entità isolate ma nodi di una rete globale di produzione e distribuzione che definisce i contorni del potere contemporaneo.
Il mercato delle armi diventa così un dispositivo attraverso cui il potere modella la vita e la morte, crea alleanze e conflitti, stabilisce gerarchie e dipendenze. È l’espressione concreta di un sistema in cui la violenza è normalizzata, istituzionalizzata e resa funzionale al mantenimento dell’ordine globale.
Il dato economico, allora, non è mero numero, è la manifestazione di una tensione, di un conflitto tra vita e morte, tra libertà e dominio, tra sovranità e sacrificio. Le esportazioni italiane, l’egemonia statunitense, la crisi russa, le rotte asiatiche, sono frammenti di un discorso più ampio che ci interroga sul senso della politica e del potere nel nostro tempo.
Il sistema globale delle armi ci parla di un’umanità divisa, sospesa tra la possibilità di pace e la necessità di guerra, tra la vita protetta e la morte esposta. In questo senso, il dispositivo bellico è specchio e motore di un mondo che si mantiene attraverso la violenza, che si regge su un equilibrio instabile di forze e contraddizioni.
Ecco allora che comprendere le dinamiche delle esportazioni di armi non è solo questione di geopolitica o economia, ma diventa esercizio di pensiero critico sul tempo presente, che siamo chiamati a decifrare dentro la rete del potere globale. La guerra infinita non è solo fuori di noi: è dentro il tessuto stesso delle nostre società, nei flussi invisibili che connettono produttori, mercati e poteri.
La sfida che resta aperta è quella di rompere questo circuito, di pensare un’alternativa alla logica del riarmo e della violenza strutturale, di immaginare un mondo in cui il potere non sia più esercitato attraverso la produzione e la distribuzione di strumenti di morte. Un mondo in cui la sovranità torni a essere sinonimo di vita e non di sacrificio.