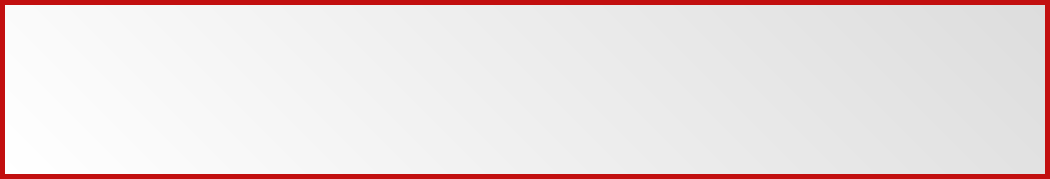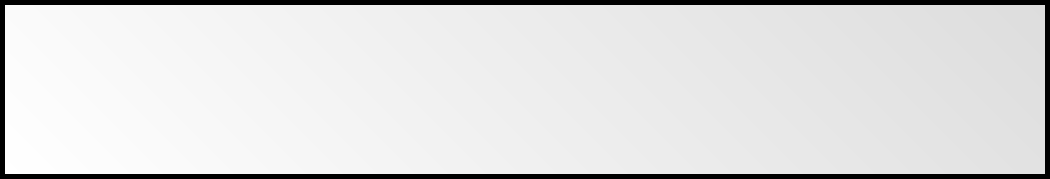Il rischio e il Mare
Scritto da Danilo Pette il . Pubblicato in Attualità.
Sotto il cielo disteso come un lenzuolo tiepido, trafitto dalla luce densa di un pomeriggio d’agosto, il mare di Ostia scivolava contro la riva con una calma antica, familiare, quasi domestica. Il vento, generoso ma discreto, faceva danzare le vele sulle tavole della scuola nautica, mentre le grida dei bambini si mescolavano al respiro lento e profondo del Mar Tirreno. Era una giornata qualunque e insieme irripetibile, come lo sono tutte le giornate in cui qualcosa cambia — anche solo un pensiero, una percezione, o un’idea.
Lei era lì, una bambina di nove anni, leggera come la tavola sotto i piedi, con gli occhi pieni di sale e di sogni. Indossava una muta troppo grande di una taglia, prestata dalla scuola. La cerniera ballava sulla schiena come una spina dorsale finta. Le maniche le finivano oltre i polsi, ma lei non se ne curava. L’equilibrio non le mancava, e nemmeno la curiosità. Si era alzata in piedi, lasciando che il vento le gonfiasse la vela come una promessa. Le mani strette, le braccia tese, il corpo oscillava tra il gioco e la concentrazione. Non c’erano pensieri — solo mare.
Poi, con la stessa naturalezza con cui il sole gira il cielo, è arrivato lui.
«Hai uno squaletto sotto la tavola», ha detto l’istruttore, e la frase è caduta nell’aria come una foglia in una pozza. Non era un allarme. Era quasi poesia. Come se avesse detto: “Hai un’ombra con la coda”, oppure: “Hai un compagno di giochi invisibile”.
La bambina ha guardato in basso. L’acqua era chiara, placida. Rifletteva la sua sagoma in controluce, e sotto quella sagoma ce n’era un’altra, più agile, più antica. Uno squaletto. Forse un verdesca, forse una di quelle creature del Mediterraneo che si spingono fino a riva solo quando qualcosa le attira. Forse la fame. O forse la dolcezza.
Non c’è stata paura. Nessun grido, nessun sussulto. Solo occhi grandi, aperti, uno sguardo che cercava di trattenere il momento. «È uno squaletto, sì», ha detto «ma non fa niente. È solo curioso». E la sua voce era come quella di chi racconta di una farfalla che si posa su una mano.
Aveva già visto squali. Nei libri, nei documentari di Ositn Levrn. A Cattolica, in galleria, con le voci che si abbassavano automaticamente all’arrivo del grande vetro curvo. A Barcellona, dove l’acquario sembrava una cattedrale e i turisti guardavano gli squali come reliquie sacre. Aveva imparato i nomi, le famiglie, le abitudini. Sapeva che alcuni dormono, nuotando, che altri partoriscono. Sapeva, ma non conosceva.
Ora sì. Ora conosceva. Questo non era un contenuto didattico. Questo era vero. Ed era lì, sotto di lei, in mare aperto.
L’istruttore non disse nulla. Restò in silenzio, a galleggiare a pochi metri, come se sapesse che non c’era nulla da aggiungere. Nessuna regola da ricordare. Nessun intervento. Solo presenza. E forse un po’ di gratitudine, anche da parte sua, per essere testimone di qualcosa che succede una volta sola.
La bambina non cercò di toccarlo. Non si mosse. Lo guardava. E basta.
«Lo so che possono essere pericolosi», ha detto. «Ma questo no. Questo si vede che è diverso. Si vede dagli occhi».
In quella frase, innocente e tremenda, c’era tutta l’infanzia. La capacità di leggere il mondo non con gli schemi, ma con le fibre e l’anima.
Il vento le scompigliava i capelli. La vela ondeggiava piano. Lo squaletto faceva piccoli cerchi, sempre più vicini alla riva. Sembrava che la guidasse. La tavola la seguiva senza resistenza. Come ipnotizzata. E lei non opponeva alcun controllo, lasciava fare. Né fuga, né ricerca. Solo essere.
Le venne in mente, all’improvviso, una visita fatta anni prima, con suo padre. Avevano preso la macchina all’alba, direzione nord. Lui voleva rivedere un amico, il suo ex comandante di pescherecci. L’uomo aveva una casa semplice, ma piena di oggetti marini. Nodi, reti, barattoli con conchiglie, e una mensola con denti grandi come dita. Erano denti di Squalo Bianco, porosi, irregolari, e un dente di squalo bianco come collana.
“Con tuo padre pescavamo anche i poveri squali” disse l’uomo.
Lei li aveva guardati con un misto di timore e ammirazione. Aveva chiesto a suo padre: “Ti manca la barca, papà?” E lui aveva risposto senza rispondere. “Certe cose non ti mancano. Ti restano dentro.”
Ecco, ora capiva.
Lo squaletto intanto ruotava lento, con movimenti antichi. L’istinto, forse, o solo il richiamo dell’ignoto. La bambina continuava a stare in piedi, diritta, senza pensare. Solo sentendo, quel silenzio – che non era mutismo, ma ascolto.
Anche sua madre parlava spesso del mare. Con un modo tutto suo. Diceva che aveva sempre avuto un rapporto strano con l’acqua: attratta, ma con diffidenza. “Il mare ti chiama, ma non ti spiega.” Le diceva spesso che il suo nome indiano, in Italiano suonava quasi come “pesci”. Lei non capiva, ma la frase le restava dentro come una rima che non si dimentica.
La bambina invece si chiamava Agnese, come quella canzone di Ivan Graziani. L’aveva ascoltata tante volte dalla radio vecchia del padre, quando sistemava stoffe o puliva i coltelli. Una canzone malinconica, con parole che facevano male anche senza capirle tutte. Parlava di un amore mai vissuto, di un bacio mancato, di biciclette all’alba. Di un barcone rovesciato, di una ragazza color cioccolata che non si dimentica. Ogni volta che la sentiva, Agnese chiudeva gli occhi, come se fosse lei quella ragazza.
E ora stava lì, al largo di Ostia, con un squaletto che le girava intorno come un ricordo che arriva prima di esistere.
Agnese aveva un quaderno a casa, con tutti gli animali marini che aveva visto. Li disegnava male, ma li scriveva bene. Aveva nomi difficili: Rhizoprionodon, Hexanchus, Cetorhinus. Ma gli occhi… quelli li disegnava grandi, e mai cattivi. Gli occhi degli squali l’avevano sempre colpita. Non erano vuoti.
Ora uno di quegli occhi la guardava da sotto.
«Non ha paura di me», ha pensato. «E io non ho paura di lui, conosco bene la paura quando faccio le gare di judo». Una frase senza grammatica, pura. Come solo i bambini e i poeti sanno avere.
Lo squaletto si allontanò piano, dopo qualche altro giro. Nessuna fuga, nessun segnale. Solo il compimento di qualcosa, come se sapesse che bastava così. Agnese lo seguì con gli occhi finché poté. Poi lasciò che la vela riprendesse a guidarla.
Non disse nulla. Non subito. Né all’istruttore, né agli altri. Rimase lì, finché il tempo non tornò a scorrere. Poi rientrò, si tolse la muta e si avvolse nell’asciugamano. Prese un gelato e si sedette sulla sdraio.
«Era bello», disse. Solo questo, nessuno le chiese altro.
Quando la sera cadde sul lungomare, e le prime ombre si stesero sui marciapiedi, raccontò tutto
a suo padre. «Papà, oggi ho visto uno squalo». Lui rise. “Davvero?” Ma poi vide i suoi occhi. E smise di sorridere. “Era grande?” Agnese scrollò le spalle. “Era giusto. Era quello che doveva essere.”
Camminarono in silenzio, lungo la battigia. Il rumore dei piedi sull’acqua bassa sembrava un’orchestra lontana. Agnese si chinò a raccogliere una conchiglia. Era piccola, bianca, bucata al centro. La guardò. Se la mise in tasca. Non come un trofeo, ma come una promessa. Forse, un giorno, sarebbe diventata una biologa marina. Forse no. Forse avrebbe solo continuato ad amare il mare. A cercarlo nei sogni. A scriverne, forse.
Il mare, intanto, continuava senza sapere, senza curarsi. Continuava.
Il Tirreno — antico, stanco, stuprato — aveva ancora dentro, ogni tanto, la grazia. La grazia di offrire meraviglia, di offrire qualcosa che non si può comprare. Un piccolo squalo, una piccola bambina. Un incontro breve come un lampo, ma eterno come una prima parola.
Agnese, quel giorno, non imparò a virare. Non migliorò la postura. Ma imparò che la natura non chiede approvazione. Chiede solo silenzio. Chiede occhi aperti. Chiede meraviglia. E se trova qualcuno disposto ad ascoltare, anche solo per un attimo, si rivela.
E in quell’attimo c’è tutto.
a cura di Danilo Pette