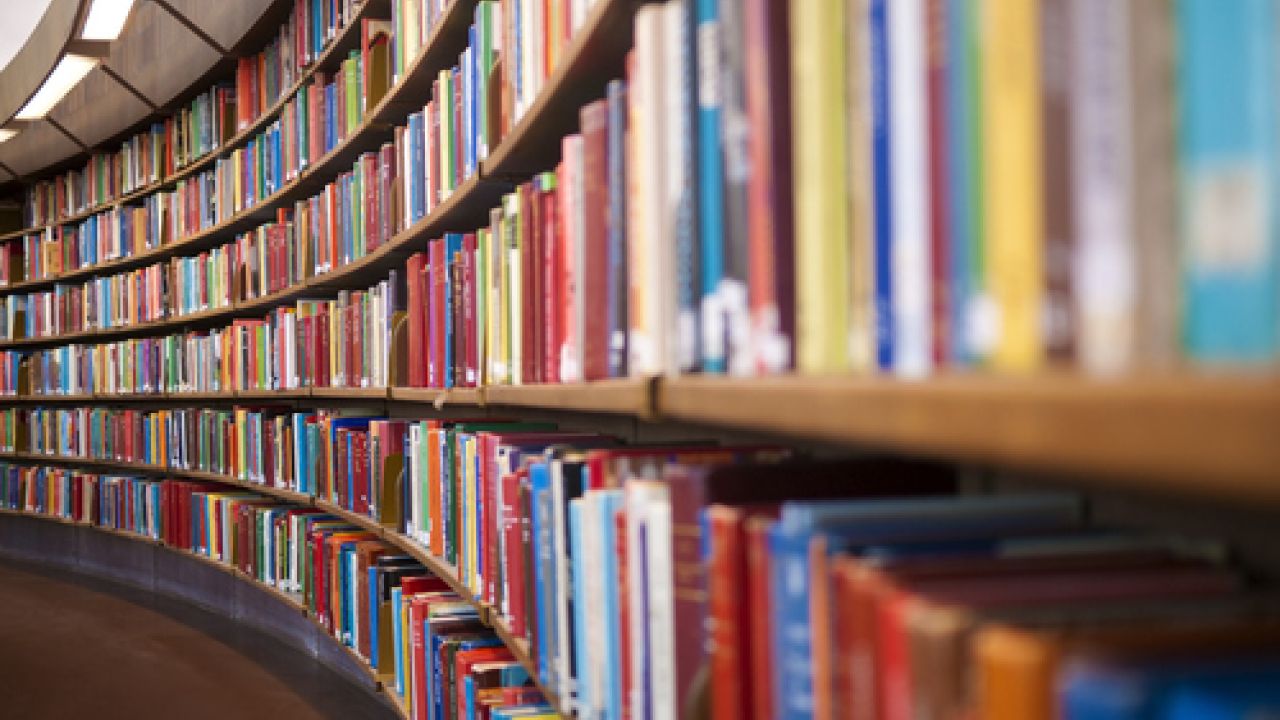
“La lettura come esercizio di sparizione”
Scritto da Agostino Agamben il . Pubblicato in Arte, Cultura ed Eventi, Libri, Media e Rassegna Stampa.
Oltre la memoria e l’utilità, leggere non per trattenere ma per essere trasformati: una meditazione sul tempo, sull’esperienza e sulla verità che scorre come acqua tra le dita. Come il setaccio che si purifica perdendo ciò che non può trattenere, così il lettore si affina lasciandosi attraversare da ciò che dimenticherà — e proprio in questo atto di svuotamento si compie la vera conoscenza.
Ho letto moltissimi libri, ma ho dimenticato la maggior parte di essi. Ma allora qual è lo scopo della lettura?
Non esiste domanda più ingenuamente radicale di questa, proprio perché essa, nel suo apparente candore, dischiude l’intero paradosso dell’esperienza umana: l’impossibilità di trattenere ciò che più profondamente ci modifica. Nessuna delle esperienze fondamentali della vita — l’amore, la sofferenza, la contemplazione, la morte — è mai interamente trattenibile o replicabile. Come l’acqua che scorre tra le dita, esse lasciano una traccia senza lasciare nulla. Non possiamo possedere l’amore, né conservare la gioia. Non possiamo ricordare fedelmente il dolore, se non come forma svuotata, eppure esso ci plasma più di qualunque teoria. Allo stesso modo, non leggiamo per ricordare, ma per essere trasformati.
L’immagine del setaccio che si ripulisce mentre perde l’acqua è, in questa direzione, più che una parabola didattica. È una figura dell’esperienza, un’epifania del tempo e del pensiero. In essa si manifesta il gesto di una verità che non si lascia fissare né archiviare, ma che proprio nella sua inafferrabilità compie l’essenziale. Ogni lettura autentica, come ogni esperienza vera, è un gesto che si perde mentre si compie, ma che — proprio in questo perdersi — mostra ciò che è: un attraversamento, un passaggio, un chiarore.
La memoria, come l’ha compresa Aristotele, non è un deposito neutro ma un’attività dell’anima. Non è il luogo della conservazione, bensì della ri-attivazione. Ricordare non è possedere il passato, ma farlo tornare presente nella sua assenza. E leggere, in fondo, è un modo particolare di ricordare: non di fatti, ma di forme; non di eventi, ma di possibilità. Il libro non è mai un contenitore di informazioni, ma un dispositivo di potenzialità. Ciò che esso produce non è un sapere determinato, ma una mutazione impercettibile dell’essere. In questo senso, il lettore è un setaccio che, proprio mentre fallisce nel trattenere l’acqua, si rende capace di lasciarsi purificare da essa.
È significativo che il luogo della rivelazione in questa storia sia un fiume. L’acqua, il setaccio, la corrente: la verità si presenta sempre in forme che sfuggono alla presa. Si direbbe che l’unico modo per accostarsi ad essa sia attraverso ciò che non si può trattenere. L’essenziale non è mai nell’oggetto, ma nel gesto; non nella permanenza, ma nell’atto del passaggio. La conoscenza, come l’acqua, non si conserva, ma purifica. Essa non si accumula, ma trasforma. Non ci appartiene, ma ci accade.
Il giovane allievo, nella sua perseveranza, mostra già la condizione del discepolo autentico: egli non capisce, ma compie. Non interroga per ottenere una risposta, ma per rimanere nel vuoto dell’attesa. La pedagogia, se ha un senso, non è la trasmissione di contenuti, ma la generazione di una disposizione. L’educazione non informa, ma trasforma. E il Maestro, in quanto tale, non risponde, ma attende. Il suo silenzio non è una mancanza, ma un gesto di fiducia nella temporalità dell’apprendimento. Egli sa che il tempo della comprensione non coincide con quello della parola. La verità non si dà tutta in un istante, ma richiede una preparazione invisibile, come il lavarsi di un setaccio.
Il sapere che dimentica se stesso, il sapere che si perde nel suo compiersi, è forse la forma più alta del sapere. Perché solo ciò che si dimentica veramente ci appartiene. Solo ciò che si dissolve nel nostro essere ne modifica la struttura. La lettura è un esercizio di sparizione, un’arte del perdere. E tuttavia, in questo perdersi, essa lascia un’impronta, un’impronta senza forma, una luce che non è più distinguibile da ciò che siamo diventati. La conoscenza vera non è ciò che si ha, ma ciò che si è.
Non a caso, nella filosofia antica, l’esercizio della lettura non era disgiunto dalla pratica della vita. Leggere non significava accumulare opinioni, ma convertirsi. Non si trattava di sapere di più, ma di essere altrimenti. In questo senso, leggere è un esercizio spirituale. Non perché elevi lo spirito in senso moralistico, ma perché coinvolge l’intera forma della vita. Ciò che leggiamo — anche quando lo dimentichiamo — lavora in noi. Come l’acqua che scorre attraverso il setaccio, lavora nel profondo, rimuove le incrostazioni, prepara lo spazio di una ricettività nuova.
E tuttavia, oggi, la lettura è diventata un atto secondario, marginale, subordinato alla produzione di contenuti. Si legge per informarsi, per aggiornarsi, per essere competitivi. Il libro è ridotto a supporto, la parola a veicolo. Ma la lettura non è uno strumento. Essa non serve. Come l’amore, come l’amicizia, essa ha valore solo se non ha utilità. L’inutilità della lettura è la sua verità. Chi legge davvero, legge perché non può farne a meno, perché in quel gesto riconosce qualcosa della propria forma. Non si tratta di ottenere qualcosa, ma di restituirsi a se stessi. Leggere è, in questo senso, un ritorno. Un ritorno a ciò che siamo prima di ogni sapere, prima di ogni identità.
La parabola del setaccio e dell’acqua non è solo una riflessione sul leggere. È una meditazione sull’essere. Ogni identità, se è tale, è un processo di pulizia. Non si diventa sé stessi aggiungendo, ma togliendo. Non si è chi si è per accumulo, ma per svuotamento. L’acqua del fiume è il tempo. Il setaccio siamo noi. Ogni passaggio del tempo attraverso di noi è un’occasione di trasformazione. Non per diventare altro, ma per diventare più propriamente noi stessi. Il tempo non ci invecchia, ci affina. Non ci consuma, ci purifica. Solo se accettiamo di non trattenere possiamo essere rinnovati.
Lettura e tempo sono dunque inseparabili. Si legge nel tempo, ma anche contro il tempo. Ogni libro è una forma di resistenza alla dispersione, una tentazione di eternità. Eppure, anche questo tentativo è destinato a fallire. Ogni libro, anche il più grande, sarà dimenticato. Anche il più bello scomparirà. Ma ciò che avrà prodotto nel lettore — quel gesto impercettibile, quella piccola apertura — resterà. E non sarà visibile. Sarà come il setaccio pulito: non sarà possibile dire dove e come è avvenuta la trasformazione. Ma essa avrà avuto luogo.
Nel pensiero cristiano delle origini — e Agostino lo sapeva bene — l’interiorità non è uno spazio da riempire, ma da liberare. Non si tratta di accumulare concetti, ma di aprire la mente e il cuore alla Presenza. La lettura, come la preghiera, è un esercizio di svuotamento. Non serve a sapere di più, ma a desiderare meglio. Non forma dei contenuti, ma una postura dell’anima. La lettura, come la contemplazione, è una pratica del silenzio: non il silenzio dell’assenza, ma il silenzio che prepara l’incontro. E questo incontro, come ogni incontro vero, è sempre senza parole.
Si potrebbe dire che il libro è un setaccio inverso: esso trattiene solo ciò che il lettore è disposto a perdere. Le parole che rimangono non sono quelle che ricordiamo, ma quelle che ci hanno attraversato. Come il dolore, come l’amore, anche la verità si riconosce solo nel momento in cui svanisce. È nell’atto del distacco che essa si mostra per quello che è. La lettura è una forma di distacco. Da sé, dal mondo, dal tempo. Ma è anche un ritorno. Al mondo, a sé, al tempo — ma in una forma nuova.
La domanda dell’allievo è dunque una domanda vera. Ma non perché attende una risposta, quanto perché apre lo spazio di una interrogazione che non
si chiude. Che senso ha leggere se dimentichiamo tutto? Che senso ha vivere, se tutto finisce? Che senso ha amare, se ogni amore si consuma? Il senso non sta nel risultato, ma nel gesto. Non nel possesso, ma nella partecipazione. La vita, come la lettura, è un setaccio: ci attraversa e ci plasma, mentre nulla rimane nelle mani.
Potremmo dire, parafrasando Wittgenstein, che il senso della lettura è nel gesto del leggere stesso, così come il senso della vita è nel suo svolgersi. Non serve cercare un fine, poiché il fine è già nel presente. Ogni volta che leggiamo, siamo già nella verità. Non perché la comprendiamo, ma perché la abitiamo. La lettura è un abitare. Non uno spazio, ma un tempo. Un tempo denso, sospeso, in cui accade qualcosa di invisibile e reale.
Ed è forse proprio questa invisibilità che spaventa l’uomo moderno. Egli vuole trattenere, archiviare, catalogare. Ma la lettura non si lascia archiviare. Essa sfugge, come ogni cosa viva. Il sapere vivo è quello che si dimentica, perché vive nel gesto. Il sapere morto è quello che si conserva, ma non trasforma più. Ogni lettura autentica è un rischio: il rischio di essere cambiati senza sapere come. Ma solo in questo rischio si dà la possibilità della salvezza.
Ecco perché i veri lettori non sono mai dei professionisti del sapere, ma dei dilettanti nel senso etimologico del termine: coloro che leggono per diletto, cioè per amore. Non per dovere, ma per desiderio. Non per possedere, ma per essere toccati. Il diletto della lettura non è un piacere superficiale, ma una forma di intimità con ciò che ci trascende. Leggere, allora, è come pregare. Non si sa mai se si è stati ascoltati, ma qualcosa accade. Non si sa mai cosa si è ottenuto, ma si è diversi.
Non ci resta, forse, che accettare la lettura come accettiamo la vita: come un dono che si consuma nell’atto stesso del riceverlo. E se qualcosa resta — come il setaccio lavato dall’acqua — non sarà mai ciò che abbiamo scelto di trattenere, ma ciò che ha scelto noi.


















