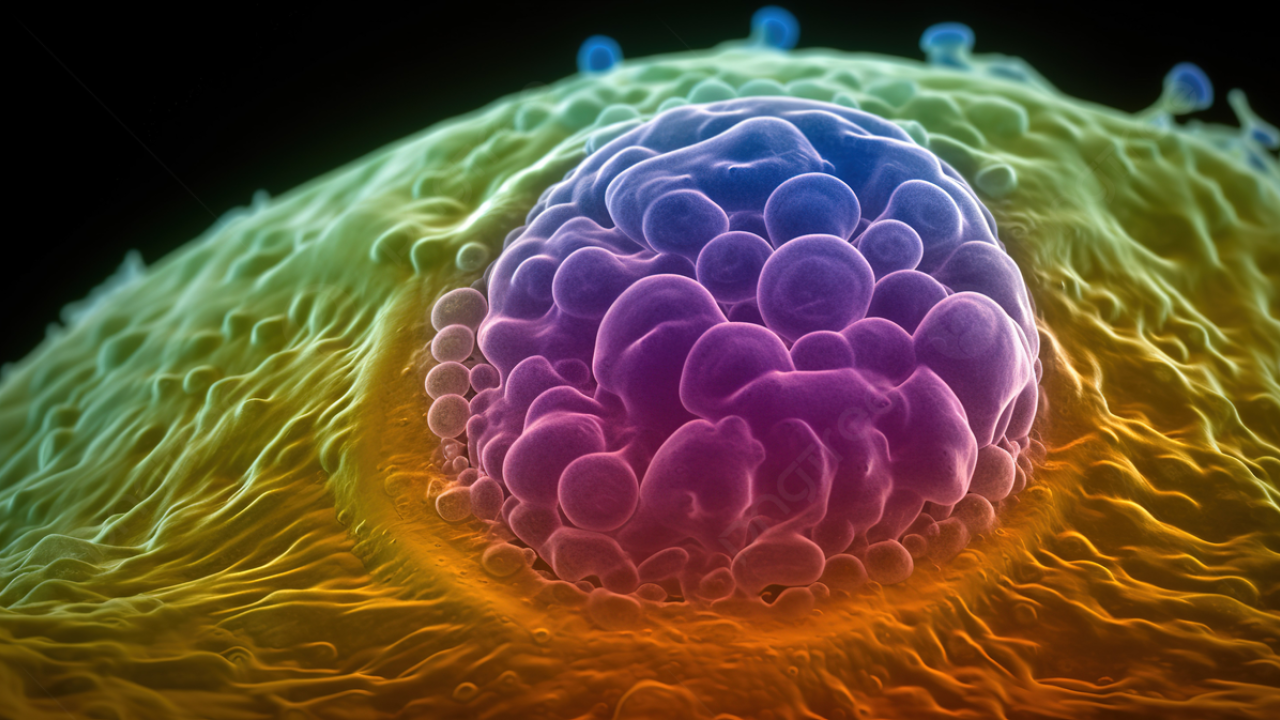
La Morte del Pensiero Verso l’Illusione del Sapere
Scritto da Danilo Pette il . Pubblicato in Attualità.
La Morte del Pensiero Filosofico, decerebrazione Umana negli Ultimi 80 Anni, l’Occidente e il Resto del Mondo
Un’analisi del declino del pensiero filosofico nella società contemporanea e le sue implicazioni globali
Negli ultimi ottant’anni, la filosofia ha attraversato una fase di progressivo svuotamento. Non si tratta solo di un declino epistemologico o della sua perdita di centralità nelle scienze e nelle discipline umanistiche, ma di una vera e propria “morte” intellettuale, che ha visto il pensiero filosofico relegato a un angolo oscuro del sapere umano, lontano dalle domande fondamentali che un tempo definivano il corso delle società. Questo fenomeno non è limitato all’Occidente, ma ha avuto ripercussioni globali, con la filosofia ridotta a un accessorio intellettuale in molte altre tradizioni culturali e mondi. Come si è giunti a questo punto, e quali sono le cause e le implicazioni di questa morte intellettuale? Questo micro saggio intendo esaminare il fenomeno del declino della filosofia negli ultimi decenni, analizzando in particolare l’Occidente, ma anche guardando al resto del mondo, dove la colonizzazione intellettuale ha svolto un ruolo cruciale.
Il Declino della Filosofia nell’Occidente Moderno
L’Apoteosi della Razionalità Strumentale
Il cuore pulsante della filosofia occidentale è sempre stato la ricerca della verità. A partire da Platone, Aristotele e gli altri grandi pensatori greci, la filosofia ha cercato di rispondere alle domande fondamentali sull’esistenza, sull’essere, sulla moralità e sulla giustizia. Tuttavia, negli ultimi cento anni, la filosofia occidentale ha subito una graduale metamorfosi. Se un tempo la riflessione filosofica era la base su cui si costruivano i sistemi di pensiero sociali, politici ed economici, oggi essa è stata marginalizzata e sostituita dalla razionalità strumentale, un tipo di ragionamento che cerca esclusivamente l’efficacia e l’utilità immediata.
L’apoteosi della razionalità strumentale ha avuto inizio con la Rivoluzione Industriale e ha preso forma piena nel Novecento, grazie agli sviluppi delle scienze naturali, della tecnologia e dell’economia. La filosofia, che in passato cercava di interrogarsi sul senso dell’esistenza e sulla giustizia, è stata gradualmente relegata in secondo piano, mentre le scienze e la tecnica hanno guadagnato sempre più terreno, diventando la forza trainante nella costruzione della realtà. La filosofia si è così trovata a dover rispondere a sfide che non poteva più vincere: da un lato, l’ascesa delle scienze naturali e sociali, dall’altro la richiesta sempre più pressante di soluzioni pratiche e immediate ai problemi globali.
Il risultato è che la filosofia, come disciplina, è diventata una sorta di “luogo della nostalgia”, un regno di pensieri teorici distaccati dalla realtà quotidiana. Oggi, è difficile trovare un filosofo che riesca ad avere un impatto significativo sul pubblico generale o sulla politica. Le grandi questioni filosofiche, che un tempo alimentavano dibattiti accesi e contribuivano a definire le sorti delle società, sono state sostituite da analisi tecniche, legate a un linguaggio specialistico che allontana il pubblico dalla riflessione teorica e dalla ricerca del senso.
La Filosofia Universitaria e la Sua Rilevanza Ridotta
Una delle cause principali di questa morte intellettuale della filosofia è la sua istituzionalizzazione nelle università. Mentre un tempo la filosofia era alla base della formazione civica e politica dei cittadini, oggi essa si è ridotta a una materia di nicchia, insegnata da accademici che raramente hanno un impatto al di fuori della loro cerchia. Le università stesse sono diventate luoghi di “specializzazione” dove la ricerca filosofica si concentra su ambiti sempre più ristretti, lontani dalle questioni centrali dell’esistenza umana.
La crescente separazione tra la filosofia e la vita quotidiana ha avuto un effetto devastante sulla sua capacità di contribuire alla costruzione di un pensiero critico nella società. La filosofia accademica oggi tende a concentrarsi su temi marginali, esaminando problemi teoretici che non hanno una connessione immediata con le sfide sociali e politiche contemporanee. La riflessione filosofica si è quindi trasformata in un’attività autoreferenziale, che interessa solo a un piccolo gruppo di studiosi, piuttosto che al grande pubblico.
In questo contesto, la filosofia ha perso la sua forza dirompente. Le sue tradizioni più vitali – la critica radicale, l’interrogazione costante del potere, l’analisi delle ingiustizie sociali – sono state smorzate dalla burocrazia accademica e dalla necessità di “prodotti” intellettuali che possano essere pubblicati e valutati. La filosofia non è più una guida per l’azione politica o sociale, ma una disciplina che si preoccupa più delle sue metodologie che delle implicazioni pratiche dei suoi concetti.
Il Potere della Tecnologia e la Scomparsa delle Grandi Domande
Un altro fattore che ha contribuito al declino del pensiero filosofico è il dominio delle tecnologie e delle scienze applicate. La tecnologia moderna ha permeato ogni aspetto della vita quotidiana, e la filosofia, incapace di rispondere alle sfide imposte dalla scienza e dalla tecnica, ha progressivamente perso il suo ruolo di guida nella comprensione del mondo.
Oggi la tecnologia è diventata la forza motrice del progresso umano. Le innovazioni tecnologiche non solo hanno trasformato il modo in cui viviamo, ma hanno anche cambiato la natura stessa della conoscenza. La velocità con cui l’informazione viene prodotta e consumata ha ridotto la capacità delle persone di riflettere in modo critico. Gli algoritmi dei social media, la pervasività della comunicazione istantanea e il dominio della logica economica hanno creato una cultura dell’informazione che premia la rapidità e la superficialità.
In questo panorama, la filosofia sembra irrilevante. Le grandi questioni esistenziali, che una volta erano al centro del pensiero umano – come il significato della vita, la natura della libertà, il fondamento della giustizia – sono diventate secondarie rispetto ai problemi pratici e immediati. L’individuo contemporaneo, immerso nella continua produzione e consumo di contenuti digitali, ha perso la capacità di interrogarsi su questi temi. La filosofia non riesce più a parlare alla società in modo diretto e significativo, e la sua “morte” sembra ormai definitiva.
La Colonizzazione Intellettuale e la Filosofia Globale
La Perdita delle Tradizioni Filosofiche Locali
Il declino della filosofia occidentale non è un fenomeno limitato ai confini dell’Europa o degli Stati Uniti. Anche nel resto del mondo, la filosofia ha subito un processo di marginalizzazione, spesso attraverso la colonizzazione intellettuale delle tradizioni locali da parte delle idee e dei sistemi di pensiero occidentali. In Asia, in Africa e in America Latina, le tradizioni filosofiche indigene sono state progressivamente erose e sostituite dalle filosofie eurocentriche, che hanno imposto un’idea di razionalità e progresso che non rispecchia le visioni del mondo locali.
In Asia, ad esempio, la filosofia indiana, cinese e giapponese, che un tempo si basava su visioni olistiche dell’esistenza e sulla meditazione come mezzo di conoscenza, è stata svuotata di significato a favore di approcci più pragmatici e utilitaristici. La tradizione indiana, con il suo profondo interesse per il karma, il dharma e la liberazione (moksha), è stata ridotta a un’idea di psicologia e benessere personale, e in molte parti del mondo, i concetti filosofici sono stati tradotti e adattati a un linguaggio che risponde alle esigenze del consumismo globale.
Anche in Africa, molte delle tradizioni filosofiche locali, che si basavano su concezioni collettivistiche del mondo e sulla connessione profonda con la natura, sono state influenzate dalle ideologie occidentali. La colonizzazione intellettuale ha spinto i pensatori africani a fare i conti con una filosofia che spesso negava le loro stesse radici culturali. Ciò ha portato a una distorsione del pensiero filosofico, in cui la visione del mondo europea è stata imposta come la norma universale, mentre le tradizioni locali sono state considerate primitive o inferiori.
La Filosofia e il Nuovo Ordine Mondiale
Nel contesto della globalizzazione, la filosofia ha perso la sua funzione critica. La dialettica tra le culture, che un tempo alimentava il confronto e la discussione, è stata ridotta a una serie di dibattiti marginali, privi di reali implicazioni per la costruzione di un mondo più giusto e solidale. Le tradizioni filosofiche locali, purtroppo, sono state assimilate in un ordine mondiale che non lascia spazio alla diversità di pensiero. La filosofia, quindi, ha subìto una “globalizzazione” che l’ha resa omogenea e incapace di rispondere alle questioni urgenti del nostro tempo.
In un mondo in cui il neoliberismo domina le politiche economiche, la filosofia sembra non avere alcuna influenza sulle decisioni che plasmano la nostra realtà quotidiana. La mancanza di un pensiero critico globale che sfidi le disuguaglianze economiche e sociali è uno dei principali motivi per cui il pensiero filosofico è morto. L’umanità sembra essersi rassegnata all’idea che non ci sia una via d’uscita dai problemi attuali. La filosofia, una volta in grado di pensare alternative al sistema sociale, politico ed economico, è oggi diventata un’ombra di sé stessa.
La Filosofia come Possibilità di Rinascita
Se la morte del pensiero filosofico sembra una realtà ineluttabile, non possiamo ignorare il fatto che la filosofia è sempre stata capace di rinascere in momenti di crisi. La filosofia è sopravvissuta alla caduta dell’Impero Romano, alla dominazione medievale, e anche alla Rivoluzione Scientifico-Industriale. Non c’è motivo di credere che oggi la filosofia debba essere definitivamente condannata.
In effetti, il nostro tempo potrebbe essere uno dei più adatti alla rinascita della filosofia. In un’epoca caratterizzata da incertezze politiche, economiche e ambientali, la filosofia potrebbe riacquisire il suo ruolo di forza critica, capace di sfidare le convenzioni e le strutture di potere. Se solo l’umanità avesse il coraggio di riscoprire la profondità del pensiero filosofico, sarebbe possibile costruire una visione del mondo più giusta, dove la riflessione non è un esercizio intellettuale fine a sé stesso, ma uno strumento di cambiamento sociale.
La filosofia potrebbe, infatti, tornare a essere una forza politica, capace di risvegliare una coscienza collettiva e di offrire risposte a domande esistenziali che oggi sembrano dimenticate. La morte della filosofia, se davvero c’è stata, potrebbe dunque essere solo un’apparenza, una fase transitoria di una riflessione che è destinata a ritrovare la sua vitalità in un mondo che ha bisogno più che mai di nuove idee e di un pensiero critico capace di sfidare le ingiustizie.
L’Epistemologia Vuota: La Distanza dal Sapere Profondo
Uno degli sviluppi più preoccupanti negli ultimi decenni è il progressivo svuotamento dell’epistemologia, ovvero la disciplina che si occupa della natura, dei limiti e della giustificazione del sapere. La ricerca filosofica tradizionale sull’origine e sulla validità del conoscibile, che un tempo animava discussioni fondamentali, si è evoluta in un’arena sterile, ridotta a un esercizio tecnico senza una direzione chiara.
Questa trasformazione ha portato a un’epistemologia “vuota”, che si limita a trattare il sapere come un insieme di tecniche e strumenti, piuttosto che come una comprensione profonda della realtà e dell’essere umano. I grandi interrogativi su come e perché conosciamo, su cosa significhi sapere qualcosa in modo autentico, sono stati relegati in un angolo oscuro, se non dimenticati del tutto.
La nuova epistemologia si concentra su modelli matematici, algoritmi e approcci riduzionisti che, sebbene abbiano prodotto risultati tecnologici straordinari, non rispondono più alle domande profonde che hanno da sempre caratterizzato il pensiero filosofico. L’interesse principale è orientato alla validità operativa della conoscenza, piuttosto che al suo valore ontologico o etico. In questo contesto, la filosofia della conoscenza si riduce a una serie di problemi tecnici, separati dalle esperienze reali delle persone e privi di una connessione autentica con le loro vite quotidiane.
L’epistemologia vuota non ha più una comprensione chiara dei fondamenti del sapere. Non si interroga più su cosa giustifica una verità o su come la nostra mente possa accedere alla realtà. Le filosofie cognitive e le neuroscienze, pur essendo contributi importanti, hanno progressivamente sostituito la riflessione filosofica classica, con il rischio che il sapere stesso venga ridotto a una mera funzione biologica o psicologica. La cultura della superficialità, dell’informazione istantanea e delle tecnologie dell’intelligenza artificiale contribuisce a creare una distorsione della conoscenza, in cui il sapere viene prodotto in serie, privo di radici profonde e lontano dalla ricerca di un senso universale.
In un mondo dove la verità è spesso determinata dalla velocità con cui si può produrre e distribuire informazione, l’epistemologia ha perso la sua missione critica. In passato, la filosofia si è occupata di rispondere alla domanda “cosa possiamo veramente sapere?”, ma oggi questa domanda è stata soppiantata dal bisogno di accumulare dati, di ottimizzare il processo cognitivo e di rendere il sapere il più produttivo e funzionale possibile. Il risultato è una forma di conoscenza priva di profondità e di significato, un sapere che è tecnicamente valido ma esistenzialmente vuoto.
Una Storia della Filosofia Vuota: La Perdita delle Radici e dell’Insegnamento Critico
L’altro aspetto cruciale di questo declino filosofico riguarda la trasformazione della storia della filosofia. Quella che un tempo era una disciplina viva, capace di interagire con le domande e le sfide del presente, è oggi una narrazione staccata dalla realtà, una cronaca di “pensieri morti” privi di vera applicazione. La storia della filosofia si è svuotata della sua potenza dialettica, diventando un elenco di autori e scuole, senza più il vigore che una volta le permetteva di trasformare la nostra comprensione del mondo.
La storia della filosofia, nelle università e nei testi accademici, è diventata un luogo di conservazione, non più di innovazione. Gli autori vengono studiati, ma raramente letti criticamente per capire come possano influenzare o stimolare la riflessione contemporanea. Si parla di Hegel, Marx, Kant o Nietzsche, ma quasi mai per portare avanti le loro domande o rispondere ai problemi che sollevano. La filosofia viene quindi ridotta a un mero “museum” di pensieri, senza il dinamismo che l’ha caratterizzata nei secoli. Non si esplora più la tensione tra le visioni del mondo, ma si presentano come se fossero teorie statiche e risolte, lontane dai fermenti di un dibattito filosofico vivo.
In questo contesto, la storia della filosofia è divenuta una mera catalogazione di pensatori e correnti, spesso inquadrata in schemi ideologici che la separano dal nostro presente. Non più la riflessione sui grandi temi esistenziali e sociali, ma solo una descrizione cronologica, accademica e priva di applicazione. La filosofia, anziché essere un motore di cambiamento e di contestazione, diventa una disciplina di rievocazione passiva.
Tale visione della storia della filosofia porta con sé il rischio che le domande fondamentali sulla giustizia, sulla libertà, sull’etica, sull’essere, vengano ignorate. L’umanità perde così il contatto con la sua capacità di riflettere profondamente su se stessa. La filosofia non è più vista come la possibilità di “mettere in discussione” la realtà, ma come un deposito di concetti e di pensieri privi di forza. La lettura delle opere filosofiche, che un tempo era un’esperienza formativa e liberatoria, diventa una formalità accademica, che non contribuisce alla crescita individuale e collettiva.
La Perdita di Significato e la Possibilità di Rinascita
La combinazione di un’epistemologia vuota e di una storia della filosofia vuota rappresenta un doppio colpo mortale per il pensiero filosofico. Senza una riflessione profonda su cosa possiamo sapere e senza una visione viva della tradizione filosofica che permetta di affrontare le sfide del presente, la filosofia rischia di diventare una disciplina irrilevante, incapace di rispondere ai dilemmi esistenziali, politici e morali della nostra epoca.
Tuttavia, come accennato in precedenza, la filosofia ha una capacità intrinseca di rinascita. Se oggi ci troviamo di fronte a un pensiero filosofico frammentato e privo di vigore, non è detto che ciò debba segnare la fine della riflessione. Le filosofie, per quanto indebolite, possono ancora fungere da strumento per interrogarsi sulla condizione umana, per rivisitare le tradizioni e per proporre nuove visioni che possano rispondere alle domande più urgenti della nostra epoca.
Una rinascita della filosofia non richiede solo un ritorno ai classici, ma una ripresa del pensiero come pratica viva, capace di rinnovarsi e di rispondere alle sfide moderne. La filosofia deve tornare a essere un percorso che ci sfida, che ci spinge a mettere in discussione ciò che diamo per scontato, che ci aiuta a comprendere la complessità del mondo. Solo allora potrà riscoprire il suo ruolo di forza trasformativa, sia nella società occidentale che nel resto del mondo, risvegliando la capacità di pensare, di interrogarsi e di agire.
di ©Danilo Pette


















