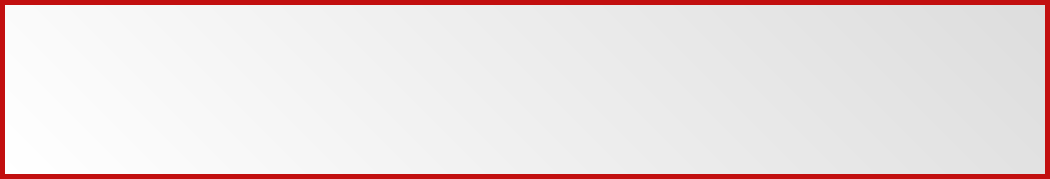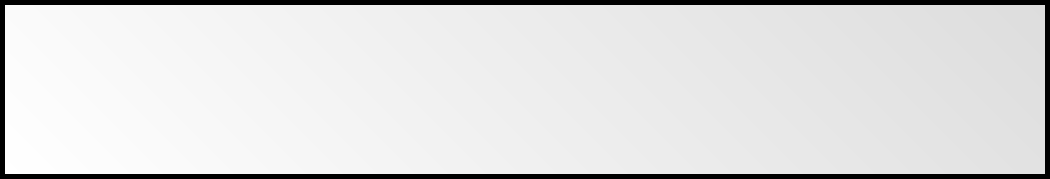Paul Weller a Roma – Tour 2023
Scritto da Davide Mengarelli il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro.
a cura Davide Mengarelli
Dai Jam agli Style Council fino all’evoluzione solista, il Modfather incanta la Cavea con un viaggio musicale che è molto più di un concerto: è un attraversamento emotivo, collettivo, necessario.Il cielo sopra Roma, il 22 settembre, era una tela grigia che pareva dipinta direttamente da Turner. Una distesa di nuvole impalpabili, leggere ma dense, capaci di trattenere la luce e amplificare l’attesa. Sotto quella volta sospesa, la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone si trasformava. Non era più solo uno spazio architettonico pensato per il suono: era una camera d’eco dell’anima collettiva. Tutti erano lì per lui. Il Modfather. Paul Weller. Il musicista che da quasi cinquant’anni attraversa decenni, rivoluzioni sonore, crisi di identità musicale e rinascite continue, senza mai davvero perdere la sua forma. E senza mai volerla fissare in un’unica espressione. C’è chi ha camminato nella sua musica sin dagli anni ’70, chi è arrivato grazie a una cover, chi ha scoperto i Jam attraverso un film, chi ha ascoltato i Style Council su vinile polveroso nella stanza di un fratello maggiore, e chi ha conosciuto Weller solo negli ultimi anni, chiuso in casa con “Fat Pop (Volume 1)” in cuffia mentre il mondo era bloccato, e la musica era l’unico modo per sentirsi ancora vivi.
La serata inizia prima ancora che inizi. Si sente nelle voci della gente, nel passo svelto di chi cerca posto, nei sorrisi appena accennati. Gli inglesi sono arrivati numerosi, come pellegrini in una terra amica. Non urlano, non sbandierano, ma cantano. Prima ancora che si alzino le luci. Cantano come se fosse il loro modo di prendere possesso del luogo, di accorciare la distanza fra Londra e Roma. Cantano per dire: “Siamo ancora qui, siamo sempre stati qui”.
Il palco è immobile, l’aria è ferma, ma è solo apparenza. Ogni elemento della scenografia è un frammento trattenuto, un dettaglio che aspetta di esplodere. E poi, a scaldare quel buio sospeso, arriva lei: Ailbhe Reddy. Irlandese, delicata ma sicura, voce che non si impone ma si insinua, sfiora e penetra. Porta con sé brani costruiti su fragilità trasformate in forza. La sua musica non è un’apertura di rito. È un’introduzione necessaria. Un’anticamera emotiva. Il suo set breve è come una poesia sussurrata prima di un discorso, un invito a spogliarsi del rumore per entrare nudi, pronti, nella materia viva del concerto.
Alle 21 in punto, tutto cambia. Non serve l’annuncio. Non servono proiezioni, countdown o effetti speciali. Basta il silenzio che si fa più fitto. E poi il suono. Un ticchettio, quasi un metronomo del destino. Un battito che anticipa il cuore. Paul Weller entra così: figura sottile, magra, scavata come le statue antiche. Capelli bianchi, lisci, tirati all’indietro. È lui, eppure sembra sempre altro. Cammina come se calpestasse il proprio passato e ogni passo fosse una nuova pagina. Il pubblico lo accoglie con un boato che non è solo entusiasmo. È un riconoscimento. Un abbraccio sonoro. È come dire: “Ci sei, e quindi ci siamo anche noi”.
La scaletta che segue è una costruzione sapiente, quasi drammaturgica. Si apre con “Jumble Queen”, inedito che non si sente come una novità ma come una prosecuzione naturale di un discorso mai interrotto. E poi, a seguire, un vortice. Style Council. Jam. Carriera solista. Non in ordine, non come una cronologia da manuale, ma come una mappa emotiva, come un percorso dentro le viscere dell’identità sonora di Weller. Ogni canzone è una lente che rifrange mille luci. Ogni suono è una vibrazione che scorre lungo la colonna vertebrale della platea.
“My Ever Changing Moods”, “Headstart For Happiness”, “Shout To The Top!”: i brani degli Style Council arrivano come onde eleganti, cariche di una raffinatezza che non ha mai perso forza. Il pubblico li accoglie come un’eco familiare, con il rispetto che si deve ai classici ma con l’entusiasmo che si riserva al nuovo. Perché quei pezzi non sono invecchiati: sono maturati. Si sono arricchiti di significati, di storie personali, di memorie condivise. E ora ritornano vivi, rinati. Sono canzoni che parlano d’amore, di lotta, di speranza, di frustrazione, ma lo fanno con un vocabolario musicale che è una sinfonia di sfumature: soul, jazz, funk, pop. Una ricchezza che travolge, che nutre.
Poi arriva la svolta solista. “Cosmic Fringes”, “Stanley Road”, “You Do Something To Me”, “Wild Wood”, “On Sunset”. Qui Weller si fa narratore intimo. Siede al piano. Guarda avanti, ma anche dentro. La sua voce graffia e accarezza, non c’è filtro. Ogni parola è corpo. “You Do Something To Me” è un sussurro che si fa carezza collettiva. “Wild Wood” è un ritorno alla natura, non quella esterna ma quella interiore. E “On Sunset” è un capolavoro di malinconia luminosa: la memoria che si fa melodia, il passato che non è mai passato del tutto.
Il cuore mod batte forte quando arrivano “Peacock Suit” e “Rockets”. Qui la scena si trasforma. Le luci cambiano, le movenze si fanno più taglienti. Weller diventa icona glam, senza maschere ma con l’eco di Bowie a fare da spirito guida. Le chitarre graffiano, il basso pulsa, i fiati lacerano. È un momento di esplosione pura. Non è revival. È riscrittura. È il passato che si reinventa nel presente, che si sporca di nuova vita.
E poi, l’atteso ritorno ai Jam. “Start!”, “That’s Entertainment”, “Town Called Malice”. Brani che sono colonne vertebrali di intere esistenze. Ogni nota è un pugno, ogni strofa una dichiarazione. Weller non interpreta: incarna. Non ripropone: rivive. “That’s Entertainment” è minimalismo lirico trasformato in manifesto. Parla della noia, della routine, della violenza sommessa della quotidianità urbana, ma lo fa con sarcasmo lucido, con poesia disillusa. È uno specchio che riflette ciò che siamo, anche oggi. Forse soprattutto oggi.
Dietro di lui, la band è una macchina perfetta. Ma non è fredda. È viva. Steve Cradock alla chitarra è colonna e carne, precisione e anima. Steve Pilgrim alla batteria aggiunge fluidità, e quando imbraccia l’acustica trasforma l’impatto in carezza. Andy Lewis al basso costruisce ponti tra ritmo e armonia. Jacko Peake ai fiati è vento che strappa e ricuce. Andy Crofts alle tastiere disegna trame sottili. Ben Gordelier alle percussioni è il battito segreto che regge l’intero corpo. Sono una famiglia. Non sono accompagnatori. Sono linfa. Ogni sguardo tra loro è complicità. Ogni cambio di tempo è una decisione presa insieme. La musica nasce in quell’interstizio tra esperienza e fiducia.
L’atmosfera nella Cavea è elettrica, ma mai caotica. È un ordine emotivo, un’energia che pulsa in modo coeso. C’è chi canta a occhi chiusi. C’è chi piange. C’è chi semplicemente ascolta. Nessuno è spettatore. Tutti sono parte di qualcosa. Un rito laico. Una celebrazione dell’inquietudine. Una festa della memoria. Nessuna canzone è eseguita per dovere. Tutte sono suonate perché hanno ancora qualcosa da dire.
Weller non parla molto. Ma quando lo fa, ogni parola pesa. Non ha bisogno di incitare, di fare il frontman classico. Basta uno sguardo, un sorriso, un gesto del braccio. Cammina sul palco come se fosse il prolungamento del suo corpo. Interagisce con i musicisti, si gira, si ferma. È presente. Ma non è mai ingombrante. Lascia spazio alla musica. È come se dicesse: “Io sono solo uno dei canali attraverso cui passa tutto questo”. E tutto questo è un flusso. Un’onda che non si ferma. Una corrente che si propaga.
Dopo quasi due ore di viaggio musicale, arriva l’epilogo. Non è una chiusura. È una sospensione. Come un libro che finisce senza mettere il punto. Come un film che si dissolve lasciando una domanda. Paul Weller esce così. Con la stessa sobrietà con cui era entrato. Ma ora, la sua figura ha qualcosa di diverso. È più leggera. Più luminosa. Più vera.
Fuori, la notte romana accoglie il pubblico con una brezza sottile. Le voci sono basse, come dopo un’intensa conversazione. Nessuno corre via. Tutti portano dentro qualcosa. Una vibrazione. Un’eco. Un pensiero.
Perché Weller non è solo un musicista. È un trasmettitore di visioni. Un artigiano della trasformazione. Un alchimista del suono e del tempo.
E Roma, per una notte, è stata parte di quel mistero.