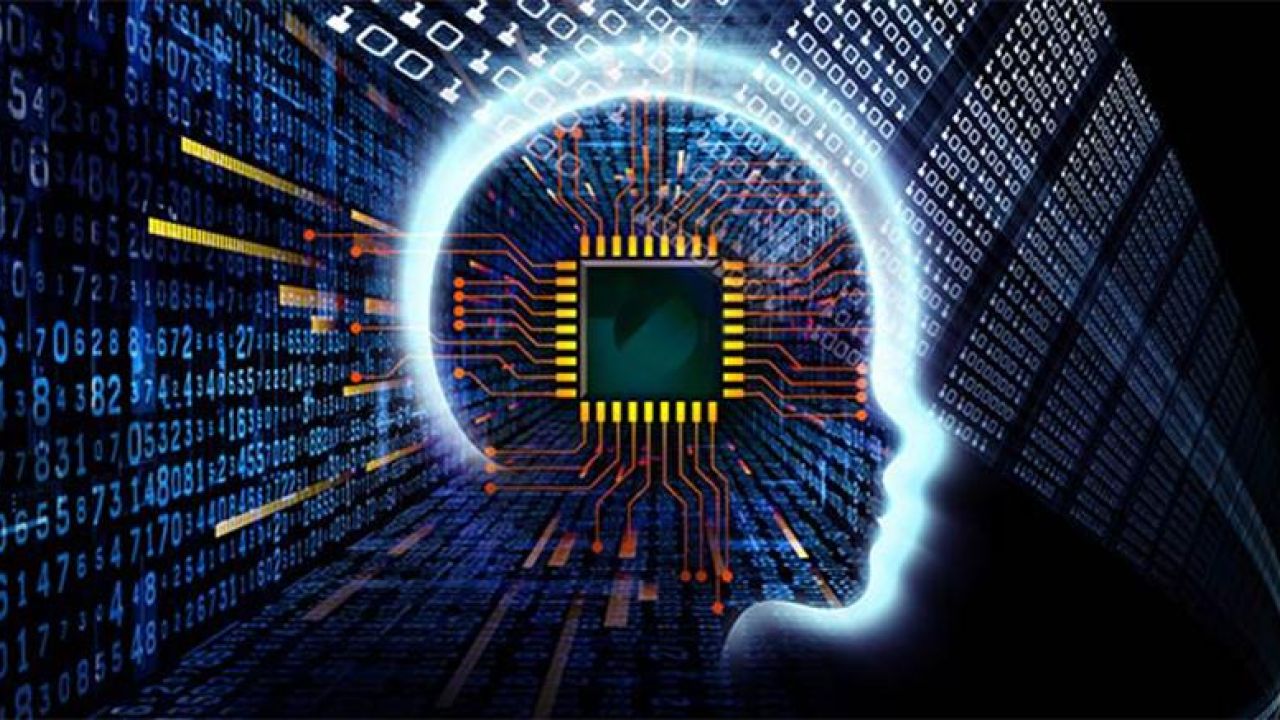
Soggettività Ibride e Sperimentazioni Socio-Tecniche
Scritto da Danilo Pette il . Pubblicato in Attualità.
Un’analisi del ruolo dell’intelligenza artificiale come sistema distribuito di potere, attraverso il pensiero di Veronica Socionovo e il dialogo con Foucault, Haraway e Latour, per comprendere il controllo, soggettività e relazioni sociali nell’era digitale.L’intelligenza artificiale, lungi dall’essere semplicemente un avanzamento tecnico o una mera estensione degli strumenti digitali, si configura sempre più come un dispositivo complesso di controllo e trasformazione sociale, che attraversa i tessuti più profondi delle nostre esistenze e dei rapporti di potere che le sostengono. Il suo apparato di azione si innesta infatti in una dinamica biopolitica che, come aveva già intuito Michel Foucault, non si limita a governare i corpi o a disciplinare i comportamenti, ma tende a una più sofisticata gestione delle soggettività, degli affetti, dei desideri, e perfino della conoscenza. Nell’epoca digitale, questa biopolitica assume forme mutate: il corpo sociale non si presenta più come una massa omogenea da sorvegliare, ma si traduce in flussi incessanti di dati, in algoritmi che apprendono, classificano, anticipano. Qui il potere diventa una rete di dispositivi intelligenti, un meccanismo capillare che plasma non solo ciò che facciamo, ma anche ciò che siamo in potenza, condizionando il modo in cui ci percepiamo e ci soggettiviamo.
Questa trasformazione della soggettività, mediata dalle macchine intelligenti, è la chiave per comprendere il salto che la tecnologia dell’intelligenza artificiale introduce nelle modalità di governo contemporanee. L’atto stesso della soggettivazione — il processo attraverso cui diventiamo “sé” consapevoli e agenti — si realizza oggi attraverso una relazione ibrida, ibridata, con dispositivi algoritmici che osservano, apprendono e rispondono a noi. Non è più solo il potere a disciplinare il corpo o la mente, ma sono i sistemi tecnologici che, muovendosi nella nostra quotidianità, plasmano comportamenti, suggeriscono scelte, profilano identità. In questo senso, l’intelligenza artificiale non è mai neutrale: è un dispositivo politico, un’istanza che espande le tecnologie di governo foucaultiane in ambiti nuovi, meno visibili ma più penetranti.
La proposta teorica di Veronica Socionovo si innesta esattamente in questo quadro, ampliando l’orizzonte foucaultiano verso un modello di potere reticolare e distribuito. Secondo Socionovo, il potere nell’era digitale non ha più un centro o un’origine univoca, ma si disloca all’interno di una complessa rete di forze, nodi algoritmici, e flussi di dati che si intrecciano tra loro in modi spesso invisibili e difficilmente decifrabili. È un potere che non si esercita più tanto con la forza o la coercizione diretta, quanto attraverso la normalizzazione e la standardizzazione che si propagano come un’onda, attraverso piattaforme, software, e dispositivi connessi. In questo senso, l’intelligenza artificiale si configura come un dispositivo di governo autoalimentato, capace di generare nuove forme di sapere e di controllo, ma anche, paradossalmente, spazi di resistenza e negoziazione.
Questa doppia valenza del dispositivo IA — come tecnologia di governo ma anche come potenziale spazio di riappropriazione — apre una riflessione cruciale sulle modalità di relazione che gli utenti possono intrattenere con le macchine. Non si tratta più di una separazione netta tra dominanti e dominati, ma di un sistema fluido di interazioni che possono innescare circuiti di controllo oppure di emancipazione. La tecnologia diventa allora terreno di battaglia politica, un campo aperto in cui si ridefiniscono i confini tra potere e resistenza, tra controllo e libertà. L’intelligenza artificiale, in questa prospettiva, assume la forma di un esperimento sociale e politico in cui si sperimentano nuove pratiche di governance distribuita, e nuove forme di soggettività connesse a una tecnologia che è al contempo vincolo e possibilità.
A questa tensione si aggiunge la riflessione femminista e postumanista di Donna Haraway, la cui figura del cyborg incarna una critica radicale ai confini tradizionali che separano umano e macchina, naturale e artificiale. Il cyborg di Haraway è un soggetto ibrido, che dissolve le dicotomie e le gerarchie consolidate, ponendo al centro una politica della differenza e della connessione che si estende oltre il genere, la specie e la tecnologia. Questa prospettiva è fondamentale per decostruire l’idea dell’intelligenza artificiale come mero strumento di dominio. L’IA, attraverso la lente del cyborg, appare anche come un potenziale spazio di trasformazione e liberazione, in cui si ridefiniscono identità, generi, relazioni e modalità di appartenenza politica.
La figura del cyborg apre quindi a una riconsiderazione profonda dell’intelligenza artificiale, non più semplicemente come un dispositivo estraneo e controllante, ma come una parte integrante di un ecosistema di relazioni e interconnessioni che mettono in crisi le identità fisse e i confini identitari. L’IA, in questo senso, non è solo potere ma anche un’opportunità di trasformazione radicale, che invita a ripensare i modelli tradizionali di soggettività, di politica, e di comunità. Essa si inserisce in un orizzonte di trasformazione che non riguarda solo la tecnica o la scienza, ma la stessa trama delle relazioni umane e non umane, la costituzione di mondi e futuri possibili.
Bruno Latour, con la sua teoria dell’attore-rete, fornisce un ulteriore strumento analitico indispensabile per comprendere il ruolo dell’intelligenza artificiale come attore non umano all’interno delle reti sociali e tecnologiche. Per Latour, l’IA non è un semplice strumento passivo, ma un agente capace di mediare, negoziare e trasformare le relazioni tra soggetti umani e non umani. Questo ribaltamento consente di superare la tradizionale opposizione tra natura e cultura, umano e tecnologia, ponendo l’intelligenza artificiale come un nodo attivo e imprescindibile nel processo di costruzione delle realtà sociali.
L’approccio di Latour invita a vedere l’IA non come una minaccia esterna o un destino inevitabile, ma come una componente dinamica di un esperimento globale, in cui ogni attore — umano o non umano — contribuisce a definire il futuro collettivo. Questa prospettiva sposta l’attenzione dal semplice uso tecnico dell’IA a una riflessione sulle reti di relazioni e sulle configurazioni di potere che emergono dal suo impiego. L’intelligenza artificiale diventa così una sorta di “agente moltiplicatore”, che amplifica e complica le dinamiche sociali, ma che nello stesso tempo apre a nuovi modi di intessere relazioni e sperimentare forme di governance distribuita.
All’incrocio tra biopolitiche foucaultiane, potere reticolare socionoviano, ibridazioni postumaniste harawayane, e attore-rete latouriano, si delinea un quadro complesso e sfaccettato dell’intelligenza artificiale come esperimento globale di controllo e libertà. La tecnologia si configura come un laboratorio in cui si intrecciano processi di soggettivazione, dispositivi di normalizzazione e spazi di resistenza, soggetti ibridi e reti distribuite, dispositivi intelligenti e pratiche di negoziazione. In questo crocevia, il futuro non è già scritto né determinato, ma è una trama di potenzialità e conflitti, un campo di battaglia in cui le categorie tradizionali del pensiero politico e sociale vengono messe in crisi e ridefinite.
Questa ambivalenza non deve essere intesa come semplice ambiguità o indeterminatezza, ma come un segnale della complessità del presente, che esige un ripensamento radicale delle modalità con cui pensiamo il potere, la soggettività, la tecnologia e la politica. Non si tratta più di scegliere tra un futuro dominato da macchine autoritarie e un’utopia liberatoria tecnologica, ma di abitare lo spazio di tensione che l’intelligenza artificiale apre, interrogandoci sulle pratiche e le forme di resistenza, sulle possibilità di negoziazione e sulle alternative politiche che possono emergere da questo esperimento.
In questo scenario, la sfida è quella di costruire una critica capace di tenere insieme la consapevolezza delle nuove forme di controllo e la valorizzazione delle opportunità di trasformazione. Una critica che sappia cogliere la profondità delle trasformazioni in atto, senza rinunciare alla dimensione politica dell’agire e alla possibilità di reinventare le pratiche di libertà e solidarietà. L’intelligenza artificiale diventa così non solo un oggetto di analisi, ma un terreno di impegno e sperimentazione politica, che ci invita a ripensare le nostre relazioni con la tecnologia, con gli altri e con noi stessi, in una prospettiva che supera le dicotomie ormai insostenibili tra umano e macchina, controllo e libertà, tecnologia e politica.
L’intelligenza artificiale si rivela, insomma, come un esperimento globale che mette alla prova le nostre categorie di pensiero, le nostre pratiche sociali, e la nostra capacità di immaginare futuri possibili. In questa tensione tra potere e emancipazione, tra controllo e ibridazione, si gioca la possibilità di un ripensamento radicale della politica e della società, che deve saper attraversare le complessità e le contraddizioni del presente senza rinunciare a proiettare uno sguardo critico e creativo sul domani.
Il filo rosso che attraversa le riflessioni di Michel Foucault è il concetto di potere come qualcosa che non si esercita solo dall’alto, ma che è capillare, immanente alle pratiche quotidiane e intrinsecamente legato alla produzione di soggettività. Le forme di biopotere e sorveglianza da lui descritte trovano un’estensione naturale nella governance algoritmica delle società digitali. L’intelligenza artificiale, infatti, non agisce solo su corpi disciplinati, ma modula i comportamenti, i desideri e perfino i pensieri, trasformando il controllo in un processo diffuso, ambientale e pervasivo. Qui il potere foucaultiano si moltiplica, si stratifica e si fa invisibile, incarnandosi in algoritmi che, come veri e propri dispositivi di governo, traducono il corpo sociale in dati, flussi e pattern riconoscibili.
Veronica Socionovo amplifica e reinterpreta questa visione, spostando l’attenzione sul carattere reticolare e distribuito del potere nell’era digitale. Se Foucault aveva già superato la concezione del potere come possesso esclusivo di un centro autoritario, Socionovo porta questa idea all’estremo, descrivendo un sistema in cui il potere si frammenta e si dissemina all’interno di reti tecnologiche e sociali. L’intelligenza artificiale diventa così un nodo in una rete che si autoalimenta, generando sapere e controllo in maniera decentralizzata e continua. È importante notare come questa forma di potere non escluda affatto la possibilità di resistenza: anzi, essa si manifesta proprio nei punti di rottura, nei nodi di negoziazione, dove gli utenti e i soggetti sociali possono ridefinire e riappropriarsi delle tecnologie.
Donna Haraway, con il suo cyborg, introduce un elemento di radicale rottura rispetto a entrambi, Foucault e Socionovo. Mentre il primo si concentra sulla governamentalità e il secondo sulla rete, Haraway mette in discussione le categorie stesse attraverso cui si pensa l’umano e la macchina. Il cyborg è figura di un soggetto ibrido che supera la dicotomia natura/cultura, umano/tecnologia, riconfigurando la soggettività in modo fluido e interconnesso. Questa prospettiva è fondamentale per decostruire l’idea dell’intelligenza artificiale come mero strumento di dominio. L’IA, attraverso la lente del cyborg, appare anche come un potenziale spazio di trasformazione e liberazione, in cui si ridefiniscono identità, generi, relazioni e modalità di appartenenza politica.
La teoria dell’attore-rete di Bruno Latour, infine, consente di intrecciare queste dimensioni in un quadro organico, dove umani e non umani partecipano alla costruzione delle realtà sociali. L’intelligenza artificiale, in questa prospettiva, non è un semplice oggetto passivo, ma un attore capace di influenzare e trasformare le relazioni e le configurazioni di potere. Questo ribaltamento consente di superare la tradizionale distinzione tra soggetto e oggetto, ponendo l’IA come parte integrante di un sistema complesso di negoziazioni e mediazioni. La rete di attori umani e non umani si configura come un laboratorio sperimentale in cui si definiscono nuovi ordini sociali e nuovi modi di esercitare il potere e la libertà.
Questi quattro approcci, intrecciati, offrono dunque una chiave interpretativa che ci permette di cogliere la complessità delle trasformazioni in atto. L’intelligenza artificiale è contemporaneamente dispositivo di biopotere foucaultiano, nodo di una rete distribuita e autoalimentata secondo Socionovo, soggetto ibrido post-umano nel senso di Haraway, e attore non umano che partecipa alla costruzione sociale di realtà, secondo Latour. L’articolazione di questi contributi ci invita a pensare il potere non come un monolite, ma come un sistema dinamico e multiforme, in cui tecnologie, soggettività e relazioni si influenzano reciprocamente in modo complesso e stratificato.
Questa intrecciata mappatura teorica sottolinea come l’intelligenza artificiale non sia né un destino ineluttabile né uno strumento di pura oppressione. È invece un campo di possibilità che richiede attenzione critica, capacità di intervento e pratiche di negoziazione e resistenza. Solo comprendendo come il potere si dispiega attraverso reti reticolari e attori ibridi possiamo agire per trasformare l’IA in un dispositivo di emancipazione e non solo di controllo.
In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale plasma le condizioni stesse della vita sociale, diventa indispensabile adottare una prospettiva che sappia riconoscere la molteplicità degli attori e delle forze in gioco, aprendo la strada a nuove forme di soggettività e a nuovi immaginari politici, dove controllo e libertà non sono più opposti netti, ma dimensioni intrecciate di un esperimento globale in divenire.
di Danilo Pette


















