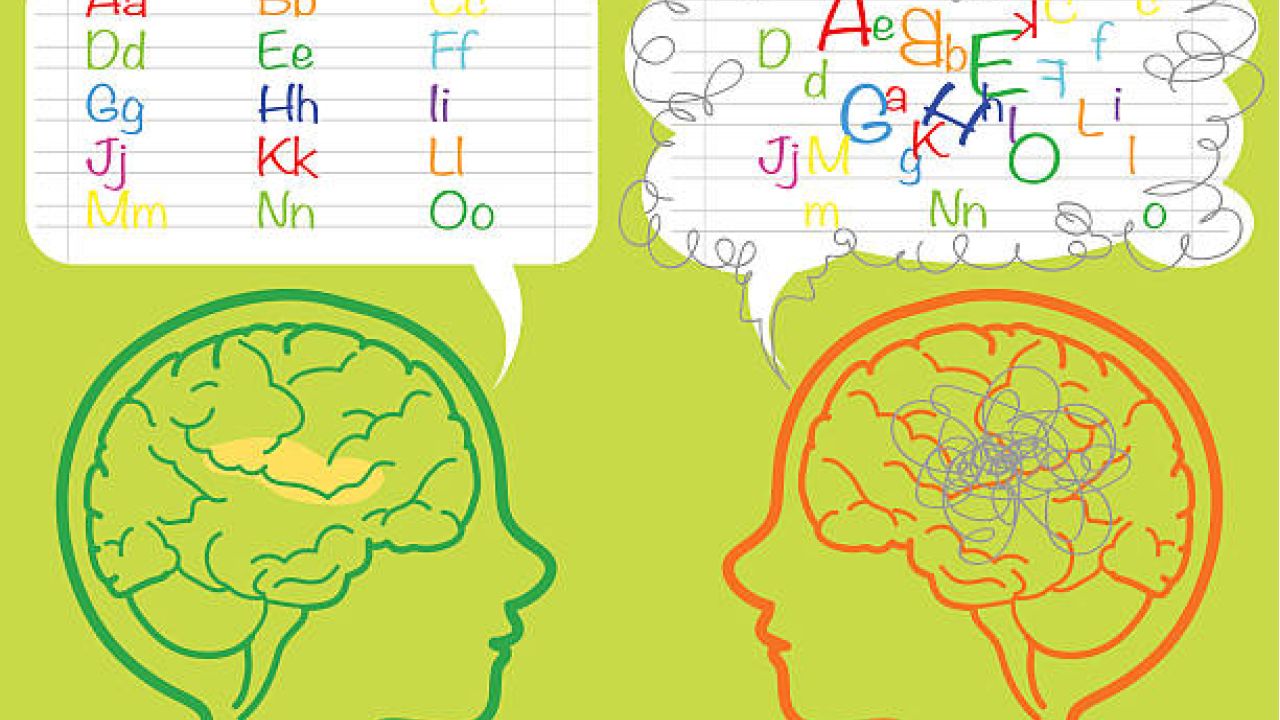
Insegnanti nel DSA
Scritto da Veronica Socionovo il . Pubblicato in Formazione, Salute e Sanità.
Disturbi Specifici dell’Apprendimento 12
Il ruolo dell’insegnante nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento è complesso e centrale. Non si tratta solo di “gestire” una difficoltà, ma di costruire una relazione educativa che sappia accogliere la differenza, sostenere lo sviluppo di abilità e competenze e accompagnare lo studente nel percorso verso la piena realizzazione personale e sociale.I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) costituiscono una delle sfide più rilevanti per il sistema scolastico contemporaneo, perché richiedono un ripensamento profondo delle pratiche educative, della formazione docente e delle modalità di relazione con lo studente. Definiti come difficoltà selettive e persistenti nell’acquisizione e nell’uso di abilità fondamentali quali la lettura, la scrittura e il calcolo, i DSA non derivano da deficit cognitivi generali, né da disabilità sensoriali o ambientali, bensì da disfunzioni neurobiologiche specifiche. Essi comprendono, tra gli altri, la dislessia (difficoltà nella lettura), la disgrafia e la disortografia (difficoltà nella scrittura e nell’ortografia), la discalculia (difficoltà nel calcolo), e il Disturbo dell’Apprendimento Non Verbale (DANV), che interessa principalmente l’organizzazione spaziale e le abilità visuo-percettive.
La complessità di questi disturbi richiede che gli insegnanti non siano semplicemente trasmettitori di contenuti, ma autentici mediatori didattici, capaci di rilevare tempestivamente i segnali di difficoltà, di modulare i processi di apprendimento e di agire come punto di riferimento educativo, emotivo e motivazionale per lo studente con DSA. In questo senso, il ruolo dell’insegnante diventa cardine non solo per la gestione quotidiana delle difficoltà, ma anche per la costruzione di un percorso scolastico inclusivo e personalizzato che consenta a ciascun alunno di esprimere al massimo il proprio potenziale.
La natura dei DSA e le implicazioni per la didattica
I DSA si caratterizzano per un’incapacità specifica di automatizzare e padroneggiare abilità legate a processi cognitivi determinati, con un impatto significativo sul rendimento scolastico. È importante sottolineare che tali disturbi non implicano una riduzione delle capacità intellettive generali, bensì una discontinuità selettiva che rende più difficile l’apprendimento di alcune competenze specifiche.
La dislessia, ad esempio, si manifesta con difficoltà nella decodifica del testo scritto e nella lettura fluente, spesso accompagnata da errori di omissione, aggiunta o sostituzione di lettere e parole. La disgrafia, invece, riguarda la difficoltà nell’esecuzione grafica della scrittura, con una motricità fine compromessa che rende la scrittura faticosa e poco leggibile. La disortografia comporta errori nella corretta composizione delle parole, in particolare nella scrittura di suoni e lettere. La discalculia si presenta come un’alterazione delle abilità nel riconoscimento dei numeri, nella memorizzazione delle tabelline o nell’esecuzione di calcoli, mentre il Disturbo dell’Apprendimento Non Verbale si manifesta attraverso difficoltà nella gestione delle relazioni spaziali e delle competenze sociali implicite.
Questa complessità implica che gli insegnanti non possano adottare un approccio univoco o standardizzato, ma debbano sviluppare una profonda comprensione delle peculiarità di ciascun disturbo, riconoscendo che ogni studente con DSA ha un profilo unico, con punti di forza e fragilità differenti. Tale consapevolezza è la base per la personalizzazione dell’intervento educativo.
Formazione docente: competenze imprescindibili
La formazione degli insegnanti in materia di DSA rappresenta una priorità inderogabile, poiché è proprio da qui che si genera la capacità di riconoscere, comprendere e supportare gli studenti con bisogni educativi speciali. Per troppo tempo il tema dei DSA è stato relegato a una conoscenza marginale o frammentaria, lasciando molti insegnanti impreparati a gestire efficacemente queste situazioni.
La formazione deve iniziare già nei percorsi universitari, integrando moduli specifici di neuropsicologia dell’apprendimento, didattica inclusiva e normativa scolastica. Non meno importante è l’aggiornamento continuo durante il servizio, tramite corsi, workshop, supervisioni e attività di ricerca-azione, che permettano di mantenere vive le competenze e di innovare le pratiche didattiche.
Un insegnante formato sui DSA conosce i principi neurobiologici alla base di tali disturbi, è in grado di identificare precocemente i segnali di difficoltà, e soprattutto padroneggia strategie didattiche differenziate, strumenti compensativi e misure dispensative efficaci. Inoltre, è consapevole dell’importanza del ruolo emotivo che può esercitare, riconoscendo che la dimensione affettiva è parte integrante dell’apprendimento.
La normativa italiana, con la Legge 170/2010, ha sancito l’importanza di una formazione adeguata e l’obbligo per le scuole di predisporre interventi personalizzati per gli studenti con DSA, ponendo così la formazione come vincolo istituzionale e non più come semplice raccomandazione. Ciò implica un impegno concreto delle istituzioni scolastiche a promuovere e supportare iniziative formative strutturate e continue.
Adattare la didattica: dall’uniformità all’individualizzazione
La didattica tradizionale, spesso centrata su modelli standardizzati, non è in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze degli studenti con DSA. Il compito dell’insegnante consiste nel ripensare il proprio approccio, adottando strategie che favoriscano l’apprendimento personalizzato e rispettino i tempi, gli stili e le modalità cognitive del singolo alunno.
Il concetto di personalizzazione della didattica supera la semplice semplificazione dei contenuti: non si tratta di “abbassare” l’obiettivo, ma di costruire percorsi alternativi che rendano accessibili i medesimi traguardi formativi. Per esempio, nel caso di un bambino con dislessia, si può integrare la lettura con l’uso di mappe concettuali, strumenti digitali di sintesi vocale, o proporre attività di ascolto e oralità che valorizzino le sue competenze linguistiche orali.
I tempi dilatati sono un altro adattamento fondamentale: permettere un tempo maggiore per le prove scritte o orali riduce l’ansia da prestazione e consente allo studente di elaborare i contenuti senza fretta. Inoltre, l’uso di materiali didattici multisensoriali, che coinvolgono la vista, l’udito e il tatto, stimola l’apprendimento attraverso canali diversi, spesso più efficaci per studenti con DSA.
Nel caso della discalculia, per esempio, l’utilizzo di strumenti concreti come l’abaco o giochi matematici manipolativi facilita la comprensione di concetti astratti. Anche la segmentazione dei compiti in unità più semplici e ben definite aiuta a evitare il sovraccarico cognitivo e favorisce il mantenimento dell’attenzione.
Le verifiche possono essere riorganizzate in modo da consentire modalità alternative di espressione delle competenze, come presentazioni orali, elaborati multimediali o prove pratiche, che valorizzino le diverse intelligenze e capacità.
L’efficacia di questi adattamenti dipende dalla capacità dell’insegnante di entrare in sintonia con lo stile di apprendimento di ciascun alunno, osservandolo con attenzione, ascoltandolo e modulando continuamente le strategie in un processo dinamico e flessibile.
Strumenti compensativi e misure dispensative: garantire equità
Gli strumenti compensativi e le misure dispensative rappresentano due pilastri fondamentali nel supporto agli studenti con DSA. Non si tratta di favori o privilegi, ma di misure che garantiscono l’equità educativa, permettendo allo studente di accedere alle stesse opportunità formative dei coetanei.
Gli strumenti compensativi sono dispositivi tecnologici o metodologici che compensano la difficoltà specifica senza ridurre il livello di apprendimento richiesto. Ad esempio, la sintesi vocale permette agli studenti con dislessia di ascoltare testi scritti, superando così il limite della decodifica; i software di videoscrittura con correttore ortografico aiutano chi ha disgrafia o disortografia a esprimersi senza che gli errori ortografici compromettano il messaggio; le calcolatrici e le tabelle di memoria sono fondamentali per gli studenti con discalculia.
Le misure dispensative, invece, consistono in esenzioni o facilitazioni da alcune attività che risultano particolarmente gravose o svantaggiose per lo studente. Per esempio, l’esenzione dalla lettura ad alta voce, dalla scrittura sotto dettatura o dalla memorizzazione mnemonica di poesie e formule permette di evitare situazioni di stress e disagio che non contribuiscono all’apprendimento.
È fondamentale che questi strumenti e misure siano scelti e personalizzati in base alle esigenze specifiche di ogni studente, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e condivisi con la famiglia e gli specialisti. Solo così possono essere efficaci e garantire il successo formativo.
L’insegnante come sostegno emotivo e motivazionale
Spesso, nel dibattito sui DSA, si tende a concentrarsi esclusivamente sulle strategie didattiche e sugli strumenti tecnici, trascurando l’importanza fondamentale dell’aspetto emotivo e motivazionale. Tuttavia, le difficoltà di apprendimento sono strettamente correlate al vissuto psicologico dello studente: sensazioni di frustrazione, insuccesso e inadeguatezza possono minare profondamente l’autostima, la motivazione e la partecipazione attiva.
I bambini con DSA sono frequentemente esposti a esperienze di fallimento ripetuto che possono generare ansia da prestazione, senso di inferiorità, isolamento sociale e comportamenti oppositivi. L’insegnante diventa allora una figura chiave nella costruzione di un ambiente scolastico accogliente e rassicurante, dove lo studente si senta compreso e valorizzato.
È importante che l’insegnante riconosca e celebri ogni progresso, anche piccolo, evitando confronti con i compagni e promuovendo un atteggiamento di accettazione e fiducia. La promozione dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione è essenziale per rafforzare la motivazione interna dello studente e per far sì che percepisca la scuola come un luogo di crescita personale.
Le strategie come il peer tutoring (insegnamento tra pari) possono favorire l’inclusione sociale e l’apprendimento cooperativo, mentre momenti di riflessione e metacognizione aiutano lo studente a sviluppare consapevolezza dei propri processi cognitivi e a imparare a gestirli efficacemente.
La rete di collaborazione: scuola, famiglia, specialisti
Il successo dell’intervento educativo per gli studenti con DSA non può prescindere da una solida collaborazione tra scuola, famiglia e specialisti. Questa rete integrata è essenziale per garantire un monitoraggio costante, una condivisione di informazioni e una coerenza negli interventi.
La famiglia è il primo punto di riferimento del bambino e un alleato prezioso per gli insegnanti: fornendo informazioni sul comportamento e le difficoltà osservate, partecipando alla definizione e revisione del PDP, e supportando l’applicazione delle strategie anche a casa, la famiglia contribuisce in modo significativo al percorso educativo.
Gli specialisti (psicologi, neuropsichiatri infantili, logopedisti, tutor dell’apprendimento) svolgono un ruolo fondamentale nell’effettuare la diagnosi, nell’individuare le strategie più efficaci e nel fornire un supporto professionale continuativo. La loro presenza nella rete educativa permette di costruire un progetto didattico integrato, che tiene conto della complessità del disturbo e delle risorse dell’alunno.
La comunicazione tra questi attori deve essere costante, trasparente e focalizzata sugli obiettivi comuni, con incontri periodici e scambio di feedback, al fine di adattare tempestivamente gli interventi alle evoluzioni e ai bisogni emergenti.
Verso una scuola veramente inclusiva: sfide e prospettive
L’inclusione scolastica rappresenta la sfida più significativa e ambiziosa per le istituzioni educative del presente e del futuro. La scuola non deve solo essere un luogo di trasmissione di conoscenze, ma una comunità educativa che riconosce e valorizza la diversità come risorsa.
I DSA costituiscono un invito a rinnovare le pratiche didattiche, a sviluppare una cultura dell’inclusione e a promuovere un’educazione che sia flessibile, personalizzata e attenta alle dimensioni cognitive, emotive e relazionali degli studenti.
Per affrontare questa sfida, è necessario investire nella formazione degli insegnanti, inserendo moduli obbligatori sui DSA nei percorsi universitari e promuovendo figure di tutor esperti in didattica inclusiva nelle scuole. Inoltre, occorre valorizzare la valutazione formativa, che consideri il processo di apprendimento e non solo il risultato finale, e incentivare la ricerca-azione, affinché i docenti possano sperimentare e condividere buone pratiche.
Coinvolgere attivamente gli studenti con DSA nella costruzione del proprio percorso educativo è un passo fondamentale per promuovere autonomia, responsabilità e consapevolezza.
©Veronica Socionovo


















