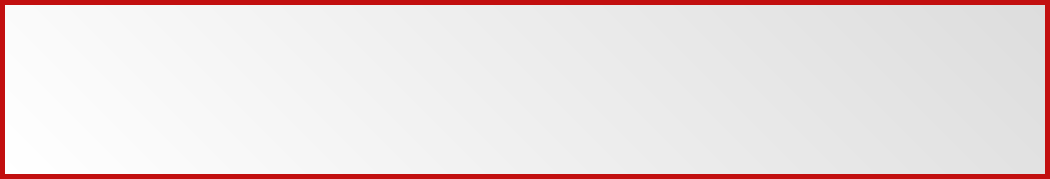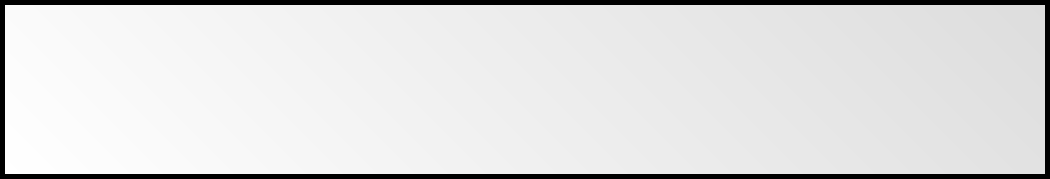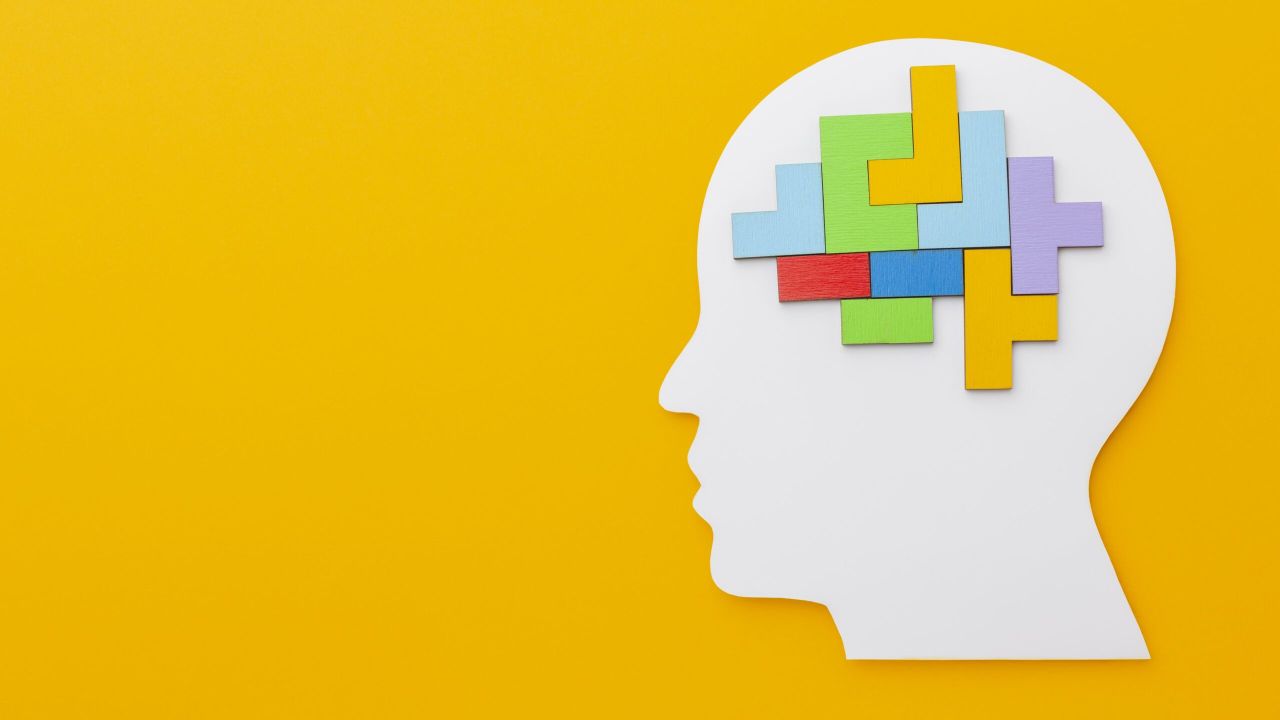
Dal Sindrome di Asperger all’Autismo
Scritto da Veronica Socionovo il . Pubblicato in Formazione, Salute e Sanità.
Un viaggio nella mente, tra classificazioni cliniche e vissuti, per capire l’evoluzione delle definizioni e le continue sfide nel riconoscere e descrivere le varianti dello spettro autistico: come cambiano i criteri diagnostici nei DSM e le patologie correlate
Quando parliamo di disturbi dello spettro autistico, spesso ci rifacciamo a una categorizzazione che appare nitida e condivisa: Asperger, autismo di grado variabile, forme atipiche. Ma basta scorrere con lo sguardo l’evoluzione dei manuali diagnostici – i celebri DSM – per capire come quella chiarezza sia frutto di un percorso complesso, spesso controverso, in cui le definizioni si ridefiniscono, si ampliano o si restringono, con evidenti impatti sia sul piano medico che su quello personale delle persone interessate.
Cominciamo col dire che il DSM-III, pubblicato nel 1980, introdusse per la prima volta un disturbo “autistico” distinto, ampliando il già presente disturbo di Rett e l’insieme delle “reazioni schizofreniche infantili”. In quel contesto pionieristico, la casistica era piuttosto ristretta: i bambini venivano considerati affetti da autismo se manifestavano gravi forme di ritardo cognitivo, difficoltà di interazione sociale estrema e tipiche stereotipie motorie.
Nel DSM-III-R del 1987 si assistette a un primo ampliamento. Scomparvero le reazioni schizofreniche infantili, sostituite da “Disturbi Pervasivi dello Sviluppo” (PDD), definendo una famiglia di disturbi che comprendevano una gamma più ampia di presentazioni. L’attenzione si spostò progressivamente su aspetti legati alla comunicazione e all’immaginazione, oltre che alla socialità, ma ancora con una prospettiva fortemente categoriale e orientata a forme limitanti.
Arriviamo dunque al DSM-IV del 1994, e alla novità più significativa: la sindrome di Asperger compare per la prima volta come entità diagnostica distinta, pur legata alla famiglia PDD. Facciamo qualche passo indietro: prima di allora, persone con peculiarità sociali, interessi ristretti, ma intelligenza nella norma o sopra la norma, venivano spesso etichettate come “autistiche ad alto funzionamento” (high functioning autism), senza una definizione precisa. L’autismo di Asperger, così com’è scientificamente conosciuto, fu descritto dall’omonimo pediatra austriaco Hans Asperger negli anni Quaranta, ma non godé di riconoscimento in ambito clinico fino agli anni Novanta. Nel DSM-IV si precisa: il linguaggio precoce come lo conosciamo, senza ritardo significativo; difficoltà nel pragmatismo comunicativo; interessi ristretti e una certa goffaggine motoria.
Ampliando gli orizzonti, il DSM-IV include anche disturbi atipici come PDD-NOS (Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified), pensati per chi non rientra nei parametri netti dell’autismo classico o dell’Asperger, pur presentando tratti significativi dello spettro. Questa scelta, se da un lato aumenta la sensibilità diagnostica, dall’altro apre la porta a una gamma di soggetti veramente eterogenea.
Tocchiamo con mano il problema: quale impatto hanno queste definizioni ‒ che mutano a ogni manuale ‒ sulle persone e sulle loro famiglie? Quando ti mettono un’etichetta, ti riconoscono sostegno e diritti, ma inevitabilmente plasmi l’immagine che hai di te, la percezione personale dei tuoi limiti, dei tuoi punti di forza, e del tuo modo di stare al mondo. Cosa significa sentirsi “autistico” piuttosto che “Asperger”? Cosa cambia nella relazione con l’ambiente, la scuola, il lavoro?
Non meno importante, sotto il profilo clinico: le differenze diagnostiche rilanciano l’attenzione sulle varianti, ma allo stesso tempo possono creare svantaggi. Pensiamo ai passaggi tra diagnosi: un bambino che – a sei anni – riceve una diagnosi di Sindrome di Asperger, con un profilo di linguaggio nella norma, può poi orientarsi verso un’autismo ad alto funzionamento o uno spettro atipico quando emergono difficoltà più sfumate nel linguaggio pragmatica, nella teoria della mente, o nelle abilità sociali. Dal punto di vista dei servizi, cambia l’accesso ai piani educativi, ai sostegni psicopedagogici, all’assistenza medica e riabilitativa.
Tutto questo cambia radicalmente con l’arrivo del DSM-5 nel 2013: l’autismo viene definito con un solo grande cappello diagnostico, “Autism Spectrum Disorder (ASD)”, con specificazione di severità, presenza o meno di ritardo cognitivo, linguaggio, comorbidità mediche o psichiatriche. A sparire definitivamente, dunque, sono l’Asperger e il PDD-NOS come categorie distinte. Lo spettro viene inteso come continuum, con scalette di gravità di sintomi sociali/comunicativi (area A) e comportamenti ripetitivi e interessi ristretti (area B), e l’asse diagnostico esteso per segnalare la conoscenza o meno del linguaggio, le capacità intellettive, l’eventuale presenza di disturbi medici/ambientali.
Da un lato, questa scelta porta a una maggiore coerenza con le evidenze scientifiche: da anni si era capito che tra Asperger e autismo c’erano tante similitudini, difficili da distinguere in chi ha una performance cognitiva a livello; e che differenziarle arbitrariamente nelle etichette poteva generare confusione, stigmi o falsi distinguo. Il DSM-5 punta a un linguaggio univoco, con tratteggi diagnostici più sfumati e personalizzabili, attraverso specificatori – ad esempio: “ASD, livello 1, con supporto” o “ASD, livello 3, con comorbilità di epilessia”.
Dall’altro lato, però, questa semplificazione sembra aver cancellato un pezzo della storia clinica: l’Asperger era un contenitore prezioso, un’icona identitaria per tanti, che si riconoscevano in un modo di pensare particolare, in “sette tratti distintivi” (di cui alcuni ancora oggi citati: eccessiva logorrea su un interesse specifico, difficoltà sensoriali…); chi riceveva diagnosi di Asperger, spesso aveva una spinta narrativa molto forte nel dire: “non sono autistico classico, sono asociale, ma profondamente speciale”. La rimozione ufficiale di quella dicitura ha innescato proteste, messaggi indignati, studi comparativi che mettevano in luce come psicologi, genitori, persino clinici, facessero fatica a compiere il cambiamento.
Ecco il cuore: “autismo” diventa termine ombrello, ma la ricchezza di sfumature all’interno di quel cappello rischia di disperdersi. Per mitigarlo, il DSM-5 introduce, sin dall’inizio, indicatori modulabili: livello 1, 2 o 3 di supporto richiesto; presenza o meno di disabilità intellettiva; presenza o meno di ritardo o assenza di linguaggio. In più, la possibilità di indicare sintomi sensoriali, iper- o ipo‑reattività agli stimoli, iperattività, ansia, disturbi del sonno, alimentari, convulsioni: tutti elementi collegati all’autismo, ma che oggi faticano a trovare un riconoscimento univoco fuori dal DSM, soprattutto in sistemi sanitari e scolastici.
Passiamo ora a considerare le comorbidità. Chi oggi riceve diagnosi ASD può manifestare un profilo clinico imprevedibilmente vasto: dall’ADHD all’ansia, dalla depressione a fobie specifiche, dai disturbi gastrointestinali a quelli del sonno, dalla disprassia al disturbo ossessivo-compulsivo. Non è un limite: è la consapevolezza che l’autismo non è un’entità isolata, e che dentro quel “disordine” ci sta un elaborato cervello, che lavora diversamente, e con cui si confrontano il corpo, il sistema nervoso, i vissuti emotivi, i contesti educativo-affettivi. E i criteri diagnostici, alla lunga, devono stare al passo con questa complessità. La psichiatria contemporanea sembra mettere al centro la persona, non solo la singola disfunzione.
Proviamo a portare due esempi concreti. Primo: una bambina di otto anni, intelligente, curiosa, con un linguaggio ricco ma rigido, grande difficoltà di relazione con i coetanei, sintomi ossessivi intorno alla simmetria, ansia anticipatoria patologica – un quadro che un tempo avrebbe potuto essere definito Asperger, ma oggi rientra pienamente in ASD livello 1, con comorbidità ossessivo-ansiosa. Il vantaggio diagnostico: accesso alla riabilitazione cognitivo-comportamentale, sostegni scolastici ufficiali, rete di protezione. Il rischio: dover giustificare affilatori clinici per ogni intervento, rafforzando l’idea di un gap permanente. Se avessi ricevuto diagnosi di Asperger in passato, mi sarei sentita “diversa, quarta ruota, geniale ma incapace”: oggi vengo vista in modo più funzionale, e ho più strumenti terapeutici strutturati.
Secondo esempio: un adolescente di 15 anni, con scarso linguaggio verbale, ritardo cognitivo moderato, necessità di supporto per l’igiene, alimentazione, routine, e continui autolesionismi nei momenti di sovraccarico sensoriale. In precedenza sarebbe stato semplicemente “autistico”, ora è ASD livello 3, con ritardo intellettivo e autolesionismo severo. Il DSM-5 permette di integrare tutto: ritardo cognitivo, DSA, disturbi del sonno, stimolazione rimodellata, percorsi formativi personalizzati. Ma rimane una sfida enorme: lavorare con servizi sanitari e sociali affaticati, coordinare équipe multidisciplinari, ignorare spesso problemi genetici e metabolici spesso correlati alla comorbidità.
Una nota di merito va alla capacità del DSM-5 di riconoscere voci spesso dimenticate: i disturbi sensoriali. Ipereattività o iporeattività agli stimoli tattili, rumorosi, visivi, alimentari. Qui, la transizione dal DSM-IV al DSM-5 ha significato un passo avanti clinico importante: prima erano percepiti come aura, ora sono codificati e integrati nella diagnosi. Perché lo sfondo sinestetico nel quale vive la persona con ASD determina la quotidianità, l’autoregolazione, il senso stesso di familiarità con il mondo. Oros a cogens da non omettere.
Un’ulteriore evoluzione culturale riguarda la valorizzazione delle “formulazioni personali”: per molte persone, definire se stesse come “diagnosi di spettro autistico” è esattamente l’inizio di un percorso di empowerment, di consapevolezza, di “neurodiversità”. È un contraltare alla vecchia linea diagnostica medica che “categorizza i deficit”. L’approccio neurodiversitario vede nel cervello diverso non il difetto da correggere, ma una differenza culturale, percettiva, cognitiva, che ha significato come tale. In questa ottica, il cambiamento del DSM non appare soltanto come un aggiornamento tecnico, ma come un passo verso una ridefinizione dei confini tra salute, disabilità, rottura dell’ordine dominante.
Ne scordiamo i nodi irrisolti. Primo, i criteri diagnostici a volte appaiono ancora lontani dall’adattamento e dalla personalizzazione specifica: la severità dei sintomi non sempre corrisponde all’impatto reale sulla qualità di vita, né all’equità degli interventi richiesti. Secondo, la sensibilità diagnostica cambia con le epoche: oggi è aumentata la diagnosi negli adulti, con segnalazioni di persone in età avanzata che hanno saputo vivere anni senza un’identità autistica riconosciuta, aggrappandosi solo a strategie di coping incredibili. L’Asperger era una chiave, oggi mantenere la dicharazione di “ASD livello 1” è l’unica via per ottenere riconoscimento clinico. Quanti adulti, magari genitori, dipendenti, lavoratori autonomi, hanno imparato a modulare i loro sintomi per rimanere invisibili?
Infine, le varianti linguistiche: autismo ad alto funzionamento, autismo atipico, autismo silente all’interno della famiglia femminile (dove le ragazze decodificano a fatica gli standard sociali e fanno autocamouflage, fino alla crisi emotiva che esplode dopo la pubertà). Il DSM-5 prova a contenere questa eterogeneità: “mascheramento sociale”, ansia, burnout, disastri nutrizionali… eppure, ogni persona con ASD continua a muoversi nella vita con una storia diversa, con cicatrici simboliche, compatibilità ambientali, risorse proprie.
Dal punto di vista della ricerca, la classificazione continua: gruppi di studio che studiano sottotipi basati su marcatori genetici, cognitivi, neurologici; progetti longitudinali che misurano gli outcome di adulti diagnosticati in infanzia e adolescenza; interventi che puntano su modelli di formazione degli insegnanti, lavoro di rete, digitalizzazione e AI al fianco dei soggetti con ASD. L’elemento costante resta: l’autismo non è una categoria rigida come un tempo, ma un ossimoro dello spettro, una gamma, un mosaico umano, neurologico, affettivo, di gruppo, famigliare – con cui conviviamo, che curiamo, che accompagniamo.
Concludo in punta, rinunciando a una vera “conclusione” come richiesto: la vita con l’autismo non è una diagnosi, è una traiettoria. Se Sara, una ventenne con ASD livello 1, oggi frequenta l’università, studia lingue, gestisce l’ansia e sorride, è anche perché c’è uno spettro diagnostico (il DSM‑5), un percorso terapeutico precoce, un riconoscimento sociale, un compagno sensoriale che modera i rumori, un bagaglio familiare che ha informato i compagni, e una società che si sforza di accettare la differenza.
Se Marco, trentenne con ASD livello 2, trova un laboratorio di ceramica nel quartiere periferico, lontano da etichette cliniche severe, è perché il suo gesto sensoriale e ripetitivo produce arte possibile, e il gesto sensoriale è parte di un modo di essere che ha senso pratico ed estetico.
E se Luca, bimbo di 5 anni, con linguaggio ritardato e occhio immenso per la musica, avrà una diagnosi di ASD livello 1 o 2 non significa meno o più potenzialità, ma solo la strada che viene tracciata per abilitare, sostenere, accompagnare la sua traiettoria di sviluppo, con strumenti “tarati” su quell’incontro tra cervello e relazione, tra presenza clinica e progetto umano.
Così, tra pagine di DSM che si stropicciano e parole che si precisano, tra famiglie che chiedono servizi e ricerca che reclama coerenza, l’Atlantide del “disturbo” si propaga per riposizionarsi in un’isola di “differenza”. Ne parliamo da quarant’anni, un decennio di criteri che cambia, e le vite continuano.
- Tabella evolutiva delle classificazioni diagnostiche dell’autismo nei DSM
|
DSM |
Anno |
Definizione di Autismo/Spettro |
Categorie Principali |
Cambiamenti chiave |
|
DSM-III |
1980 |
Disturbo Autistico separato |
Disturbo autistico, Disturbo di Rett, reazioni schizofreniche infantili |
Prima comparsa dell’autismo come categoria distinta. |
|
DSM-III-R |
1987 |
Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (PDD) |
PDD, incluso autismo |
Rimosse le reazioni schizofreniche infantili, si amplia lo spettro. |
|
DSM-IV |
1994 |
Famiglia PDD |
Autismo, Sindrome di Asperger, PDD-NOS, Rett, Disintegrativo |
Prima comparsa ufficiale dell’Asperger. Introdotti casi “atipici”. |
|
DSM-5 |
2013 |
Disturbo dello Spettro Autistico (ASD) |
ASD con livelli 1-3 e specificatori |
Unificazione in un’unica categoria; scompaiono Asperger e PDD-NOS. Introduzione della dimensione sensoriale. |
Francesco, 13 anni – Il ragazzo che cadeva tra le righe
“Non abbastanza grave per avere aiuto, non abbastanza tipico per passare inosservato.”
A tredici anni, Francesco passa le ricreazioni da solo. Si siede su un gradino dietro la palestra, lo stesso da tre anni. Nessuno lo bullizza apertamente, ma pochi gli parlano. Francesco ha una diagnosi di ASD livello 1, senza disabilità intellettiva né problemi di linguaggio. Ma da quando è alle medie, qualcosa si è inceppato.
Il DSM-5 dice che chi rientra in livello 1 ha bisogno di supporto “senza supervisione costante”. Ma la scuola di Francesco – oberata, sotto organico – ha interpretato quella frase alla lettera: niente insegnante di sostegno, niente educatore. Solo una coordinatrice “sensibile” che cerca di capirlo, ma da sola non può reggere. Così, Francesco si è ritrovato non abbastanza disabile per ricevere risorse, non abbastanza neurotipico per cavarsela da solo.
I genitori hanno chiesto una rivalutazione. “Ma secondo le griglie del DSM, lui è ancora un livello 1. È collaborativo, ha un QI nella norma, parla bene. Solo che… si perde nella folla.” Francesco ha passioni fortissime: il meteo, la cartografia. Ma quando prova a parlarne, viene interrotto. Quando non riesce a reggere il rumore in aula, si chiude in bagno. Nessuno lo accompagna: non ha diritto.
Il DSM-5, nella sua razionalità scientifica, ha lasciato fuori l’aspetto relazionale, affettivo, quotidiano.
Francesco non si autodanneggia. Non urla. Non morde. Ma si spegne. Lentamente. Invisibilmente. Un livello 1, certo. Ma il vuoto che vive, quello, non è mai stato quantificato.
Linda, 9 anni – La bambina trasparente
“Nel DSM c’era scritto tutto, tranne lei.”
Linda ha nove anni, capelli ricci e occhi larghi che sembrano domandare sempre qualcosa. A scuola non crea problemi. Disegna bene, parla poco, ride per le battute che non capisce, ma ride. Così, per anni, è passata liscia. “Timida”, dicevano. “Sensibile”. Poi, un giorno, ha cominciato a non voler più andare in classe. Vomito psicosomatico, insonnia, ansia costante.
Quando è arrivata in neuropsichiatria infantile, si è parlato di possibile spettro autistico femminile, mascheramento, disturbo d’ansia. I genitori si sono sentiti sollevati: finalmente una spiegazione. Ma poi è arrivata l’equipe DSM in mano, e il verdetto: “Non soddisfa tutti i criteri. Non possiamo diagnosticare ASD.”
Nel manuale, le categorie erano chiare. Linda, invece, era tutta nei margini. Funzionava troppo bene per “meritare” la diagnosi, ma troppo male per stare bene. Così è stata etichettata con un generico “disturbo misto dell’emotività”, e rimandata alla psicoterapia privata. Niente PEI, niente supporti a scuola, niente riconoscimento.
Linda disegna solo con il nero. Rifiuta abiti ruvidi. Ha crisi silenziose quando cambia la maestra. Nessuno la “vede”, perché non rientra. Non fa scena. È solo una bambina stanca, che fatica a stare nel mondo.
Il DSM-5 l’ha esclusa per eccesso di rigore. Perché è ancora tarato sul maschile, sull’evidente, sul quantificabile. Linda è tutto ciò che resta fuori: sottile, dissimulato, reale.
Riflessione
Il DSM-5 ha compiuto un enorme passo verso la complessità, ma si porta dietro un paradosso: proprio nella sua volontà di unificare, ha generato nuove invisibilità. Francesco e Linda non hanno sintomi “gravi”, ma vivono un disagio profondo. E il sistema, che dovrebbe includere, spesso si irrigidisce proprio nel nome della classificazione.
La diagnosi, quando c’è, protegge. Quando manca o non basta, può diventare una condanna al vuoto.
Serve un nuovo sguardo, capace di leggere tra le righe. Perché tra i livelli del DSM e le griglie della burocrazia, ci sono persone. E i loro silenzi gridano forte, se sappiamo ascoltare.
®Veronica Socionovo©