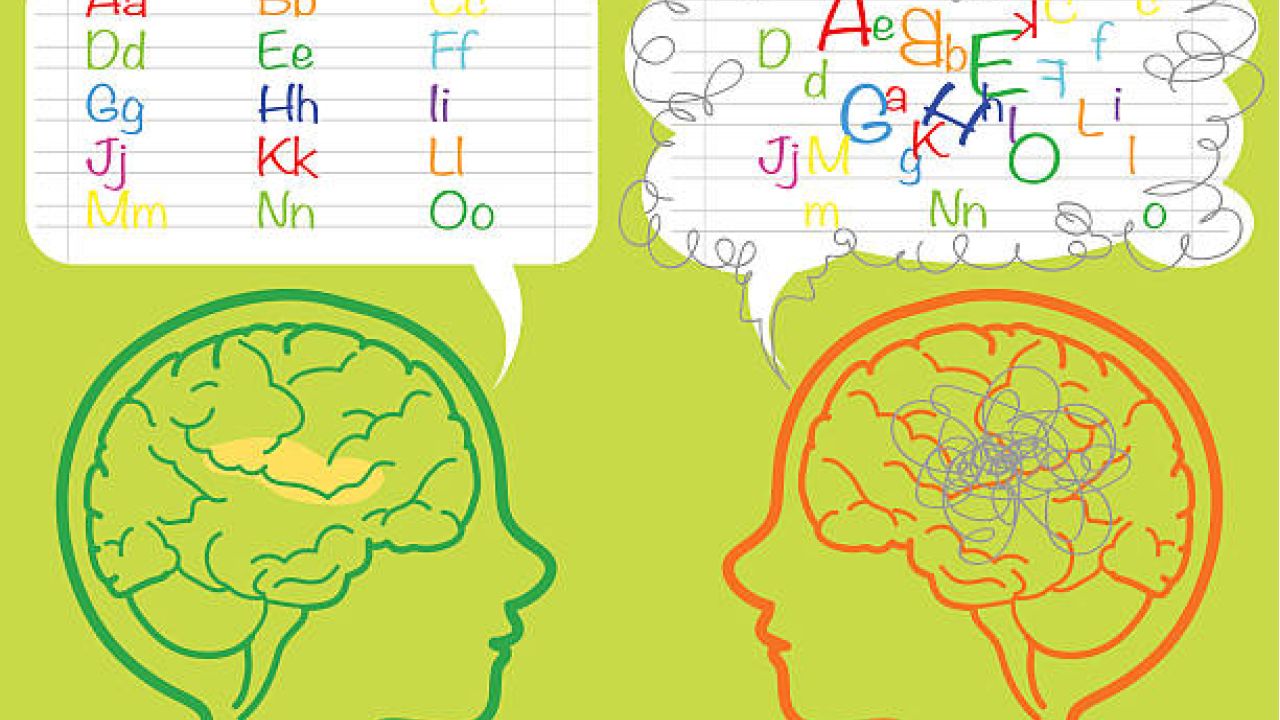
Scolastica e la Legge sui DSA
Scritto da Veronica Socionovo il . Pubblicato in Formazione, Salute e Sanità.
Disturbi Specifici dell’Apprendimento 14
La scuola italiana ha attraversato nel corso degli anni trasformazioni sostanziali per rispondere alle necessità di un numero crescente di studenti che affrontano difficoltà specifiche nell’apprendimento, riconosciute come Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). Questi disturbi, comprendenti la dislessia, la disortografia, la discalculia e la disgrafia, rappresentano condizioni neurobiologiche che non compromettono l’intelligenza generale ma interferiscono con modalità e tempi specifici nell’acquisizione di abilità fondamentali come la lettura, la scrittura e il calcolo. La presa di coscienza di queste difficoltà ha portato, nel tempo, a un articolato sistema normativo volto a tutelare il diritto all’istruzione e all’inclusione di tutti gli studenti, culminato con l’approvazione della Legge 170/2010, punto di svolta nel trattamento scolastico dei DSA.
La Legge 170/2010 si pone come un pilastro fondamentale nel panorama legislativo italiano, riconoscendo ufficialmente i Disturbi Specifici dell’Apprendimento e sancendo il diritto degli studenti a ricevere un percorso formativo adeguato e personalizzato, capace di garantire loro pari opportunità rispetto ai coetanei senza difficoltà. Questo riconoscimento sottolinea come i DSA non siano sinonimo di incapacità o ritardo mentale, ma costituiscano un diverso modo di apprendere, che necessita di adeguati strumenti compensativi e dispensativi per poter essere affrontato con successo.
In particolare, la legge stabilisce che il sistema scolastico deve adottare strategie e strumenti che permettano agli studenti con DSA di partecipare attivamente e proficuamente alle attività didattiche, raggiungendo gli stessi obiettivi previsti per tutti gli altri studenti, senza essere penalizzati per le loro difficoltà specifiche. Questa normativa non si limita ad una semplice indicazione formale, ma promuove un approccio inclusivo e personalizzato, intervenendo su più fronti, dalla diagnosi precoce, alla definizione di percorsi educativi personalizzati, fino alla formazione degli insegnanti.
La diagnosi di DSA rappresenta una fase imprescindibile per l’attivazione delle misure necessarie a garantire un percorso scolastico adeguato. Secondo la Legge 170/2010, questa diagnosi deve essere effettuata da professionisti specializzati, come psicologi, neuropsichiatri infantili o logopedisti, attraverso una valutazione approfondita che tenga conto non solo delle competenze cognitive del bambino, ma anche del contesto familiare e scolastico. L’obiettivo è quello di identificare tempestivamente, idealmente entro il terzo anno della scuola primaria, le difficoltà specifiche di apprendimento, così da poter attivare interventi mirati senza ritardi che potrebbero compromettere l’autostima e il percorso educativo dello studente.
A seguito della diagnosi, viene redatto un documento fondamentale per la personalizzazione del percorso scolastico: il Piano Didattico Personalizzato (PDP). Questo documento, elaborato con la collaborazione della famiglia, degli insegnanti e, se necessario, di altri professionisti, descrive dettagliatamente le difficoltà specifiche dello studente e le strategie didattiche, gli strumenti compensativi e le misure dispensative da adottare. Il PDP è dinamico e flessibile, viene aggiornato nel tempo in base ai progressi dello studente e alle sue esigenze, e rappresenta il fulcro di un intervento realmente centrato sul bambino.
La Legge 170/2010 ha introdotto in maniera strutturale due concetti fondamentali che guidano l’organizzazione del percorso educativo per gli studenti con DSA: le misure compensative e le misure dispensative. Le misure compensative sono strumenti e strategie che aiutano lo studente a superare le difficoltà senza ridurre gli obiettivi di apprendimento. Questi strumenti possono comprendere l’utilizzo di tecnologie digitali come software per la lettura, programmi di sintesi vocale, audiolibri, mappe concettuali, e altre risorse che facilitano la comprensione e la produzione di contenuti scritti o matematici. Inoltre, il supporto di figure specializzate, come insegnanti di sostegno o tutor, rappresenta un’ulteriore misura compensativa volta a favorire un apprendimento più efficace.
Le misure dispensative, invece, rappresentano degli adattamenti che consentono allo studente di non essere obbligato a svolgere attività particolarmente gravose o difficili a causa del suo disturbo, senza che ciò comporti una diminuzione delle aspettative nei suoi confronti. Tra queste misure rientrano, ad esempio, l’esonero dalla lettura ad alta voce in classe, dalla scrittura sotto dettatura o dall’esecuzione di calcoli complessi a mano, lasciando invece spazio all’uso di strumenti compensativi o modalità alternative di verifica. È importante sottolineare come tali misure non significhino un abbassamento degli standard educativi, ma rappresentino un adattamento necessario a garantire l’accesso equo al curriculum scolastico.
L’adozione di misure compensative e dispensative consente di creare un ambiente scolastico realmente inclusivo, in cui ogni studente può esprimere le proprie potenzialità senza essere penalizzato da barriere legate alla propria condizione. Il riconoscimento ufficiale di queste strategie ha rappresentato un importante passo avanti nella tutela dei diritti degli studenti con DSA e nella diffusione di una cultura dell’inclusione.
L’elaborazione e all’attuazione del PDP, la formazione degli insegnanti riveste un ruolo cruciale per garantire l’efficacia degli interventi. La legge prevede che i docenti ricevano una preparazione specifica sui DSA, non limitandosi a una conoscenza teorica, ma approfondendo le tecniche pratiche per riconoscere tempestivamente i segnali di difficoltà, intervenire con metodi didattici adeguati e applicare correttamente le misure compensative e dispensative. La formazione degli insegnanti è indispensabile per superare l’isolamento didattico e culturale che in passato ha spesso accompagnato i disturbi dell’apprendimento, e per promuovere una didattica inclusiva e motivante per tutti gli studenti.
La collaborazione tra scuola, famiglia e operatori specializzati rappresenta un ulteriore elemento imprescindibile per un intervento efficace e integrato. Le famiglie svolgono un ruolo attivo e partecipato, contribuendo alla stesura del PDP e supportando il percorso educativo a casa. L’interazione continua tra docenti e genitori favorisce la condivisione di informazioni e strategie, riduce l’ansia legata alla diagnosi e ai percorsi di apprendimento, e crea un ambiente di sostegno e accoglienza intorno allo studente.
Il quadro normativo e operativo previsto dalla Legge 170/2010 si inserisce in un più ampio contesto di tutela dei diritti e di inclusione sociale. La legge si riallaccia infatti alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, che sancisce il diritto all’educazione inclusiva, e alla Costituzione italiana, che garantisce il diritto all’istruzione per tutti. L’inclusione scolastica, oltre a favorire l’apprendimento, promuove l’integrazione sociale, la valorizzazione delle diversità e la crescita di una comunità educativa accogliente e rispettosa delle differenze.
Nonostante i progressi normativi e culturali, permangono tuttavia numerose criticità e sfide nell’applicazione concreta della Legge 170/2010. Uno degli ostacoli principali riguarda la disponibilità e l’efficacia delle risorse materiali e umane nelle scuole. Spesso, gli istituti scolastici sono carenti di personale specializzato, come insegnanti di sostegno e operatori logopedisti, e mancano gli strumenti tecnologici adeguati per attuare tutte le misure compensative previste. Questo può generare disuguaglianze territoriali e compromette la qualità del supporto offerto agli studenti con DSA.
Altro punto critico è rappresentato dalla formazione degli insegnanti, che in molte realtà risulta ancora insufficiente o non uniforme. La preparazione teorica spesso non si traduce in competenze operative, e la mancanza di aggiornamenti continui può portare a una gestione poco efficace o non aggiornata delle difficoltà di apprendimento. È quindi necessario un investimento costante e capillare nella formazione iniziale e permanente del corpo docente, per far sì che la didattica inclusiva diventi una prassi consolidata e diffusa.
La tempestività della diagnosi è un altro fattore che incide significativamente sul successo del percorso educativo. In alcune situazioni, infatti, le diagnosi di DSA possono subire ritardi a causa di tempi lunghi nelle valutazioni o di difficoltà nell’accesso ai servizi specialistici. Questo rallentamento limita la possibilità di attivare presto le misure compensative e dispensative, con effetti negativi sul rendimento scolastico, sulla motivazione e sull’autostima dello studente.
Anche la redazione e l’aggiornamento del Piano Didattico Personalizzato non sempre vengono curati con la dovuta attenzione. In alcuni casi, il PDP è stilato in modo generico, senza una reale personalizzazione rispetto alle caratteristiche dello studente, o non viene rivisto nel tempo per adattarsi ai suoi progressi o nuove esigenze. Questo può compromettere l’efficacia degli interventi e far sentire lo studente e la famiglia poco supportati.
Per superare queste difficoltà è indispensabile un impegno condiviso e coordinato tra tutti i soggetti coinvolti: scuole, famiglie, istituzioni e professionisti sanitari e educativi. Solo attraverso una collaborazione reale e costante si potrà creare un ambiente scolastico che sia davvero inclusivo, dove ogni studente con DSA possa trovare le condizioni per esprimere le proprie potenzialità e raggiungere il successo formativo.
La Legge 170/2010 ha costituito una svolta epocale nel sistema scolastico italiano, definendo un quadro normativo che riconosce e tutela il diritto all’apprendimento per gli studenti con DSA, promuovendo la personalizzazione della didattica e l’inclusione. Tuttavia, la piena realizzazione degli obiettivi di questa legge richiede un impegno continuo nel migliorare le risorse, nel potenziare la formazione degli insegnanti, nel favorire diagnosi tempestive e nel rendere il Piano Didattico Personalizzato uno strumento realmente efficace e dinamico.
Solo così la scuola potrà davvero trasformarsi in un luogo accogliente e stimolante per tutti, capace di valorizzare le diversità e di garantire il successo educativo di ogni studente, a prescindere dalle difficoltà specifiche di apprendimento. L’attenzione e la cura dedicate agli studenti con DSA diventano allora un indicatore fondamentale della qualità del sistema scolastico e della sua capacità di rispondere ai bisogni reali di una società sempre più inclusiva e attenta ai diritti di tutti.
©Veronica Socionovo


















