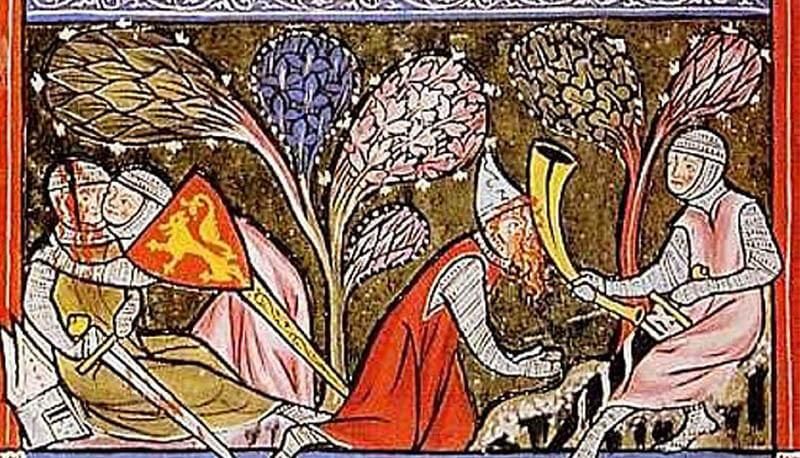“ I RESPONSABILI della SCONFITTA ”:
il libro di Gianfranco Giulivi sulla “Guerra del ’40-’43”
Indagine sui colpevoli del disastro del ’40-’43
e su quelle che erano le possibili alternative
una recensione critica sul testo di FABRIZIO FEDERICI
recentemente presentato presso la Sede dell’UNAR a Roma
Siamo subito e pienamente chiari (come sempre cerchiamo di essere). Apprezziamo molto questo secondo libro di Gianfranco Giulivi, “I responsabili della sconfitta” (Fergen Edizioni), che prosegue onestamente la ricerca sugli effettivi responsabili – militari e politici – della sconfitta italiana del 1940-’43 e su quelle che potevano essere le possibilità alternative per l’Italia nella Seconda guerra mondiale (ricerca iniziata nel 2020, con l’altro saggio “Potevamo vincere! Se solo l’avessimo voluto” (Booksprint).